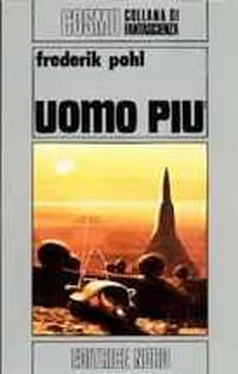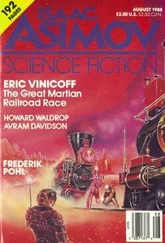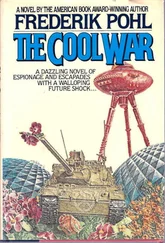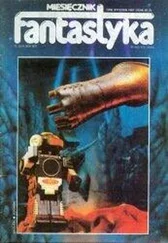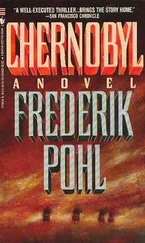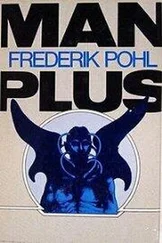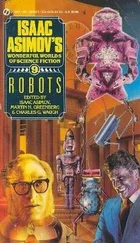Il terzo esaminava le possibilità extraterrestri.
All’inizio sembrava che avessimo mille possibilità tra cui scegliere: ed ognuna delle tre piste principali presentava ramificazioni che parevano promettenti. Una ad una le piste si chiusero. Le nostre stime più esatte — non quelle che passavamo al presidente degli Stati Uniti, ma quelle private che non mostravamo a nessuno, e tenevamo per noi — erano di zero virgola nove e dieci nove probabilità di una guerra termonucleare entro un decennio; e il primo anno chiudemmo il centro per la soluzione delle tensioni internazionali. Creare rifugi sembrava un po’ più semplice. Risultò, dalle analisi più pessimistiche, che alcuni luoghi della Terra difficilmente avrebbero subìto un attacco diretto: l’Antartide, parti del Sahara, persino tratti dell’Australia e un buon numero di isole. Vennero scelte dieci località. Ognuna aveva zero virgola una probabilità, o anche meno, di venire distrutta; tenendo conto di tutte e dieci, le probabilità che venissero distrutte tutte quante erano relativamente insignificanti. Ma un’analisi più attenta mostrò che vi erano due lacune. Innanzi tutto, non potevamo sapere che quantità di isotopi a lungo periodo di dimezzamento sarebbe rimasta nell’atmosfera dopo una guerra del genere, e secondo le indicazioni vi sarebbero stati livelli eccessivi di radiazioni ionizzanti almeno per mille anni. Su di una simile scala temporale, la probabilità che almeno uno dei rifugi sopravvivesse diventava di gran lunga inferiore a zero virgola cinque. Peggio ancora, c’era la necessità dell’investimento dei capitali. Costruire i rifugi sotterranei e riempirli dell’immensa quantità necessaria di complesse attrezzature elettroniche, generatori, riserve di carburante e così via, era in pratica impossibile. Non avevamo modo di procurarci il danaro.
Perciò chiudemmo anche quel centro e dedicammo tutte le risorse di cui potevamo disporre alla colonizzazione extraterrestre. All’inizio, era parsa la soluzione meno promettente.
Ma — quasi! — eravamo riusciti a renderla operante. Quando Roger Torraway toccò il suolo marziano, si completò la prima fase, la più difficile. Quando i veicoli spaziali che lo seguivano avessero raggiunto le rispettive posizioni, in orbita o sulla superficie del pianeta, noi avremmo potuto, per la prima volta, fare i piani per il futuro, dato che ormai la sopravvivenza della razza era assicurata.
Perciò osservammo con grande soddisfazione, mentre Roger uscì sulla superficie del pianeta.
Il computer portatile di Roger era un trionfo dell’ingegneria. Aveva tre sistemi separati, collegati e dotati di risorse comuni, ma con una ridondanza sufficiente, in modo che tutti i sistemi avevano un’attendibilità di almeno zero virgola nove, fino a quando il computer d’appoggio, il 3070, fosse arrivato in orbita. Un sistema mediava le percezioni di Roger. Un altro controllava i subsistemi dei nervi e dei muscoli che gli consentivano di camminare e di muoversi. Il terzo provvedeva alla telemetria di tutti i suoi input. Qualunque cosa lui vedesse, la vedevamo anche noi sulla Terra.
Avevamo dovuto lavorare parecchio per organizzare tutto questo. Secondo la Legge di Shannon non c’era un’ampiezza di banda sufficiente per trasmettere tutto, ma noi avevamo incluso un elemento per la campionatura randomizzata. Veniva trasmesso approssimativamente un bit su cento… prima alla radio del modulo, dove avevamo assegnato permanentemente un canale a quella funzione. Poi veniva ritrasmesso sull’astronave in orbita, dove il generale Hesburgh fluttuava, e guardava la televisione mentre il calcio gli usciva dalle ossa. Da lì, ripulito e amplificato, veniva trasmesso a quel satellite sincrono della Terra che in quel momento si trovava collegato con Marte e Goldstone. Perciò, tutto quello che vedevamo era «reale» solo all’uno per cento. Ma era abbastanza. Il resto veniva integrato per mezzo di un programma di comparazione che avevamo preparato per il ricevitore di Goldstone. Hesburgh vedeva solo una serie di fotogrammi fissi: sulla Terra noi trasmettevamo ciò che sembrava esattamente una ripresa diretta di tutto ciò che Roger vedeva.
Perciò, su tutta la Terra, sui teleschermi di ogni paese, la gente guardò le montagne beige e brune alte sedicimila metri, vide il brillio del sole marziano sui finestrini del modulo, poté addirittura leggere l’espressione di padre Kayman quando si alzò dalla sua preghiera e per la prima volta guardò Marte.
Nel Palazzo di Pechino, i dirigenti della Nuova Asia Popolare interruppero un’importante seduta per guardare il teleschermo. I loro sentimenti erano contrastanti. Quello era il trionfo dell’America, non il loro. Nella Sala Ovale, la gioia del presidente Deshatine era allo stato puro. Il trionfo non era soltanto americano, era suo personale: era identificato, per sempre, come il presidente che aveva reso possibile la colonizzazione umana di Marte. Quasi tutti coloro che assistevano alla trasmissione erano felici… persino Dorrie Torraway, che era nel suo studio, nel retro del negozio, con il mento appoggiato alle mani, e studiava il messaggio degli occhi di suo marito. E naturalmente, nel gran cubo bianco del progetto, alla periferia di Tonka, Oklahoma, quelli dello staff che erano ancora lì guardavano quasi in continuazione le immagini provenienti da Marte.
Ne avevano tutto il tempo. Non avevano molto da fare. Sorprendentemente, l’edificio era sembrato vuoto, da quando Roger se ne era andato.
Erano stati tutti ricompensati, dai magazzinieri in su: un elogio personale per ciascuno da parte del presidente, più una vacanza-premio di trenta giorni e un avanzamento di carriera. Clara Bly approfittò della vacanza per finire la luna di miele rinviata per tanto tempo. Weidner e Freeling trovarono il tempo di redigere un abbozzo del saggio di Brad, trasmettendogliene ogni paragrafo via via che usciva dalle macchine da scrivere, e ricevendo le sue correzioni via Goldstone. Vern Scanyon, naturalmente, fece un giro trionfale insieme al presidente, nei cinquantaquattro stati e nelle città principali di venti paesi stranieri. Brenda Hartnett era apparsa due volte alla televisione, insieme ai figli: erano stati sepolti sotto montagne di doni. La vedova dell’uomo che era morto per mandare Roger Torraway su Marte era ormai milionaria. Avevano avuto tutti la loro ora di gloria, non appena l’astronave era partita e Roger si era messo in rotta, specialmente in quei momenti immediatamente precedenti l’atterraggío.
Poi il mondo guardò Marte con gli occhi di Roger, e con i sensi del fratello fissato sul dorso di Roger, e tutta la loro fama si dileguò. Da quel momento ci fu soltanto Roger.
Anche noi osservavamo.
Vedemmo Brad e Don Kayman, chiusi nelle tute, mentre completavano le procedure prima di uscire. Roger non aveva bisogno di una tuta. Era in punta di piedi sul portello del modulo, librato, e fiutava il vento vuoto; le grandi ali nere sollevate dietro di lui assorbivano i raggi del sole, di una piccolezza ma anche di uno splendore sconcertanti. Per mezzo del pick-up televisivo all’interno del modulo vedemmo Roger profilato contro il beige e il bruno del tagliente orizzonte marziano…
E poi attraverso gli occhi di Roger vedemmo ciò che egli vedeva. Per Roger, che guardava i fulgidi colori gemmei del pianeta su cui doveva vivere, era una terra incantata, bellissima e invitante.
Il modulo aveva abbassato la scaletta al magnesio fino a sfiorare la superficie marziana, ma Roger non ne aveva bisogno. Balzò giù, con le ali svolazzanti — per tenersi in equilibrio, non per sollevarsi — e si posò con leggerezza sulla gessosa superficie arancione, dove il soffio dei retrorazzi aveva spazzato via la crosta. Rimase lì per un momento, scrutando il suo regno con i grandi occhi sfaccettati. — Non essere precipitoso, — consigliò dentro la sua testa una voce che proveniva dalla radio della tuta di Don Kayman. — Meglio seguire l’elenco degli esercizi.
Читать дальше