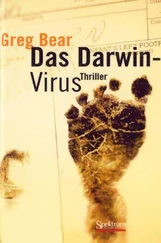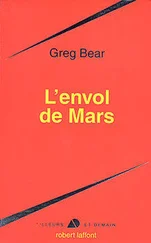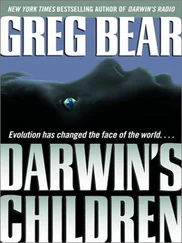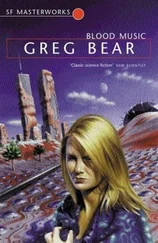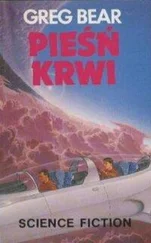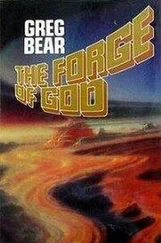— Lascerò perdere. Dove andiamo a cena, stasera?
— Mangiamo un boccone al Moroccan.
— Mentre fanno la danza del ventre. Certo.
Di tutte le cose che non capiva di April, il culmine era rappresentato dalla camera da letto della sua infanzia. Coi giocattoli, il letto, i mobili, i poster alle pareti, la stanza era conservata non com’era quando lui se n’era andato, ma com’era stata quando lui aveva dodici anni. I libri letti a quell’età erano stati tolti dalle scatole in solaio, e allineati sul piccolo scaffale che un tempo era servito per i suoi libri scolastici. Quaderni, romanzi di fantascienza e fumetti convivevano ora coi pochi testi scientifici e di elettronica rimasti in casa.
Manifesti cinematografici — ormai già con un certo valore d’antiquariato — mostravano Robbie il Robot con sottobraccio una Anne Frances di dimensioni molto ingrandite nello scenario irreale di un pianeta alieno; Cristopher Lee con occhi arrossati e sogghignanti canini acuminati; il volto teso e stupefatto di Keir Dullea all’interno del suo elmetto spaziale.
A diciannove anni aveva staccato via tutti quei poster, arrotolandoli sul fondo di un baule. April li aveva tirati fuori dopo che lui era partito per il college.
Aveva anche resuscitato il suo scendiletto coi cacciatori e i cani. Il letto stesso aveva la familiarità delle cose lasciate nel dimenticatoio e lo seduceva col sapore di una fanciullezza che non era certo d’aver mai avuto veramente.
Ricordava gli anni della sua prima adolescenza come un’epoca di continue paure e angosce. Paure d’essere una specie di anormale, e d’essere stato in qualche modo responsabile della fuga di suo padre; angoscia per l’obbligo di doversi misurare con gli altri a scuola. E, misti a quei timori, momenti di esaltazione. L’euforia e la meraviglia che aveva provato nell’arrotolare una striscia di carta, unendone le estremità a formare il suo primo nastro di Moebius; il suo formicaio nella cassetta di vetro, le eliche a moto perpetuo mosse dal calore; il giorno in cui aveva trovato tutti i fascicoli degli ultimi dieci anni di Scientific Americans accanto a un bidone di rifiuti in una strada dietro casa sua.
Nella penombra della stanza, già mezzo addormentato, sentì una fitta alla colonna vertebrale. Si massaggiò la schiena distrattamente, poi con un’imprecazione si tirò a sedere sul letto e continuò a massaggiarsi con ambo le mani attraverso il pigiama, dall’alto in basso, nel tentativo di lenire il dolore.
Si portò le dita alla faccia e la tastò. La sentiva del tutto sconosciuta, la faccia di qualcun altro: zigomi estranei, guance misteriose, naso e labbra troppo sporgenti. Ma quando provò con l’altra mano la sentì normale. Unì le dita di entrambe le mani. La sensazione aveva qualcosa di sbagliato. Una mano era molto più sensibile del solito, l’altra quasi anestetizzata.
Col fiato mozzo e accelerato Vergil scese dal letto, attraversò il pianerottolo in cima alle scale e accese la luce nel bagno. Un dolore insopportabile gli attanagliava il torace. Dai piedi alle ginocchia gli correvano fremiti simili a miriadi di morsi di formiche. Non s’era mai sentito così male da quando aveva avuto la varicella, a dieci anni, un mese prima che suo padre se ne andasse. Tremante e quasi incapace di pensare si strappò via di dosso il pigiama e aprì la doccia, sperando di trovare sollievo sotto il getto d’acqua fredda.
La vecchia doccia sputacchiava stanchi rivoli d’acqua che gli scendevano lungo la testa e il collo, le spalle e la schiena, suddividendosi in filamenti giù per l’addome e le gambe. Entrambe le mani era adesso deliziosamente, dolorosamente sensibili, e l’acqua svegliava in esse centinaia di punture d’ago, calde e fredde, roventi e gelide. Allargò le braccia in fuori e gli parve di afferrare l’aria stessa come un oggetto solido pieno di protuberanze.
Per quindici minuti rimase sotto la doccia, ansimando di sollievo mentre il dolore calava, sfregandosi le zone ipersensibili della pelle coi polsi e il dorso delle mani fino a lasciarsi chiazze di forte rossore. Le mani cominciarono a formicolargli, poi quella sensazione si smorzò nel pulsare del sangue che tornava a circolare normalmente.
Chiuse il rubinetto e si asciugò, quindi si appoggiò al davanzale della finestra, nudo, lasciandosi investire dalla corrente d’aria fresca e ascoltando il frinire dei grilli. — Oh, Cristo! — sussurrò con enfasi. Si girò a esaminarsi nello specchio del bagno. Sul petto aveva numerose chiazze rosse lasciate dalla violenza con cui s’era grattato. Da sopra una spalla si osservò la schiena.
Da una scapola all’altra in un intreccio che gli scendeva lungo la colonna vertebrale vide una quantità di strisce pallide simili a una mappa stradale, proprio sotto la superficie dell’epidermide. Intanto che cercava di esaminarle meglio svanirono lentamente finché, confuso, fu costretto a chiedersi se le avesse viste davvero.
Col cuore che continuava a pulsargli forte Vergil sedette sulla tazza del gabinetto e appoggiò il mento sulle mani, fissandosi i piedi scalzi. Adesso che riusciva a pensare si sentiva spaventato.
Riuscì ad emettere una risata rauca, amara.
— Hai messo quei pargoletti al lavoro, mh? — chiese a se stesso in un sussurro.
— Vergil, ti senti bene? — chiese sua madre dall’altra parte della porta del bagno.
— Sì, sto bene — rispose lui. Bene e sempre meglio, ogni giorno.
— Non capirò mai gli uomini finché avrò vita e respiro — disse sua madre, versandosi un’altra tazza di caffè nero. — Sempre ad almanaccare qualcosa, sempre a cacciarsi nei guai.
— Io non sono nei guai, mamma. — Quelle parole non suonarono convincenti neppure a lui.
— No?
Scrollò le spalle. — Godo di buona salute, posso permettermi di stare alcuni mesi senza lavoro… e qualcosa dovrà pur succedere.
— Finora non ne hai neppure la speranza.
Questo era abbastanza vero. — Devo superare un po’ di depressione — disse, ed era un’aperta menzogna.
— Balle — replicò April. — Tu non sei mai stato depresso in vita tua. Non sai neppure cosa significa. Dovresti provare a essere una donna per qualche anno, e poi me lo sapresti dire.
Il sole mattutino indorava le sottili tende della finestra e riempiva la cucina di un piacevole tepore. — Qualche volta ti comporti come se io fosse un muro di mattoni — brontolò Vergil.
— Qualche volta lo sei. Santo cielo, Verge, sei mio figlio. Ti ho dato io la vita (penso che si possa sorvolare sul contributo di Frank) e ti ho allevato fino all’età di ventidue anni. Ma non sei mai cresciuto, almeno per quel che riguarda la tua sensibilità emotiva. Sei un ragazzo brillante, però non sei del tutto completo.
— E tu — sogghignò lui, — sei un pozzo di saggezza e di comprensione.
— Non punzecchiare chi è più anziano di te, Vergil. Io ti capisco e ti sono accanto più di quanto meriti. Ora sei in un grosso guaio, non è vero? Questo esperimento.
— Vorrei che tu non battessi su questo tasto, sul fatto che io sono lo scienziato e che mi sono iniettato qualcosa e così via… — Chiuse la bocca con una smorfia e intrecciò le braccia sul petto. Tutto cominciava ad apparirgli più spiacevole che mai. I linfociti che s’era iniettato erano senza dubbio ormai morti o decrepiti. Nelle provette avevano subito profonde mutazioni, probabilmente avevano acquisito un’incompetibilità con gli altri anticorpi e già da qualche settimana erano stati attaccati e divorati dai loro immutati ex fratelli. E ogni altra supposizione, semplicemente, non era suffragata da prove. La notte prima lui non aveva avuto altro che una complessa reazione allergica. Perché doveva mettersi a discutere proprio con sua madre la possibilità che…
— Verge?
Читать дальше