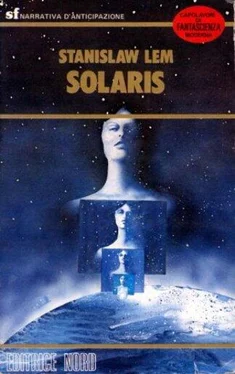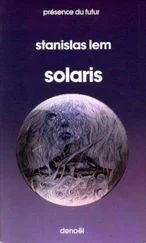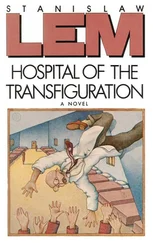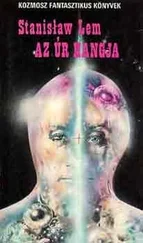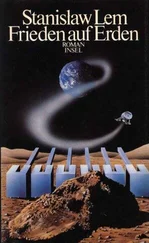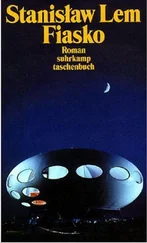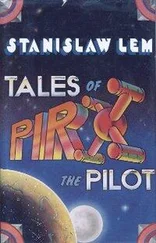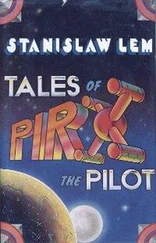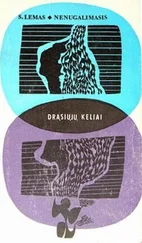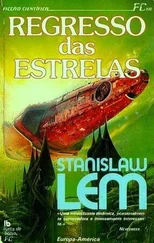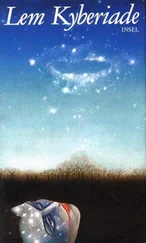La mediocrità e il genio rimanevano del pari interdetti di fronte alle metamorfosi di Solaris, cosa che non facilitava i rapporti con i fenomeni dell’oceano vivente. Giese non era appartenuto né all’una né all’altra categoria. Era semplicemente un classificatore pedante, della schiera di coloro che nella dedizione incondizionata e accanita al lavoro trovano rifugio dalle vicissitudini della vita. Usava, fin dove poteva, un linguaggio descrittivo abbastanza comune; ma quando gli mancavano le parole ne creava di nuove, non sempre con mano felice. Bisogna riconoscere, però, che non esistevano definizioni, per ciò che accade su Solaris. I suoi « montalberi », i suoi « longhi », « perfunghi », « mimoidi », « simmetriadi », « asimmetriadi », « vertebroidi » e « agilanti » suonano artificiosi, ma davano un’idea di Solaris a chi l’aveva visto soltanto in film o in fotografie di scarsa precisione.
Questo ricercatore, per quanto scrupoloso, commise tuttavia qualche imprudenza. L’uomo è spinto suo malgrado a fare ipotesi, anche quando sta molto attento. Giese aveva considerato i « longhi » come tipo fondamentale delle formazioni, assimilandoli alle ondemarea dei mari terrestri, però molto più grandi e accavallati.
Chi aveva letto la prima edizione delle sue opere sapeva che Giese aveva inizialmente chiamato appunto « maree » queste formazioni, ispirato da un geocentrismo che farebbe sorridere se non tradisse l’imbarazzo dello studioso. In realtà queste formazioni, che superano per grandezza, se si vogliono proprio stabilire dei paragoni con la Terra, il Grand Canyon del Colorado, sono modellate in una massa di materia che esternamente ha una consistenza gelatinosa schiumosa (che nel corso di quella fantastica lavorazione si coagula in blocchi facilmente sgretolabili, in trine traforate e inamidate, inducendo certi studiosi a parlare di «escrescenze scheletriche»), mentre all’interno la sostanza diventa via via più compatta, come un muscolo teso, e infine, a una profondità di una quindicina di metri, è dura come la pietra pur conservando l’elasticità. Fra le pareti simili alle ali membranose e tese di un mostro, alle quali si agganciano le escrescenze scheletriche, il longo si stende per chilometri, simile a un gigantesco pitone che ha divorato montagne e che le digerisce in silenzio, col corpo percorso ogni tanto da lente contrazioni.
Ma solo dall’alto, da un apparecchio in volo, il longo appare così. Se si scende, quando le due «pareti del burrone» si innalzano per centinaia di metri al di sopra del velivolo, ci si accorge che il « corpo del pitone », quel cilindro gonfiato che si estende fino all’orizzonte, è animato da un moto vertiginoso. Si osserva per prima cosa il movimento ininterrotto di rotazione di una specie di mota scivolosa grigioverdastra che riflette con violenza la luce solare; ma quando l’apparecchio scende ancora fino a sfiorare la «schiena del pitone», quando le creste del «burrone» in cui si cela il longo appaiono come il ciglio di faglie geologiche, ci si accorge allora che i movimenti sono molto più complessi, esiste una circolazione mediana con dei rivoli scuri, e a volte il «manto» esterno è lucido come uno specchio che riflette il cielo e le nuvole, a volte è perforato da eruzioni di gas provenienti dall’interno semiliquido. A poco a poco diventa evidente che è in funzione lì sotto il centro di forze che divarica e che solleva verso l’alto i due versanti gelatinosi che lentamente cristallizzano.
Ma ciò che era ovvio per l’occhio, non poteva essere accettato senza prove dalla scienza. Per quanti anni si è discusso su che cosa succedeva ai margini dei longhi che a milioni solcano la superficie dell’oceano vivo! Si pensava che fossero organi mostruosi nei quali avvenivano processi di respirazione o il trasporto di materie nutritive: solo la polvere delle biblioteche sa tutto quel che si è detto in proposito. Esperienze laboriose e talvolta pericolose hanno a mano a mano eliminato queste ipotesi. Oggi si parla solo di longhi, formazioni, in fondo, semplici e relativamente stabili, poiché la loro esistenza si conta a settimane: cosa, questa, quasi eccezionale.
Più complicati, e capricciosi nella forma, sono i mimoidi.
Non si esagera dicendo che Giese si era dedicato a questi con un vero amore, studiandoli, descrivendoli e impegnandosi fino all’ultimo per indovinarne l’origine. Con quel nome riuscì a rendere l’idea di ciò che in essi risulta più caratteristico per l’uomo: una certa predisposizione a imitare le forme circostanti, vicine o lontane.
Un giorno, nelle profondità dell’oceano, una macchia circolare comincia a scurirsi, come se si ricoprisse di catrame.
Dopo alcune ore si divide in strati e contemporaneamente sale verso la superficie. L’osservatore giurerebbe che si stia svolgendo una lotta violenta, poiché intorno, da ogni direzione, giungono come delle labbra chiuse, vive e muscolose, simili a crateri od onde circolari, che si uniscono, s’innalzano e ricadono. Ogni caduta di una di quelle masse, del peso di centinaia di tonnellate, è accompagnata da un boato, poiché tutto avviene su scala infinitamente grande. L’immensa massa scura è spinta verso il basso, ogni colpo successivo sembra appiattirla e scioglierla; dai singoli strati, che pendono come ali bagnate, si stacca una sorta di grappoli, che poi prendono la forma di collane e che, snodandosi, si riuniscono e scorrono verso l’alto, mentre dalle zone superiori cadono in cerchio, senza tregua, i successivi anelli d’onda.
Questo gioco dura a volte giorni, a volte mesi e a volte non ha alcun seguito. Lo scrupoloso Giese chiamò questa variante « mimoide iniziale »; non si sa da dove avesse attinto la certezza che lo scopo finale di ogni cataclisma fosse il « mimoide maturo »; ciò significava una colonia di polipi con pelle scura (di solito più grandi di una città) il cui fine era l’imitazione delle forme esterne…
Naturalmente non mancò un altro solarista, di nome Uyvens, che chiamò l’ultima fase «degenerata», cioè un decadimento, una necrosi, e la selva di forme nascenti un visibile indizio di rottura col rigoglio di potenza della matrice originaria.
Giese comunque, come in tutte le sue descrizioni delle creazioni di Solaris, si comportava come una formica, che per nessun motivo cambia il ritmo del passo, e catalogava in bell’ordine ogni fase di apparizione di mimoide secondo il grado di perfezione raggiunta.
Visto dall’alto il mimoide appare simile a una città, ma ciò è frutto d’immaginazione, provocato dalla ricerca di una qualsiasi analogia con ciò che si conosce. Quando il cielo è limpido, tutte le forme stratificate e le loro palizzate sono circondate da una massa d’aria riscaldata, che provoca un ondeggiamento e un tremolio di forme difficili da definire. La prima nube che attraversa l’azzurro (parlo d’azzurro per pura abitudine, dato che qui l’azzurro, il cielo, è color rosso ruggine oppure terribilmente bianco durante il giorno del sole azzurro) sembra costituire un richiamo. Il tegumento elastico comincia di colpo a crescere, staccandosi dalla base e impallidendo, e in capo a pochi minuti imita perfettamente la nube. Questo «oggetto» immenso manda un’ombra rossa e certi pinnacoli del mimoide si piegano, con un movimento che va sempre in direzione opposta a quello della nube vera.
Penso che Giese sarebbe stato pronto a tutto, pur di capire questo fenomeno. E queste creazioni «singole» del mimoide erano ancora una bazzecola a confronto dell’attività travolgente cui era «stimolato» in presenza degli oggetti e forme di provenienza terrestre che gli si presentavano. La riproduzione di forme esterne coinvolgeva tutto ciò che si trovava in un raggio di una quindicina di chilometri. Spesso i mimoidi fornivano riproduzioni ingrandite o deformate, spesso davano luogo a caricature grottesche, soprattutto quando si trattava di macchine.
Читать дальше