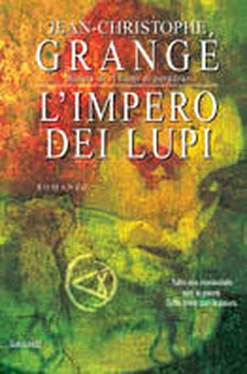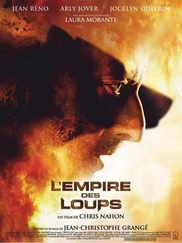«È caduta?»
«No. Credo di avere una nevralgia facciale. Non so.»
«O semplicemente una sinusite», disse lui strizzando l’occhio, «in questo periodo ce ne sono un sacco.»
Gettò uno sguardo alla sala e ai suoi pensionanti: il rasato, l’ubriacone, la nonnetta… La solita truppa. Sospirò; a un tratto sembrava disposto a concedersi una piccola tregua in compagnia di Anna.
La gratificò di un ampio sorriso, modello Costa Azzurra, e, con voce calda, sussurrò:
«Adesso la passiamo allo scanner, miss. Una panoramica. Ma prima», disse prendendo la manica strappata, «bendaggio.»
Un’ora dopo Anna era sotto la galleria di pietra che costeggiava i giardini dell’ospedale; il dottore le aveva permesso di attendere là i risultati dell’esame.
Il tempo era cambiato, dardi di sole si diluivano nella pioggia, trasformandola in bruma d’argento dal chiarore irreale. Anna osservava con attenzione il rimbalzare delle gocce d’acqua sulle foglie degli alberi, le pozzanghere scintillanti, i sottili ruscelli che si disegnavano tra la ghiaia e tra le radici nei boschetti. Quel piccolo gioco le permetteva di mantenere ancora il vuoto nella mente e di dominare il panico latente. Niente domande. Non ancora.
Alla sua destra sentì uno scalpiccio di zoccoli. Seguendo i portici della galleria, il medico stava arrivando, con le radiografie in mano. Non sorrideva più, per nulla.
«Avrebbe dovuto parlarmi del suo incidente.»
Anna si alzò.
«Il mio incidente?»
«Cosa le è successo? Roba di macchina, no?»
Lei indietreggiò spaventata. L’uomo scosse la testa incredulo:
«È pazzesco quello che riescono a fare oggi con la chirurgia plastica. Vedendola, non l’avrei mai immaginato…»
Anna gli strappò le lastre dalle mani.
L’immagine mostrava un cranio fessurato, suturato, reincollato in tutti i sensi. C’erano linee nere che rivelavano degli innesti all’altezza della fronte e degli zigomi. Delle fratture intorno all’orifizio nasale tradivano un rifacimento completo del naso, mentre alcune viti agli angoli delle mandibole e delle tempie tenevano ferme delle protesi.
Anna scoppiò in una risata spezzata, in una risata che era un singhiozzo; poi fuggì lungo il portico.
La radiografia sventolava nella sua mano come una fiamma blu.
Da due giorni percorrevano in lungo e in largo il quartiere turco.
Paul Nerteaux non capiva la strategia di Schiffer. Già dalla domenica sera avrebbero dovuto fare irruzione da Marek Cesiuz, alias Marius, responsabile dell’Iskele, la principale rete di immigrazione clandestina turca. Avrebbero dovuto scrollare il negriero fino a fargli tirare fuori i documenti d’identità delle tre vittime.
E invece, il Cifra aveva voluto riallacciare i rapporti con il «suo» quartiere; aveva voluto — diceva lui — ritrovare le sue tracce. Da due giorni, fiutava, sfiorava, osservava il suo vecchio territorio, senza interrogare nessuno. Solo la pioggia battente aveva permesso loro di rimanere invisibili in macchina, di vedere senza essere visti.
Paul mordeva il freno, ma doveva ammettere che in quarantotto ore aveva imparato sulla Piccola Turchia più di quanto avesse fatto in tre mesi di indagini.
Jean-Louis Schiffer gli aveva da prima mostrato gli annessi disseminati qua e là. Erano andati nel passage Brady, in boulevard de Strasbourg, nel cuore del mondo indiano. Sotto una lunga tettoia vetrata si allineavano botteghe minuscole ed eterogenee e ristoranti oscuri, tappezzati di paraventi; i camerieri imbonivano i passanti, mentre le donne in sari lasciavano la parola al loro ombelico, tra potenti sentori di spezie. Con quel tempo piovoso, quando i rovesci si facevano più intensi esaltando ogni profumo, si sarebbe potuto credere di essere a Bombay in pieno monsone.
Schiffer gli aveva fatto vedere i negozietti che servivano da punto d’incontro agli indi, ai bengalesi, ai pakistani. Gli aveva indicato i capi delle varie confessioni: induisti, musulmani, giainisti, sik, buddisti… In poche parole, gli aveva spiegato in dettaglio quel concentrato di esotismo che, secondo lui, non chiedeva altro se non di diluirsi.
«Tra qualche anno», aveva aggiunto, «saranno i sik a fare il traffico nel decimo arrondissement.»
Poi si erano appostati in rue du Faubourg-Saint-Martin, di fronte ai negozi dei cinesi. Drogherie che sembravano caverne, sature d’odori d’aglio e di zenzero; ristoranti con le tende tirate che si socchiudevano come scrigni di velluto; rosticcerie scintillanti di vetrine e di banconi cromati, colorate da insalate e da frittelle rosolate. Schiffer gli aveva presentato a distanza i principali responsabili della comunità: negozianti per i quali la bottega non rappresentava che il cinque percento della loro vera attività.
«Mai fidarsi di questi stronzi», aveva ringhiato. «Non ce n’è uno che righi diritto. La loro testa è come quella schifezza che mangiano. Piena zeppa di roba tagliata in quattro. Riempita di glutammato per addormentarti il cervello.»
Più tardi ancora, erano tornati sul boulevard de Strasbourg, dove i parrucchieri antillesi e africani contendevano il marciapiede ai grossisti di prodotti cosmetici e ai venditori di oggetti per fare scherzi. Sotto le tettoie dei negozi, gruppi di neri che si riparavano dalla pioggia offrivano un perfetto caleidoscopio delle etnie che bazzicavano per il boulevard. I baoulé, i mbochis e i bete della Costa d’Avorio, i ba congos e i baluba dell’ex Zaire, i bameleke e gli ewondo del Camerun…
Paul era intrigato da quegli africani, sempre presenti e oziosi. Sapeva che la maggior parte di loro erano trafficanti o imbroglioni, ma non poteva impedirsi una certa tenerezza al loro riguardo. La loro leggerezza di spirito, il loro umorismo, quella vita tropicale che imponevano persino all’asfalto lo esaltavano. Erano soprattutto le donne ad affascinarlo. I loro sguardi lisci e neri sembravano avere una complicità misteriosa con i loro capelli lucenti, appena stirati da Afro 2000 o da Royal Coiffure. Delle fate di legno bruciato, delle maschere di raso dagli occhi scuri…
Schiffer gli aveva servito una descrizione più realistica e circostanziata:
«I camerunensi sono i re del falso, banconote, carte di credito. I congolesi lavorano nel campo della roba da vestire: abiti rubati, marchi contraffatti e così via. Quelli della Costa d’Avorio sono specializzati in false organizzazioni benefiche. Trovano sempre il modo di spillare quattrini per gli affamati dell’Etiopia o per gli orfani dell’Angola. Bell’esempio di solidarietà. Ma i più pericolosi sono quelli dello Zaire. Il loro impero è la droga. Regnano su tutto il quartiere. I Blacks sono i peggiori», aveva concluso. «Puri parassiti. Hanno una sola ragione di vita: succhiarci il sangue.»
Paul non replicava a nessuna di quelle riflessioni razziste. Aveva deciso di chiudersi a tutto ciò che non riguardava direttamente l’inchiesta. Mirava solo ai risultati e metteva da parte ogni altra considerazione. D’altronde, continuava ad avanzare con discrezione anche su altri fronti. Aveva incaricato due ispettori della giudiziaria, Naubrel e Matkowska, di seguire la pista delle camere iperbariche. I due avevano già visitato tre ospedali, ma avevano ottenuto solo risposte negative. Ora stavano indagando nell’ambiente di quelli che, a Parigi, lavoravano nelle profondità della terra, in ambienti ad alta pressione, per impedire che la falda freatica inondasse i cantieri. Ogni sera, quegli operai utilizzavano camere di decompressione. Le tenebre, i sotterranei… Paul la sentiva, quella pista. Attendeva un rapporto in giornata.
Inoltre, aveva incaricato un ragazzo della Brigata anticrimine di raccogliere altre guide e altri cataloghi archeologici sulla Turchia. La sera prima, il giovane poliziotto gli aveva fatto una prima consegna a casa sua, in rue du Chemin-Vert, nell’undicesimo arrondissement. Un plico che non aveva ancora avuto il tempo di esaminare, ma che ben presto avrebbe popolato le sue insonnie.
Читать дальше