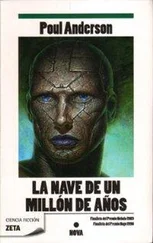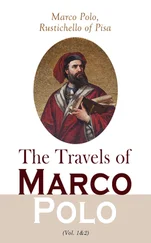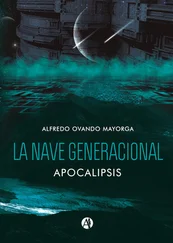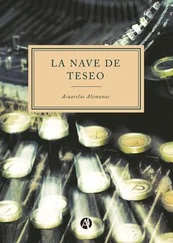Piacenza, castello dei conti di Valnure, 1337
La più grave tra le contusioni che Diletta aveva riportato nel corso della caduta si era rivelata una frattura al braccio che adesso, dopo venti giorni di immobilità, sembrava ormai in via di guarigione.
Durante il periodo trascorso come ospiti nel castello degli avi di Lorenzo, il Muqatil e la giovane avevano sperimentato per la prima volta i piaceri di una tranquilla esistenza familiare.
«Riusciremo mai a vivere senza lo spettro della paura?» chiese Diletta guardando negli occhi l’uomo che amava.
«Amministrare la città di Tabarqa non si concilia con le scorrerie in mare. Credo che avremo tempo per stare insieme, da oggi in poi, Diletta. Sempre ammesso che i nemici ce lo concedano», rispose il Muqatil. «La nave di un mercante a noi fedele dovrebbe salpare dal piccolo porto di Livorno tra una quindicina di giorni. Cerca di ristabilirti per quella data: dovremo affrontare il lungo viaggio sino alla nostra città.»
«Non preoccuparti per me, mi sento già molto meglio, e del resto ho cavalcato ferita senza lamentarmi mai durante tutta la nostra fuga da Venezia.»
L’atmosfera che si respirava all’interno delle carceri di Venezia era spettrale. La luce di una torcia illuminò lo sguardo inquietante di Hito Humarawa.
«L’unico che siamo riusciti a catturare si rifiuta di parlare, signore», disse un ufficiale del doge rivolto al giapponese.
«Conosco molti modi per convincere un uomo a parlare.» Una smorfia simile a un sorriso passò per un istante sulle labbra sottili del samurai.
Dario, uno dei fedelissimi che, al fianco del Muqatil, avevano preso parte alla liberazione di Diletta, era stato catturato nel corso dell’ultimo scontro.
Adesso giaceva con il capo reclinato e le braccia verso l’alto, assicurate al muro umido della cella da due pesanti anelli di legno.
I suoi occhi si alzarono, osservando Hito Humarawa che ordinava ai carcerieri di richiudere la porta alle sue spalle.
Diverse ore più tardi, il giapponese varcava a ritroso la porta della cella. Aveva un’espressione soddisfatta dipinta in volto. Dietro di lui lasciava il corpo di Dario ridotto a un sanguinolento ammasso di carni dalle quali la vita, dopo indescrivibili torture, stava ormai fuggendo.
Febbraio 2002
«Così sarebbe questo il trattamento che Funet ci ha riservato», commentò Sara Terracini, parlando in modo da superare il rumore dello scroscio dell’acqua, che le era già arrivata al torace.
«Probabilmente troveranno i nostri corpi a galleggiare nei pressi del relitto del C’est Dommage », continuò Grandi, senza tradire la minima paura.
«Proviamo a vedere se riusciamo a guastare la festa al nostro amico francese e ai suoi datori di lavoro», disse Henry, immergendosi nei pressi della porta stagna, subito imitato da Etienne Jalard.
‹HO DEGLI OTTIMI CONTATTI PERSONALI CON ALCUNI UFFICIALI DEL NUCLEO TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO›, Stava scrivendo Toni Marradesi, in linea con Oswald Breil. ‹NON CREDO MI SARÀ DIFFICILE OTTENERE CHE TRASMETTANO UNA RICHIESTA DI INFORMATIVA ALLA POLIZIA GIAPPONESE. SONO PREOCCUPATO PER SARA, DOTTOR BREIL.›
‹LO SONO ANCH’IO, TONI. SONO ORMAI SETTE GIORNI CHE NON ABBIAMO NESSUNA NOTIZIA. MA CREDO CHE QUELLA CHE HO INTRAPRESO SIA LA VIA GIUSTA PER SALVARLE LA VITA. DOBBIAMO AGIRE CON LA MASSIMA DISCREZIONE E RAPIDITÀ›, rispose Oswald.
‹MI METTO IMMEDIATAMENTE IN MOTO. TRA POCHE ORE L’ISPETTORE GIAPPONESE CHE MI HA INDICATO AVRÀ SULLA SCRIVANIA LA RICHIESTA DI INDAGINI PROVENIENTE DALLE AUTORITÀ ITALIANE.›
Una volta lasciato Marradesi ai suoi compiti, Breil si affrettò a contattare il capitano Bernstein: in un messaggio che gli era appena giunto, il custode delle informazioni elettroniche del Mossad lo sollecitava a mettersi in comunicazione con lui con la massima urgenza e con qualsiasi mezzo.
La piattaforma sporgeva per circa tre metri dalla fiancata dello Shimakaze. Un meccanismo elettrico consentiva di ritrarre con un movimento alare la parte di paratia che scendeva sino a una cinquantina di centimetri dal pelo dell’acqua e che veniva utilizzata come imbarcadero. Due grossi gommoni, usati in qualità di barche appoggio dai sub, erano legati alle bitte della piattaforma.
I due uomini che montavano la guardia all’accesso passeggiavano sullo spazio ristretto, parlottando tra loro in giapponese. Due colpi precisi, esplosi dalle armi dotate di silenziatore del misterioso commando, li centrarono in piena fronte, facendo sì che le due sentinelle si accasciassero senza un lamento. I sei uomini salirono con agilità sulla piattaforma, dopo aver abbandonato in mare le ormai inutili attrezzature subacquee.
«Non c’è modo di uscire», disse Vittard, riemergendo per l’ennesima volta. L’acqua era salita sino a una trentina di centimetri dal soffitto della cabina.
I quattro prigionieri erano stremati e, con le poche forze rimaste, annaspavano tentando di tenere la testa rivolta verso la sacca d’aria che stava diventando sempre più ridotta. Ancora pochi minuti e poi sarebbero andati incontro a una morte orribile.
I sei subacquei si muovevano con destrezza nei corridoi deserti dello Shimakaze. I visori notturni che montavano sul capo li rendevano simili a un manipolo di alieni. Individuare la prigione non fu eccessivamente difficile: c’era un carceriere seduto su una sedia a guardia di una porta. Ancora una volta una pistola emise il suo soffocato rumore di morte e il membro dell’equipaggio rimase seduto, con un’ultima espressione incredula dipinta sul volto.
Uno dei sei uomini mise mano al chiavistello, girò il volantino che assicurava la chiusura stagna della porta e un getto d’acqua lo investì con violenza, proiettandolo contro il muro prospiciente.
L’acqua defluì dalla cella in poco meno di un minuto e, quando raggiunse un’altezza di cinque centimetri all’interno del corridoio, gli allarmi della nave presero a suonare.
Vittard osservò il viso di Sara Terracini: la giovane stava affrontando la morte con coraggio. Il soffitto della cabina era ormai a pochi centimetri dalla sua bocca. L’aria cominciava a scarseggiare. Alla mente di Henry riaffiorò il ricordo di Sylvie e il modo in cui lui l’aveva vista morire.
Vittard avrebbe voluto dire molte cose a Sara, ma l’acqua gli penetrò tra le labbra. Sara prese fiato nell’ultima bolla d’aria rimasta, lesse la disperazione nello sguardo di Vittard, poi l’acqua la sommerse.
Jalard si ritrovò a pregare Dio: quello era un modo stupido per morire. Specialmente per un agente del Mossad che già tante volte aveva rischiato la vita riuscendo sempre a salvarsi.
Guglielmo Grandi forse immaginava che la vita di un marinaio dovesse terminare in mare. Ma mai avrebbe pensato di dover morire affogato all’interno della cabina di una nave. Gli sembrava quasi una beffa.
Sara sentì i polmoni che stavano per scoppiarle. Per istinto di sopravvivenza diede un colpo di reni verso l’alto.
Quando si rese conto che la sua testa era emersa e che il livello stava velocemente abbassandosi, non volle credere al miracolo.
Pochi istanti più tardi, tutti e quattro annaspavano tra le suppellettili galleggianti della loro prigione. I loro corpi vennero risucchiati nell’apertura della porta. Le mani forti di alcuni uomini li aiutarono a rimettersi in piedi, all’interno del corridoio.
«Presto, dobbiamo andarcene immediatamente da qui!» ordinò uno degli uomini del misterioso commando. La sirena d’allarme ululava e in breve tempo si sarebbero trovati addosso l’intero equipaggio della nave.
La «Sezione 8200» svolgeva la funzione di inviolabile scrigno in cui erano custodite tutte le informazioni del Mossad. Un secondo e non meno importante compito del dipartimento, che aveva a capo il capitano Bernstein, era quello di rendere disponibili tali informazioni agli agenti israeliani sparsi per il mondo e di garantire le comunicazioni con sofisticate apparecchiature elettroniche.
Читать дальше