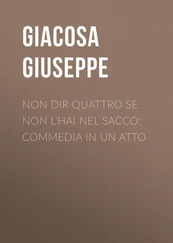La donna scosse il capo per allontanarsi i capelli dagli occhi e sollevò lo sguardo su di me. E io tornai con la memoria ai tempi della scuola, quell’edificio di mattoni lontano non più di un paio di centinaia di metri dal punto in cui ci trovavamo. Ora forse ciò che era successo cominciava ad avere una sua logica. La donna misteriosa se n’era stata davanti alla casa in cui un tempo aveva abitato.
Era Dina Levinsky la donna misteriosa.
Andammo a sederci al tavolo della cucina. Preparai il tè, una miscela Tazo di tè verde cinese che avevo comprato da Starbucks, avrebbe dovuto rilassarci. Vai a sapere. Porsi a Dina una tazza.
«Grazie, Marc.»
La conoscevo da sempre, Dina. La conoscevo come soltanto un ragazzino può conoscere un altro ragazzino, come si conoscono i compagni di scuola delle elementari anche se, e qui vi prego di credermi, penso proprio che non ci siamo mai rivolti la parola.
Ognuno ha una Dina Levinsky nel suo passato. Era la vittima della nostra classe, la bambina così emarginata, derisa e maltrattata da chiedersi come avesse fatto a rimanere sana di mente. Io non l’avevo mai presa di mira, ma ero rimasto tante volte a guardare mentre altri le facevano degli scherzi. E anche se non avessi abitato nella casa dov’era vissuta lei da bambina, Dina Levinsky sarebbe sempre vissuta dentro di me. Vive anche dentro di voi. Rispondete subito: chi era il bambino o la bambina più “messo in mezzo” alle elementari? Giusto, esatto, ve lo siete ricordato. Ricordate il nome, il cognome, il viso. Ricordate quando camminava verso casa tutto solo e andava a sedersi in silenzio a un tavolino della caffetteria. Ricordate, insomma. Dina Levinsky rimane con voi.
«Ho sentito che sei un dottore» mi disse.
«Sì. E tu?»
«Faccio la grafica, ma sono anche un’artista. Il mese prossimo farò una mostra al Greenwich Village.»
«Una mostra di quadri?»
Esitò. «Sì.»
«Sei sempre stata brava in disegno.»
Sollevò il capo, sorpresa. «L’avevi notato?»
Seguì una breve pausa. Poi mi scoprii a dire: «Avrei dovuto fare qualcosa».
Dina sorrise. «No, avrei dovuto farlo io.»
Aveva un bell’aspetto. Con questo non voglio dire che il brutto anatroccolo si era trasformato in uno splendido cigno, come nei film. Dina, tanto per cominciare, non era mai stata brutta. Piuttosto anonima, direi. E forse lo era ancora. I lineamenti erano sempre troppo aguzzi, per così dire, ma su un viso adulto non stonavano. E i suoi capelli, così scialbi da giovane, avevano ora una loro personalità.
«Ti ricordi Cindy McGovern?» mi chiese.
«Certo.»
«Era quella che mi torturava di più.»
«Me lo ricordo.»
«Be’, non ci crederai. Qualche anno fa esponevo in una galleria, a midtown Manhattan, e un giorno vedo entrare Cindy che subito mi abbraccia e bacia. Vuole parlare dei bei tempi, mi fa domande tipo: “Ti ricordi quant’era idiota il signor Lewis?”. Era tutta sorrisi e te lo giuro, Marc, non si ricordava come mi trattava quando eravamo bambine. Non fingeva, aveva completamente rimosso tutto. Me ne accorgo, a volte.»
«Ti accorgi di che cosa?»
Lei sollevò la tazza con entrambe le mani. «Nessuno rammenta di avere fatto il prepotente.» Chinò la schiena, lanciando occhiate a destra e a sinistra. E cominciai a chiedermi se i miei ricordi fossero precisi o se, per caso, stessimo rivisitando la storia.
«È tutto così incasinato» disse Dina.
«Essere tornata in questa casa, vuoi dire?»
«Sì.» Appoggiò la tazza sul tavolo. «Immagino vorrai una spiegazione.»
Attesi.
Ricominciò a lanciare rapide occhiate. «Vuoi sentire qualcosa di curioso?»
«Certo.»
«Era qui che mi sedevo. Da ragazzina, voglio dire. Avevamo anche noi un tavolo rettangolare come questo e io mi sedevo sempre allo stesso posto. E ora, tornando qui, non so perché, ma mi sono sentita come attratta da questa sedia. Questo, immagino, è in parte il motivo per cui sono venuta qui, questa notte.»
«Credo di non capire.»
«Questa casa. Ha ancora una forte attrazione su di me, è come una calamita.» Avvicinò il capo al mio e per la prima volta i nostri sguardi s’incrociarono. «Le hai sentite anche tu quelle voci, vero? Su mio padre, su quello che è successo in questa casa.»
«Sì.»
«Erano vere.»
Cercai di non trasalire. Non sapevo assolutamente che cosa dire. Pensai all’inferno della scuola, poi tentai di aggiungervi l’inferno di quella casa. Era qualcosa d’inimmaginabile.
«Ora è morto, mio padre, voglio dire. È morto sei anni fa.»
Battei le palpebre e distolsi lo sguardo.
«Sto bene, Marc. Davvero. Sono stata in analisi… o meglio, ci sono ancora. Conosci il dottor Radio?»
«No.»
«Si chiama proprio così, Stanley Radio, ed è piuttosto noto per la sua “tecnica Radio”. Sono in cura da lui da anni e sto molto meglio, ho superato le mie tendenze autodistruttive, non mi sento più inutile. Però è strano. Ce l’ho fatta. No, davvero. Quasi tutte le vittime di abusi domestici hanno problemi sessuali e di impegno personale, io non li ho mai avuti. Riesco ad affrontare le questioni intime senza problemi. Sono sposata, mio marito è in gambissima. Il nostro non è un matrimonio da “e vissero felici e contenti”, ma è ugualmente un ottimo matrimonio.»
«Mi fa piacere» dissi, anche perché non sapevo che altro dire.
Sorrise di nuovo. «Sei superstizioso, Marc?»
«No.»
«Nemmeno io. Solo che, non so, ma quando ho letto di tua moglie e tua figlia ho cominciato a farmi delle domande. Su questa casa, su un possibile karma negativo e roba del genere. Era così simpatica, tua moglie.»
«Conoscevi Monica?»
«Ci eravamo incontrate.»
«Quando?»
Dina non rispose subito. «Hai mai sentito il termine “molla”?»
Mi tornò in mente un corso di Medicina. «In psichiatria, intendi dire?»
«Sì. Vedi, quando ho letto della tua tragedia è scattata una specie di molla, come accade agli alcolisti o alle anoressiche. Non guariscono mai del tutto per cui, se succede qualcosa, scatta un non so che e tornano alle vecchie, brutte abitudini. Ho cominciato a mangiarmi le unghie, a farmi male fisicamente. Ed era come se… come se dovessi fare i conti con questa casa. Dovevo affrontare il passato per sconfiggerlo.»
«Ed è quello che stavi facendo questa notte?»
«Sì.»
«E quando ti ho visto diciotto mesi fa?»
«Lo stesso.»
Mi appoggiai allo schienale della sedia. «Ogni quanto ti fermi a guardarla?»
«Ogni due mesi, più o meno. Lascio l’auto al parcheggio della scuola e per venire qui passo dal sentiero degli Zucker. Ma c’è dell’altro.»
«Che cos’altro c’è?»
«Le mie visite. Perché, vedi, questa casa conserva ancora i miei segreti, letteralmente.»
«Non ti seguo.»
«Mi sforzo di trovare il coraggio di bussare di nuovo a questa porta, ma non ci riesco. E ora sono qui, in questa cucina, e sto bene.» Cercò di sorridere, come per dare una conferma alle sue parole. «Ma non so ancora se riesco a farcela.»
«A fare che cosa?»
«Sto parlando a vanvera.» Si grattò il dorso della mano, con forza, piantando quasi le unghie nella pelle. Avrei voluto allungare una mano verso di lei, ma il gesto sarebbe apparso forzato. «Ho scritto tutto. In un diario. Ho scritto quello che mi è successo, e il diario è ancora qui.»
«In casa?»
Annuì. «L’avevo nascosto.»
«La polizia ha perquisito questa casa, dopo il delitto, da cima a fondo.»
«Non l’hanno trovato, ne sono sicura. E anche se l’avessero scoperto è sempre un vecchio diario, non avrebbero avuto alcun motivo di svegliarlo dal suo sonno. Una parte di me vorrebbe che questo diario rimanesse al suo posto, ignorato da tutti. Ormai appartiene al passato, non so se capisci che cosa intendo dire. Non svegliare il can che dorme, in questo senso. Ma un’altra parte vorrebbe che questo diario vedesse la luce, quasi che la luce potesse ucciderlo come fa con i vampiri.»
Читать дальше