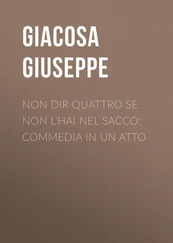Harlan Coben
Non hai scelta
Ricordando con affetto mia suocera, Nancy Armstrong.
E in omaggio ai suoi nipoti:
Thomas, Katharine, McCallum, Reilly, Charlotte, Dovey, Benjamin, Will, Ana, Eve, Mary, Sam, Caleb e Annie.
Quando la prima pallottola mi colpì al petto, pensai a mia figlia.
Questo, almeno, è ciò che voglio credere. Svenni quasi subito e, se vi interessano i dettagli tecnici, non ricordo nemmeno il momento in cui mi hanno sparato. So che persi un mucchio di sangue. So che una seconda pallottola mi sfiorò la testa, anche se a quel punto ero probabilmente già svenuto. So che il mio cuore si fermò. Ma mi piace lo stesso credere che mentre agonizzavo a terra pensavo a Tara.
Per vostra informazione: non ho visto né una luce radiosa, né un tunnel. Oppure, se li ho visti, non me ne ricordo nemmeno.
Tara, la mia bambina, ha soltanto sei mesi. Era nella sua culla e chissà se i colpi di pistola l’hanno spaventata. Credo di sì. Probabilmente è scoppiata a piangere. E mi chiedo se il suo pianto, familiare quanto irritante, sia riuscito a penetrare la caligine che mi avvolgeva, ammesso che io l’abbia udito a qualche livello. Ma, ripeto, non me lo ricordo.
Quello che ricordo, comunque, è il momento in cui Tara è nata. Ricordo Monica, la mamma di Tara, che dava un’ultima spinta. Ricordo la sua piccola testa che compariva. Fui il primo a vedere mia figlia. Sappiamo tutti che sulla strada della vita si trovano dei bivi. Sappiamo tutti che aprendo una porta se ne chiude un’altra, conosciamo bene i cicli vitali, i cambi di stagione. Ma il momento in cui vi nasce un figlio… è qualcosa che va al di là del surreale. È come varcare una specie di portale di Star Trek , è un trasformatore in piena regola della realtà. È tutto diverso. Tu sei diverso, da elemento semplice che eri vieni colpito all’improvviso da un catalizzatore che ti trasforma in un elemento ben più complesso. Il tuo mondo non c’è più, si è ridotto alle dimensioni di un batuffolo di tre chili e duecento grammi: nel caso di mia figlia, voglio dire.
La paternità mi confonde. Sì, so bene che essendo nel ramo solo da sei mesi devo considerarmi un dilettante. Lenny, il mio migliore amico, ha quattro bambini, una femmina e tre maschi. Marianne è la più grande e ha dieci anni mentre il più piccolo dei tre fratelli ha appena compiuto un anno. Per rendermi conto che ancora non so nulla della paternità mi basta guardare l’espressione del viso di Lenny, quella di uno che è felice di vivere in tutto quel caos, oppure i tappetini del suo fuoristrada sempre incrostati di macchie di cibo. Ma quando mi sento davvero perso o spaventato dalla prospettiva di allevare un bambino, guardo quel fagottino indifeso nella culla, il fagottino guarda me e penso a che cosa non farei per proteggerlo. Per la mia bambina sarei pronto a sacrificare la mia vita in un secondo: e se devo dirla tutta, in caso di assoluta necessità sarei pronto a sacrificare anche la vostra di vita.
Così mi piace pensare che, mentre le due pallottole mi colpivano, mentre crollavo sul pavimento di linoleum della cucina stringendo in mano una barretta di müsli mangiata per metà, mentre giacevo immobile nella pozza del mio sangue che continuava ad allargarsi e perfino mentre il mio cuore cessava di battere, stavo comunque cercando di fare qualcosa per proteggere mia figlia.
Ripresi conoscenza nell’oscurità.
Dapprima non capii dove mi trovavo, finché non udii da destra un bip bip familiare. Non mi mossi, ma rimasi ad ascoltarlo. Mi sembrava di avere il cervello marinato nella melassa. Il primo impulso che provai fu quello primitivo della sete. Bramavo l’acqua. Non avrei mai immaginato che la gola potesse seccarsi a tal punto. Cercai di chiamare qualcuno, ma la lingua era come appiccicata in fondo alla bocca.
Una figura umana entrò nella stanza. Cercai di mettermi seduto nel letto, e un dolore cocente mi trafisse il collo come un coltello. La testa mi ricadde all’indietro. E, ancora una volta, piombai nelle tenebre.
Quando mi risvegliai, era giorno. Impietose lame di sole sciabolavano attraverso i listelli della veneziana. Battei le palpebre. Una parte di me avrebbe voluto sollevare una mano per bloccare i raggi, ma la spossatezza era tale che quel comando non riusciva a giungere al luogo preposto. E avevo ancora la gola insopportabilmente asciutta.
Udii un movimento e all’improvviso una donna si materializzò accanto al mio letto. Alzando lo sguardo mi accorsi che era un’infermiera. E la prospettiva, così diversa da quella cui ero abituato, mi sconcertò. Non c’eravamo proprio. Avrei dovuto essere io quello in piedi accanto al letto e qualcun altro dentro, non il contrario. Un cappellino bianco, di quelli a tricorno, stava piantato, simile a un nido d’uccello, sulla testa dell’infermiera. Ho lavorato buona parte della mia vita in ospedali di ogni tipo, ma credo di aver visto quel tipo di cappellino soltanto in televisione o al cinema. La donna era tarchiata e nera.
«Dottor Seidman?»
La sua voce faceva pensare allo sciroppo d’acero caldo. Riuscii ad annuire vagamente.
Doveva leggere nel pensiero, quell’infermiera, perché aveva in mano una tazza piena d’acqua. Mi infilò la cannuccia tra le labbra e io succhiai avidamente.
«Non così in fretta» mi disse con dolcezza.
Stavo per chiederle dove mi trovavo, ma sarebbe stata una domanda fin troppo ovvia. Aprii la bocca per domandare che cos’era successo, ma ancora una volta lei mi anticipò.
«Vado a chiamare il dottore» disse, avviandosi verso la porta. «Lei stia tranquillo.»
«La mia famiglia…» biascicai.
«Torno subito. Lei cerchi di non preoccuparsi.»
Mi guardai attorno. La mia vista era ancora avvolta nella caligine indotta dai medicinali, simile a una tenda da doccia, ma avevo sufficienti stimoli per trarre le dovute conclusioni. Mi trovavo in una tipica camera d’ospedale, era fin troppo ovvio. Alla mia sinistra era appesa una flebo, e la sua cannula terminava dentro il mio braccio. I tubi al neon ronzavano quasi impercettibilmente, ma non poi così tanto. Di fronte a me, nell’angolo a destra della stanza, spuntava un braccio metallico girevole sul quale era sistemato un piccolo televisore.
A un metro o poco più dal letto si apriva una grossa vetrata; socchiusi le palpebre ma non riuscii a vedere nulla. Probabilmente ero sotto monitoraggio, il che voleva dire che mi trovavo in Rianimazione: il che, a sua volta, voleva dire che avevo qualcosa di serio.
Mi prudeva la testa e sentii che i capelli mi tiravano. Bende, avrei giurato. Cercai di capire in quali condizioni mi trovassi ma il cervello non voleva proprio collaborare. Dentro di me rimbombava silenziosamente un dolore sordo, anche se non ne intuivo la provenienza. Mi sentivo le braccia e le gambe pesanti e il torace costretto dentro una gabbia di piombo.
«Dottor Seidman?»
Girai di scatto lo sguardo verso la porta, e vidi entrare una donnetta in divisa da sala operatoria completa di cuffia. La mascherina, allentata, le pendeva sul collo. Io ho trentaquattro anni, lei dimostrava la stessa età.
«Sono la dottoressa Heller» si presentò, avvicinandosi. «Ruth Heller.» Sicuramente mi aveva detto il cognome, oltre al nome, per pura cortesia professionale. Ruth Heller mi dette un’occhiata indagatrice. Io cercai di mettere a fuoco il suo sguardo. Il mio cervello era ancora inerte, ma sentivo che stava lentamente e faticosamente riprendendo vita. «Si trova al St Elizabeth Hospital» mi informò con un tono di voce debitamente serio.
La porta alle sue spalle si aprì per far entrare un uomo. Non riuscivo a distinguerlo bene, data la caligine da tenda-doccia di cui sopra, ma non mi sembrava di conoscerlo. L’uomo incrociò le braccia e si appoggiò alla parete con consumata disinvoltura. Non è un dottore, pensai. Li conoscevo, i dottori, lavoravo con loro da tanto tempo.
Читать дальше