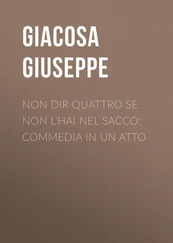Sulla mensola del caminetto c’erano delle foto e io mi fermavo sempre a guardare quelle di mia sorella Stacy. Non so che cosa cercassi. O forse sì. Cercavo tracce premonitrici. Cercavo qualche elemento dal quale si sarebbe dovuto intuire che quella donna giovane, fragile e disturbata un giorno avrebbe comprato in strada una pistola per spararmi e fare del male a mia figlia.
«Marc?» Era mia madre, e sapeva che cosa stavo facendo. «Vieni a darmi una mano?»
Andai nella camera da letto sul retro. Papà dormiva al piano terra, per evitare di doverlo portare su per le scale con la sedia a rotelle. Lo vestimmo, che era come vestire della sabbia bagnata. Mio padre dondola da una parte all’altra e dato il suo peso fa spesso movimenti improvvisi. Mamma e io ci siamo abituati, ma non per questo il nostro compito è più agevole.
Quando mamma mi salutò con un bacio, prima di andare al lavoro, sentii nel suo alito un misto di menta e di sigarette. Avevo insistito tante volte perché smettesse, lei prometteva sempre, ma sapevo che non avrebbe mai smesso di fumare. Mi accorsi di quanto si fosse rilasciata la pelle del suo collo, con le collane d’oro che si andavano quasi a infilare tra le pieghe. Si chinò a baciare mio padre sulla guancia e per qualche secondo non staccò le labbra.
«State attenti» ci disse. Ce lo diceva sempre, quando uscivamo insieme.
Il nostro viaggio ebbe inizio. Spingendo la carrozzella di papà passammo davanti alla stazione ferroviaria. La nostra è una cittadina di pendolari. I viaggiatori, soprattutto uomini ma anche diverse donne, erano in fila in attesa del treno con i loro lunghi cappotti, la borsa in una mano e il bicchierone di caffè nell’altra. Potrà sembrarvi strano, ma anche prima dell’ll settembre ai miei occhi quei pendolari erano degli eroi. Salivano su quel maledetto treno cinque giorni la settimana, cambiavano a Hoboken per prenderne uno della PATH con il quale giungevamo a New York. Alcuni scendevano nella Trentatreesima Strada e prendevano la metropolitana per midtown, altri invece si spostavano nella zona finanziaria, adesso che è stata riaperta. Facevano quel sacrificio ogni giorno, soffocando i propri desideri e le proprie esigenze per provvedere ai bisogni dei loro cari.
Io potrei dedicarmi alla chirurgia plastica estetica e guadagnare una barca di soldi. I miei genitori, di conseguenza, potrebbero permettersi un’assistenza migliore per papà, potrebbero trasferirsi in una zona più bella, prendersi un’infermiera a tempo pieno, andare a vivere in una casa più adatta alle loro esigenze. Ma non mi interessa quella branca della chirurgia plastica, non li aiuto prendendo la strada più battuta perché, francamente, un lavoro del genere mi annoierebbe. Quindi scelgo di fare qualcosa di più coinvolgente, qualcosa che amo fare. E questo basta agli altri per considerarmi una specie di eroe votato al sacrificio. Ma la verità è un’altra. Quelli che lavorano con i poveri sono di solito i più egoisti. Non vogliamo, cioè, sacrificare i nostri bisogni, fare un lavoro che ci consente di mantenere più che dignitosamente i nostri cari non ci basta, mantenere le persone che amiamo è secondario. Abbiamo bisogno di una soddisfazione personale, noi, anche se questo significa che le nostre famiglie certe cose non se le potranno permettere. Quei tipi in giacca e cravatta che vedo salire ancora intorpiditi dal sonno sul treno della NJ Transit? Spesso odiano il posto dove stanno andando e il loro lavoro, ma in ogni caso lo fanno. Lo fanno per provvedere alle loro famiglie, per offrire migliori condizioni di vita alle mogli, ai figli e forse, forse, anche ai genitori avanti negli anni e malati.
Chi è da ammirare, quindi? Loro o quelli come me?
Io e papà seguivamo ogni giovedì lo stesso itinerario. Prendevamo il sentiero che gira attorno al parco, dietro la biblioteca. Il parco era pieno di campi di calcio, tipico delle periferie residenziali. Quanti terreni di qualità erano destinati a questo sport straniero, cosiddetto di seconda scelta? Mio padre sembrava gradire quell’atmosfera, sentire e vedere quei ragazzini che giocavano. Ci fermammo per fare respiri profondi. Guardai alla mia sinistra: diverse donne, evidentemente ricche, facevano jogging fasciate in tute aderentissime di lycra. Papà sembrava concentrato e la cosa mi fece sorridere. Forse la predilezione di papà per questo parco non aveva nulla a che vedere con il calcio.
Non ricordo più che aspetto avesse una volta mio padre. Quando tento di spingermi così indietro con il pensiero, i miei ricordi diventano delle semplici istantanee, dei flash, la risata profonda di un uomo, un bambino aggrappato al suo braccio che dondola sollevato dal suolo. Non molto di più. Ricordo che l’amavo moltissimo e tanto basta, direi.
Dopo il suo secondo ictus, sedici anni fa, papà cominciò ad avere problemi a parlare. Si bloccava a metà frase, si mangiava le parole. Rimaneva in silenzio per ore e a volte per giorni. Ci si dimenticava della sua esistenza. Nessuno aveva la certezza che lui capisse davvero, se la sua fosse una classica “afasia espressiva” — chi ne è affetto capisce ma non riesce a comunicare — o qualcosa di ben più inquietante.
Ma in una calda giornata di giugno, quando ero all’ultimo anno delle superiori, mio padre all’improvviso allungò un braccio e mi afferrò una manica stringendola con la forza dell’artiglio di un’aquila. Stavo andando a una festa e Lenny mi aspettava alla porta. La sorprendente forza di mio padre mi bloccò, abbassai lo sguardo su di lui. Aveva il viso esangue, i tendini del collo tesi: ma soprattutto ciò che lessi in lui fu paura allo stato puro. Il suo sguardo perseguitò per anni il mio sonno. Mi sedetti sulla sedia accanto a lui, che non mi aveva lasciato il braccio.
«Papà?»
«Io capisco» mi disse in tono implorante. La stretta sul braccio aumentò. «Per favore.» Ogni parola era una lotta. «Capisco ancora.»
Fu tutto ciò che disse, ma bastò. Secondo me aveva voluto dire “Anche se non so parlare o rispondere, capisco ugualmente. Per favore, non tagliatemi fuori”. Per un po’ i medici furono concordi: il suo era un caso di afasia espressiva. Poi ebbe un altro ictus e i medici furono meno certi su cosa lui capisse e cosa no. Forse il mio ragionamento è una versione personale della “scommessa” di Pascal, e cioè: “Se lui mi capisce allora dovrei parlargli, in caso contrario che male c’è a parlargli?”: ma sento di doverglielo, a mio padre. E così gli parlo, gli dico tutto. E in quel momento gli stavo parlando della visita di Dina Levinsky (“Te la ricordi Dina?”) e del CD nascosto.
Il viso di papà era immobile, con l’angolo sinistro della bocca all’ingiù a formare una piega amara. Spesso vorrei che lui e io non avessimo avuto quella conversazione dell’“Io capisco”. Non so se sia peggio non capire nulla o rendersi conto di essere in trappola. O forse lo so.
Stavo facendo il secondo giro, quello che passa accanto alla nuova pista di skateboard, quando vidi mio suocero. Edgar Portman se ne stava seduto su una panchina ed era elegante come al solito, aveva le gambe accavallate e la piega dei pantaloni era talmente “affilata” che ci si sarebbero potuti affettare i pomodori. Dopo il fattaccio io ed Edgar cercavamo di tenere in piedi un rapporto che in effetti non era mai esistito quando sua figlia era ancora viva. Ci eravamo rivolti assieme a un’agenzia investigativa, Edgar naturalmente conosceva la migliore sulla piazza, ma non avevano cavato un ragno dal buco. Dopo un po’ ci eravamo entrambi stancati di fingere, l’unico legame che ci univa era quello che evocava il più brutto momento della mia vita.
Edgar poteva trovarsi là per pura coincidenza, ovviamente. Viviamo nella stessa cittadina e sarebbe più che naturale ogni tanto imbattersi l’uno nell’altro. Ma non in quel caso, lo sapevo. Edgar non era il tipo da fare passeggiate in un giardino pubblico, era là per incontrare me.
Читать дальше