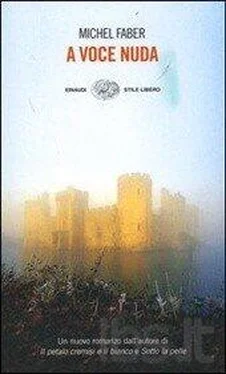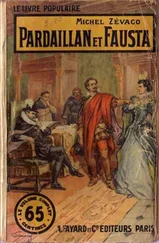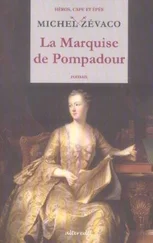— Oh… grazie, — disse.
— Però, se sono l’unica a fare la spesa, mi servono più soldi, — aggiunse Dagmar. Il bambino succhiava ancora al seno, tranquillo come un gattino addormentato.
— Basta che lo dici a Roger, ci pensa lui, — disse Catherine. Erano anni che non firmava un assegno né metteva piede in una banca. Negli ultimi tempi aveva una tesserina di plastica che faceva uscire i soldi da una fessura incastonata nel muro, ammesso che lei ricordasse un numero a quattro cifre… e la tessera, naturalmente. Nel bosco di Martinekerke non c’era sicuramente un posto dove infilare quella tesserina di plastica.
— Come hai dormito stanotte, Dagmar? — chiese Catherine, portando la scodella di Ben nel lavandino.
— Benissimo, — disse Dagmar.
— Non hai sentito niente di strano, alle prime luci dell’alba? Come un grido dal bosco?
— Niente è capace di svegliarmi, — disse Dagmar, abbassando lo sguardo su Axel, — a parte lui, ovviamente.
Non sembrava molto probabile, dato il funzionamento pressoché silenzioso del piccino, anche se di sicuro Dagmar parlava con cognizione di causa. Catherine rimase colpita vedendo che, nell’abbassare lo sguardo sul figlio che aveva al seno, alla base del viso magro e dalla pelle compatta della ragazza tedesca si era formato un doppio mento che la invecchiava di cinque anni. Dagmar aveva anche una sottile cicatrice sulla fronte che Catherine non aveva mai notato. Rughe del futuro, cicatrici del passato, milioni di segni a registrare una vita privata che a nessun estraneo è dato capire.
— Ti stai divertendo qui? — chiese Catherine.
— Certo, — rispose Dagmar. — È bello che ci mettano a disposizione tutto questo spazio. Sono una musicista professionista ormai da nove anni, e ho un figlio; è ora che qualcuno ci paghi per fare le prove, ti pare?
— Ma il luogo in sé, il brano in sé… ti divertono?
— Non m’importa un accidenti della musica di Pino Fugazza, — disse Dagmar con un’alzata di spalle, scostando Axel dal seno. Il capezzolo e l’areola rilucevano di saliva, il che indusse Catherine a distogliere immediatamente lo sguardo. — Voglio cantarla bene. Se la musica che mi mettono davanti mi annoia tanto, farei meglio ad alzare il culo e compormela da sola, ti pare?
Catherine, ancora in imbarazzo per il disgusto provato vedendo il capezzolo cosparso di bava, rimase tanto più sconcertata per la piega che stava assumendo la conversazione. Quel linguaggio spiccio adottato da Dagmar accentuava il fatto che fosse straniera perfino più dell’accento tedesco, e la sincera indifferenza per l’incarico che li aveva condotti lì era ancora più sbalorditiva. Ma la cosa in assoluto più strana era l’idea di comporre la musica da soli qualora insoddisfatti di quella fornita dagli altri.
— Tu scrivi musica? — Ai margini inferiori della sua visione, Catherine scorse la T-shirt che calava andando a coprire il perturbante turgore di carne.
— Certo, — disse Dagmar, trovando un punto più adeguato dove poggiare la testa lanuginosa del figlioletto. — Tu no?
Catherine non si era mai sognata di comporre una nota. Suonava il piano con destrezza, se la cavava bene con il flauto, le bastava leggere lo spartito di un brano musicale per sentirlo risuonare nella testa — anche se non con la precisione con cui riusciva a sentirlo Roger, è ovvio. Quando si trattava di leggere uno spartito, Catherine immaginava il proprio cervello come una vecchia radio, col sonoro che ogni tanto andava e veniva, e il cervello di Roger come un lettore di cd, che coglieva ogni sfumatura grazie all’efficienza del digitale. Quanto all’eventualità di fare dei segni sul pentagramma con le sue mani: no, era inconcepibile. Le rare volte in cui si permetteva di cantare una nota diversa da quelle che qualcuno aveva scritto per lei, Roger era sempre lì pronto a dire: «Fa diesis, Kate, non fa naturale» o qualcosa del genere.
— Sono convinta di non avere i requisiti, — disse a Dagmar.
La ragazza tedesca non sentiva un forte impulso a contraddirla, gli occhi marroni scuri e opachi come cioccolato al caffè belga.
— Se lo dici tu, — commentò, stringendosi nelle spalle.
Catherine si richiuse in se stessa: aveva sperato di sentirsi rassicurare. Che strani questi tedeschi, non capivano che una dichiarazione di inadeguatezza di fatto è solo una scusa per sentirsi incoraggiare. Forse era un bene che non avessero vinto la Battaglia di Inghilterra.
— Tanto per cominciare non ho la formazione giusta, — disse Catherine. — I vari Pino Comesichiama hanno studiato composizione per anni.
Era chiaro che Dagmar si faceva un baffo delle credenziali di Pino.
— Canticchiare sottovoce in bagno è comporre, non trovi? — disse, stringendo Axel contro la spalla. — Io canto per me stessa quando vado in bici, e per mio figlio. E non è il Partitum Mutante che canto, questo è certo.
Sfoderò un largo sorriso, che Catherine ricambiò. Era un modo piacevole e sicuro per chiudere la conversazione.
— Ora metto Axel a letto, — disse Dagmar. — Dovresti andare a fare una passeggiata, non credi? Là fuori è tutto perfetto: il clima, il bosco, tutto.
— Mi piacerebbe, — le assicurò Catherine. — Non sai quanto. Ma forse Roger vuole che cominciamo subito.
L’occhiata che le scoccò Dagmar la fece vergognare tanto che corse a cercare le scarpe.
Gina la cameriera arrivò a bordo di una piccola Peugeot bianca proprio mentre Catherine usciva dalla porta — un tempismo perfetto, così Roger non poteva arrabbiarsi per il ritardo nelle prove, giusto?
Vagamente sgomenta per la propria indocilità, Catherine mollò gli ormeggi dalla casa senza dare spiegazioni a chicchessia, dirigendosi velocemente ai margini del bosco, per poi sbirciare da lì, attraverso gli alberi radi, in direzione del castello. Roger e Julian facevano a gara per dare il benvenuto a Gina la quale, contrariamente alle aspettative, era una bionda poco più che ventenne con un fisico da ballerina e una tenuta da lavoro in tema. Tutto nei Paesi Bassi aveva una qualità superiore al previsto. Perfino l’aspirapolvere che Gina cercava di estrarre dal sedile posteriore dell’auto senza l’aiuto degli stranieri sembrava degno di un premio per il design e capace di risucchiare qualunque cosa nel suo lucente corpicino di plastica.
Per quanto Catherine ne sapeva, Roger non le era mai stato infedele. Non era nel suo stile. Una volta che prendeva un impegno, vi si atteneva scrupolosamente e non lo mollava a nessun costo. A nessun costo. Né era probabile che un infarto o un colpo apoplettico glielo portassero via. Aveva quattro anni più di lei, ma era in gran forma. Sarebbero stati insieme per sempre, a meno che non morisse prima lei.
Catherine diede le spalle al castello, inoltrandosi fra gli alberi. Camminando calciava dolcemente il morbido tappeto frusciante di foglie morte e terra torbosa per tracciare una specie di sentiero da seguire dopo nel caso si fosse persa. Il cielo era limpido, il venticello mite. Le impronte sarebbero rimaste, ne era sicura.
Durante la guerra, probabilmente i nazisti avevano ucciso delle persone in quel bosco. La guerra era arrivata in Belgio, no? Provò una leggera vergogna nell’ammettere che non ne era sicura. In realtà ne sapeva ben poco su qualunque argomento che esulasse dal canto. Roger l’aveva salvata dall’infelicità post-adolescenziale al Magdalen’s College e, da lì in poi, si era assunto la responsabilità del mondo intero. Le diceva quello che secondo lui poteva interessarle, evitava accuratamente quello che a suo parere era meglio non sapesse. E lei, da parte sua, aveva davvero la memoria corta, soprattutto negli ultimi tempi. Era possibile che Roger una volta le avesse parlato del ruolo svolto dal Belgio durante la Seconda guerra mondiale, ma ormai l’aveva dimenticato.
Читать дальше