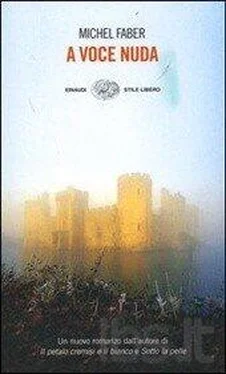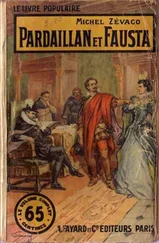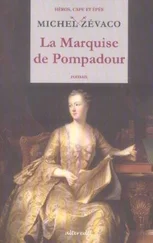Dagmar tagliava il pane fresco sul ripiano della cucina mentre il figlioletto dormiva avvolto in una coperta sulla stessa superficie, proprio accanto alla tavoletta del pane, come se subito dopo volesse affettare anche lui.
— È il silenzio che senti quando scali una montagna, — disse, riferendosi al suo passatempo preferito. — A me piace.
Non avendo trovato soddisfazione sul versante femminile, Catherine tornò agli uomini. Ben, però, era alle prese con l’ havermout , che infilava tra le grosse labbra morbide un cucchiaio dopo l’altro, e Julian aveva rivolto l’attenzione al caffè, sicché restava solo Roger.
Il marito sondò un istante il proprio animo in cerca di un commento adeguato.
— A pensarci, un’acustica vocale così silenziosa dev’essere rarissima, — disse. — Cioè, basta pensare a quella registrazione dei canti di Hildegard fatta dalle Gothic Voices… Emma Kirkby canta come un’allodola e, in sottofondo, si sentono le macchine che sfrecciano in strada!
Julian si vide costretto a dissentire.
— È perché i tecnici del suono hanno messo i microfoni a una distanza eccessiva dai cantanti, — disse, — nel tentativo di cogliere quell’acustica da monastero. Avrebbero fatto meglio a piazzarglieli davanti alla bocca, e ad aggiungere qualche risonanza in un secondo momento.
— Non dirai sul serio, — protestò Roger. Catherine aveva cessato di esistere, dimenticata mentre cercava di tostare il pane per il marito sotto il grill del forno. — L’acustica di un luogo è unica e preziosa.
— Per un’esibizione dal vivo senz’altro, — acconsentì Julian. — La mia voce non è mai risuonata bene come in quella cantina di Reykjavik, con le pareti di pietra e tutto il resto. Ma le Gothic Voices non cantavano dal vivo, registravano un disco. Che bisogno c’è della chiesa di St Jude-on-the-Wall a Hampstead se basta premere un interruttore o un fader per avere un’acustica da chiesa, senza un’accidenti di Volvo che romba in strada?
In cucina cominciò a diffondersi un odore di pane bruciato. Il piccolo Axel prese a tossire agitando dolcemente i braccìni sul ripiano della cucina, come se cercasse di volare verso un quadrato d’aria più pura.
— Scusate, — disse Catherine.
Il Partitum Mutante era una vera goduria per almeno uno dei suoi esecutori: Benjamin Lamb. Evidentemente Pino Fugazza aveva un debole per le litanie reboanti dei monaci tibetani e nel suo brano aveva inserito a profusione qualcosa di molto analogo per le parti destinate al basso.
Se gli altri componenti del Coro Courage dovevano imparare melodie complesse e acrobatiche in tonalità ingrate, a Benjamin veniva richiesto di mormorare come un organo battuta dopo battuta. All’inizio del brano, i suoi vocalizzi erano intesi a comunicare nientemeno che la nascita dell’universo, compito che lui affrontava con una risonanza agghiacciante degna di un santo himalayano… anzi di molti.
— Muooooooiiiinnng, muoooooiiiiinnng, muooooooiiiinnng, — cantava, dal profondo del grosso ventre.
Pino Fugazza, però, era un tipo scaltro: aveva cronometrato le discese del baritono in modo che Roger coprisse le pause di Ben per riprendere fiato, creando l’illusione di un’incessante sirena di basso. E, proprio quando sembrava che la musica dovesse rimanere abissalmente cupa in eterno, Julian si inseriva intonando la prima vera parola con voce alta e pura: «Dio»… in sol maggiore, naturalmente.
Il vero problema sorgeva con l’ingresso delle voci femminili, un riflesso indubbiamente della filosofia italiana, filtrata dalla tradizione giudaico cristiana, in materia di rapporti umani. A quel punto il manoscritto assumeva una complessità preoccupante, le note affollavano le linee divisorie delle battute come truppe compatte di formiche schiacciate in massa incontro a qualcosa di irresistibile.
Dagmar e Catherine cantarono fino a grondare sudore, che colava dalla fronte andando a imbrattare le pagine. Cantarono fino ad avere mal di gola. Cantarono finché non si sentirono indotte a fissarsi con aria implorante, come due schiave in una piantagione desiderose che l’altra non crolli, perché questo spianerebbe la strada a un destino ben più infausto. Le ore passavano, non in un flusso lineare, bensì in ripetizioni infinite di due minuti qua, cinque minuti là, poi gli stessi due minuti di prima, e avanti così a oltranza.
Finalmente, mentre calava di nuovo la sera, il Coro arrivò alla fine del brano e, uno a uno, i vari cantanti si dileguarono, lasciando Catherine a portare il Partitum Mutante a conclusione. L’ultimissima nota era un do altissimo, da raggiungere scalando varie battute a partire da due ottave più giù, e da tenere per quindici secondi, aumentando il volume, prima di lasciarlo sfumare nel nulla. Estatica all’idea di scorgere la fine, Catherine cantò quella nota con la purezza e la sicurezza di un piffero.
Per vari secondi dopo che lei ebbe pilotato le ultime tracce della nota verso l’oblio, il resto del Coro Courage rimase muto. Nella quiete straordinaria del bosco di Martinekerke respiravano come bambini, e nessuno voleva essere il primo a parlare.
— Devo confessare che quella nota mi preoccupava un po’, — disse Roger alla fine. — Ben fatto.
Catherine arrossì nascondendosi la gola dietro la mano.
— Si direbbe che riesco a prendere note sempre più alte, — disse.
Non appena ebbe concluso, tornò a insediarsi il silenzio, perciò riprese a parlare, usando la conversazione per colmare il vuoto.
— Se da piccola avessi avuto una di quelle madri che ti stanno col fiato sul collo, forse a quest’ora sarei un soprano leggero.
Dagmar stava liberando le gambe dalla posizione del loto con una smorfia di disagio, e intanto agitava i piedi nudi — la sua soluzione personale al dilemma delle ciabatte.
— Perché, che tipo di madre avevi? — chiese.
Catherine alzò gli occhi al soffitto, cercando un’indicazione lassù sul tipo di madre che aveva avuto.
— A dire il vero era una violoncellista, — rispose meditabonda, — suonava nell’orchestra sinfonica della Bbc.
— Intendevo che tipo di persona era.
— Umm… non saprei, — mormorò Catherine, la visione sempre più indistinta mano a mano che fissava il raffinato mosaico di crepe nella vernice sovrastante. — Andava via spesso, e poi si è suicidata quando io avevo dodici anni.
— Oh, mi dispiace, — disse Dagmar.
Era strana quell’uscita così fiacca e formale pronunciata nei toni vigorosi della ragazza tedesca. L’asprezza dell’accento faceva sembrare l’espressione di cordoglio tutt’altra cosa, eppure non c’era una sola nota insincera: anzi, era proprio la sincerità di Dagmar a creare quella dissonanza. La frase: «Oh, mi dispiace» sembrava fatta apposta per essere cantata sottovoce in una cadenza femminile.
— Figurati, non c’è problema, — disse Catherine, abbassando lo sguardo per sorridere a Dagmar. L’immagine persistente azzurro spettrale del lampadario appeso al soffitto fluttuò come un’aura intorno al viso della ragazza tedesca. — È capitato a me trovarla… o di trovarla. Come si dice, Roger? — Gli lanciò un’occhiata, non abbastanza lunga però da cogliere l’espressione corrucciata e il sopracciglio che si agitava segnalandole di stare zitta. — L’ha fatto a letto, con i sonniferi e una busta di plastica ficcata in testa.
Dagmar strinse gli occhi senza dire niente, immaginando la scena e l’effetto che poteva aver prodotto su una bambina. Julian, invece, non riuscì a trattenersi.
— Ha lasciato un biglietto? — si informò.
— No, — rispose Catherine. Roger intanto, alla periferia della sua attenzione, si alzava facendo frusciare dei fogli. — Anche se la busta di plastica non era una qualsiasi. Era dell’Unicef, con delle immagini di bambini sorridenti. Mi sono sempre chiesta che cosa significasse.
Читать дальше