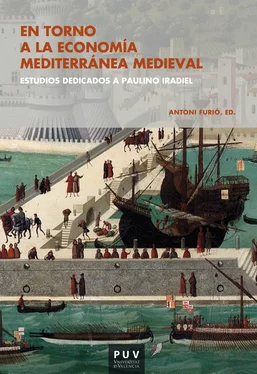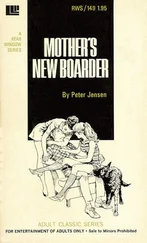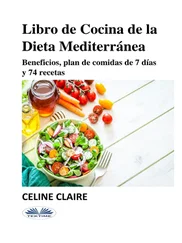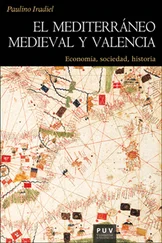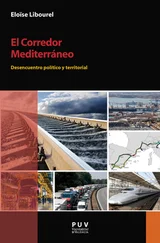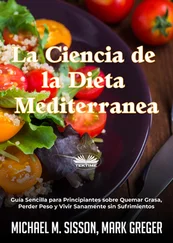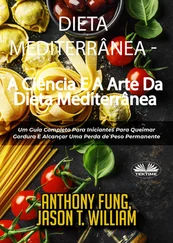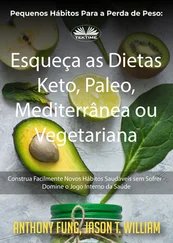54 D. Balestracci, «Lavoro e povertà in Toscana alla fine del Medioevo», Studi storici , fasc. 3, 1982, pp. 565-582, a p. 580.
55 A. Fanfani, Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII , Milano, 1959, p. 363.
56 Cfr. Franceschi, «Mobilità sociale e manifatture urbane» cit., pp. 92-94.
57 Cfr. de La Roncière, Prix et salaires à Florence cit., pp. 423-453.
58 La bibliografia sull’emigrazione/immigrazione di maestranze della manifattura laniera è vastissima e risalente nel tempo: cfr. Pinto, Il lavoro, la povertà l’assistenza cit., pp. 61-69, con i relativi riferimenti alla letteratura.
59 Tortoli, «Per la storia della produzione laniera» cit., pp. 230-231.
60 Così ad esempio lo Statuto di Bergamo della prima metà del XIII secolo prescriveva che il podestà dovesse provvedere allo sviluppo dell’arte della lana facendo sì che accanto ai panni bergamaschi se ne producessero altri sul modello di quelli di Verona e di Lombardia (Mainoni, Economia e politica nella Lombardia medievale cit., p. 30).
61 Pinto, Il lavoro, la povertà, l’assistenza cit., p. 67; Francheschi, «Woollen luxury clorth», cit., pp. 194-195.
62 Si veda per Siena, Tortoli , «Per la storia della produzione lanierta», cit., p. 222; per alcuni centri lombardi, Mainoni, Economia e politica nella Lombardia medievale cit., pp. 37-38; per Padova, Collodo, «Signore e mercanti: storia di un’alleanza» cit., pp. 362, 386-393; per vari centri marchigiani (Ascoli, Camerino, Fabriano, San Severino), G. Pinto, «Le città umbro-marchigiane», in Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale. Aspetti economici e sociali , Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 2003, pp. 245-272, a p. 258.
63 Si trattava di una prassi diffusa, ricordata in molti degli studi menzionati sopra. Significative le parole con cui nel 1387 il Comune di Siena approvò il divieto di importare panni: molti Comuni italiani «si sforzano d’acrescere e bonificare la detta Arte della lana ne le loro città, però che tutte, cioè Bologna, Vinegia, Verona, Padova, Mantova e tutte l’altre terre di Lombardia ànno proveduto che niuno panno forestieri di veruno pregio possa entrare o mettarsi ne le dette cittadi» (passo citato in Tortoli, «Per la storia della produzione laniera» cit., p. 236). A Vicenza, al divieto di vendere panni forestieri sul mercato cittadino, si aggiunse l’obbligo per i cittadini di indossare solo vestiti confezionati con tessuti vicentini (Demo, L’ « anima della città» cit., p. 79). Naturalmente sull’efficacia di tale normativa i dubbi sono tanti.
64 Si veda ad esempio per Firenze Franceschi, «Istituzioni e attività economica a Firenze» cit., pp. 82-83; per Verona e Vicenza Demo, L’ « anima della città» cit., pp. 79-83.
65 Di ciò ci si lamenta a Siena: Tortoli, «Per la storia della produzione laniera» cit., p. 236.
66 Tra le eccezioni, troviamo lo Statuto quattrocentesco di Faenza ( Statuta Faventiae , a cura di G. Rossini, RIS, 2a ediz., Bologna, 1929-1930, p. 289), che fissa i compensi massimi dei cimatori un tanto a braccio, ma con differenze tra i diversi tipi di panno. Tutt’altro discorso per gli statuti corporativi: cfr. ad esempio Statuti dell’Arte della lana di Prato cit., pp. 65-66, dove si fissano (1321) i compensi massimi dei tessitori; P. Rasi - E. Rossi, Statuta scholarum artis et laborantium lanae civitatis Feltri , Milano, 1943, pp. 74, 78, dove si stabiliscono le retribuzioni massime di tessitori, follatori e garzatori (1420 circa). Sulla regolamentazione dei salari a partire dalla metà del XIV secolo cfr. G. Pinto, «Congiuntura economica, conflitti sociali, rivolte», in Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del Trecento. Un confronto , a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze, 2008, pp. 337-349, alle pp. 347-349.
67 Zanazzo, L’arte della lana in Vicenza cit., pp. 104, 299-300. Il provvedimento tuttavia non passò facilmente dal momento che si dice che su di esso «plurimum fuit disputatum».
68 Cfr. ad esempio Franceschi, Oltre il «Tumulto» cit., pp. 280-285.
69 F. Careri, «Il “Presto ai Quattro Pavoni”: dal libro-giornale di Isacco da San Miniato (1473-75)», Archivio storico italiano , CLIX, 2001, pp. 395-421: p. 408 e sgg.
70 Così a Firenze in occasione delle carestie del 1329, 1340 e 1347, con la motivazione che a causa degli alti prezzi del grano «extenuate sunt divitie singulorum et precipue pauperum et miserabilium personarum, ita quod non possunt ad presens suis respondere creditoribus»: G. Pinto, Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del ‘200 al 1348 , Firenze, 1978, pp. 147-148. Provvedimenti simili sono attestati anche nella Firenze del ‘500: Fanfani, Storia del lavoro in Italia cit., p. 375, delibera del 1562 a favore dei tessitori.
71 Pinto, Il lavoro, la povertà, l’assistenza cit., pp. 156-158.
72 Pinto, Il Libro del Biadaiolo cit., p. 124.
73 Naturalmente si tratta di un fenomeno non solo italiano. L’intervento delle autorità pubbliche per disciplinare e incrementare la produzione laniera (e più in generale tessile) è comune a molte realtà politiche europee del tempo, come mostrano molti dei saggi raccolti in Produzione, commercio e consumo dei panni di lana cit., ai quali, in relazione a Valencia, merita aggiungere J. Bordes García, Desarrollo industrial textil y artesanado en Valencia de la conquista a la crisis (1238-1350) , Universitat de València, Facultat de Geografia i Història, Tesis doctoral dirigida por Paulino Iradiel e Enrique Cruselles, Valencia, 2003, pp. 162, 646-658 (Ordinanza del 1311), e per l’intera area catalana-aragonese, G. Navarro Espinach, «La política del desarrollo de las manufacturas textiles en la Corona de Aragón», in Il governo dell’economia. Italia e Peniscola iberica nel basso Medioevo , a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma, 2014, pp. 285-308. Per altro il tema della manifattura tessile ritorna spesso nella produzione scientifica di Paulino Iradiel –sia in riferimento alla penisola iberica, sia con considerazioni di carattere generale e di metodo– a partire dalla monografia Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI . Factores de desarollo, organización y costes de la producción manufacturera en Cuenca , Salamanca, 1974.
74 A. Stella, «Ciompi… gens de la plus baisse condition… crasseux et dépenaillés»: désigner, inférioriser, exclure», in Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités , a cura di P. Boglioni, R. Delort e C. Gauvard, Paris, 2002, pp. 145-152.
75 De La Roncière, «Pauvres et pauvretè à Florence» cit., pp. 685-691; R. De Roover, «Labour conditions in Florence around 1400: theory, policy and reality», in Florentine Studies cit., pp. 277-313, alle pp. 282-286.
76 Passo citato in B. Geremek, «Il pauperismo nell’età preindustriale (secoli XIV-X-VIII)», in Storia d’Italia , volume quinto, I documenti , I, Torino, 1973, pp. 667-698, a p. 683. È interessante ricordare che Antonino fu tra i promotori della compagnia dei «Buonuomini di San Martino», che aveva il compito di assistere i cosiddetti ‘poveri vergognosi’, soprattutto artigiani caduti in miseria, tra i quali numerosi erano i tessitori: si veda M. Fubini Leuzzi, «L’arcivescovo e la città. I Buonomini di San Martino», in Antonino Pierozzi. La figura e l’opera di un santo arcivescovo nell’Europa del Quattrocento , a cura di L. Cinelli e M. P. Paoli, Firenze, 2012 ( Memorie Domenicane , 129, 2012, pp. 141-166, alle pp. 149-152).
Читать дальше