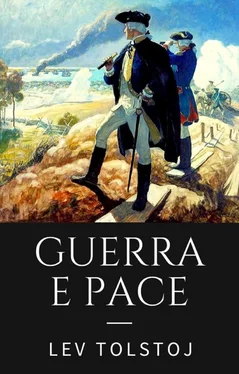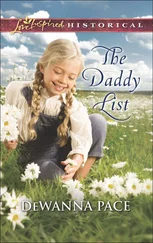— Oh, oh! ecco che manda un’altra boccata! – diceva sottovoce e parlando a sè stesso. – Adesso, chiappa il volante e rimandalo con la racchetta.
— Che dite, capitano? – domandò un cannoniere.
— Io? niente... Una granata... la nostra Mattea...
Mattea era, in mente sua, l’ultimo dei quattro pezzi, un cannone massiccio, di vecchio modello. Il numero uno del secondo pezzo, un bel giovanotto beone, era per lui, nel suo mondo fantastico, lo zio. Lo guardava più spesso che non gli altri, e giubilava ad ogni suo movimento. Lo scoppiettio dei fucili, giù nel piano, gli pareva il respiro affannoso e tossicoloso di qualcuno. «Eccolo che torna a soffiare!» diceva. Egli stesso poi si figurava di essere alto quanto un gigante, forte come un Ercole, e che con ambo le mani scagliasse le bombe sui Francesi.
— Orsù, Mattea, comare di quest’anima, non mi far cilecca! – pregò, scostandosi dal cannone, quando gli suonò sulla testa una voce estranea, affatto nuova per lui:
— Capitano Tuscin! capitano!
Si voltò spaventato. Era quello stesso ufficiale di stato maggiore, che lo avea scacciato da Grunt, e che ora gli gridava ansimando:
— Che diamine! siete pazzo?... Vi si ordina due volte di battere in ritirata, e voi...
«Ma che si vuole da me?» pensò Tuscin sbigottito; e subito portando due dita al berretto: – Io, – rispose, – niente... io...
Ma l’ufficiale di stato maggiore non finì di dire quel che voleva. Una palla passandogli vicino lo fece curvar sul cavallo. Tacque; poi fece per aprir la bocca di nuovo, e una seconda palla lo arrestò in tronco. Voltò briglia, e via di corsa.
— Ritirarsi! ritirarsi tutti! – gridò da lontano.
I soldati risero. Di lì a due minuti giunse con lo stesso ordine un aiutante.
Era il principe Andrea. Arrivando, la prima cosa che lo colpì fu un cavallo, staccato dalle stanghe, con la gamba spezzata. Nitriva dolorosamente e il sangue gli scorreva a fiotti. Giacevano nell’avantreno vari morti. Due proiettili, uno dopo l’altro, gli volarono sul capo. Un tremito nervoso gli ricercò la spina dorsale. Ma la sola idea di potere aver paura lo rianimò. «Io non posso aver paura» pensò, e nel punto stesso smontò di sella in mezzo ai cannoni. Comunicò l’ordine e non si allontanò dalla batteria. Decise di smontare i pezzi da sè e di assistere alla loro rimozione. Insieme con Tuscin, scavalcando i cadaveri, sotto il fuoco terribile dei Francesi, si mise all’opera.
— Or ora è stato qui un superiore, – disse un artigliere, – ed è scappato come il vento... Vostra signoria no...
Con Tuscin il principe Andrea non barattò parole. Eran così occupati tutti e due, che pareano non vedersi l’un l’altro. Posti sull’avantreno due cannoni ancora servibili, abbandonati un obice e un cannone scoppiato, si mossero. Allora il principe Andrea si accostò a Tuscin.
— Orsù, a rivederci, – e gli porse la mano.
— A rivederci, amico mio, – disse Tuscin, – cuor d’oro, angelo, addio! – e le lagrime, chi sa perchè, gli vennero agli occhi.
Cadde il vento, calò una nera nuvolaglia sul campo della strage, confondendosi all’orizzonte col fumo della polvere. Le ombre della notte si addensarono, e più vivido spiccò nei due campi il rosseggiar dei fuochi. Il rombo del cannone divenne più rado, ma a destra e a sinistra era più fitto e più vicino il crepitio dei fucili. Uscito appena di sotto al fuoco, passando coi suoi pezzi accanto ai feriti e sui feriti, Tuscin arrivò in basso, e incontrò generali e aiutanti, fra i quali l’ufficiale di stato maggiore e Gercow, due volte mandato e nessuna delle due arrivato alla batteria di Tuscin. Tutti, nessuno escluso, interrompendosi e parlando in coro, davano ordini e contrordini, dove e come andare, e fecero a lui appunti e rimproveri. Tuscin taceva, avea paura di parlare, poichè ad ogni parola si sentiva pronto a piangere, senza saper perchè. Se ne veniva indietro mogio mogio sulla sua rozza del treno. Benchè ci fosse ordine di abbandonare i feriti, molti di questi si trascinavano dietro le truppe e supplicavano che si dessero loro le armi. Quel medesimo ufficiale di fanteria, che prima dell’attacco era uscito, marzialmente impetuoso, dalla baracca di Tuscin, fu disteso, con una palla nel ventre, sull’affusto di Mattea. Lungo la via un alfiere degli ussari, pallido e disfatto, reggendosi una mano con l’altra, si accostò a Tuscin e pregò che lo si lasciasse sedere anche lui.
— Capitano, per amor di Dio, ho una mano slogata, – disse timidamente. – Per amor di Dio, non posso dare un passo, per amor di Dio! – Si vedeva che anche altri avea supplicato e che sempre gli si era risposto con un rifiuto. Pregava con voce incerta, pietosa, – Fatemi mettere sull’affusto, per amor di Dio!
— Sedetevi, accomodatevi, – disse Tuscin. – A te, zio, stendi il cappotto, – si volse al suo soldato favorito. – E dov’è l’ufficiale ferito?
— Scaricato... è morto, – rispose qualcuno.
— Su, aiutate questo giovane... Accomodatevi, caro... Stendi per benino il cappotto, Antonow.
L’alfiere era Rostow. Gli tremava dal ribrezzo della febbre la mascella inferiore. Lo adagiarono su Mattea, quello stesso pezzo dal quale aveano scaricato l’ufficiale morto. Il cappotto disteso era inzuppato di sangue, e Rostow n’ebbe bruttati i calzoni e le mani.
— Siete ferito, caro? – gli domandò Tuscin.
— No, contuso.
— E che è quel sangue?
— Gli è per dato e fatto dell’ufficiale, capitano, – rispose un artigliere, asciugando il sangue con la manica e quasi scusandosi per la poca pulizia del pezzo.
Con l’aiuto della fanteria e dopo grandi sforzi, fu trascinato il cannone su per l’erta. Raggiunsero il villaggio di Guntersdorf. Era già così scuro, che a dieci passi non si distinguevano le uniformi. La fucilata a poco a poco si faceva più rada. Di botto, sul fianco destro, grida, scoppi, lampi di scariche. Era l’ultimo attacco dei Francesi, al quale si rispose dalle case del villaggio, abbandonandole subito dopo. Ma i pezzi di Tuscin non si poteano muovere, e gli artiglieri, Tuscin e l’alfiere si guardavano in silenzio, aspettando la loro sorte. Tacque la fucilata. Da una via laterale sbucarono in frotta soldati, che animatamente discorrevano.
— Come va, Petrow? sei ferito? – domandava uno.
— Ne han toccate, camerata! Adesso, ti dico io che non ci tornano...
—Non ci si vede una maledetta! Figurarsi che tiravano sui loro... Buio pesto... C’è un gocciolo da bere, eh?
Per l’ultima volta, i Francesi erano stati respinti. Di nuovo, nelle tenebre, i cannoni di Tuscin si mossero, circondati da una cornice mobile e mormorante di fantaccini.
Una specie di fiume tenebroso, appena visibile, scorreva nell’ombra sempre nella stessa direzione, con uno strepito confuso di bisbigli, discorsi, ruote, zampe ferrate. Su tutti i suoni spiccavano acuti e prolungati i gemiti dei feriti, che parevano empire ed impregnar di sè tutta quella nera atmosfera notturna che avvolgeva le truppe. I gemiti e l’ombra della notte erano una cosa sola. Di lì a qualche momento, un’agitazione si produsse nella folla scorrente. Qualcuno, sopra un cavallo bianco, con folto seguito, era passato, e avea dato degli ordini.
— Che ha detto? Dove si va adesso? Si fa alto? Ha ringraziato forse? – si levavano ansiose domande da ogni parte, e tutta la massa si accalcò su sè stessa, poichè le prime file s’erano arrestate. Tutti si fermarono, di mutuo consenso, nel mezzo della strada fangosa.
Si accesero i fuochi, si fecero più alte le voci. Il capitano Tuscin, disposta la sua compagnia, mandò un soldato a cercare il posto d’ambulanza o un qualunque dottore per l’alfiere degli ussari. Si accoccolò poi davanti alla fiamma. Rostow, a stento, gli si trascinò vicino. Il freddo, l’umido, il dolore, lo faceano tremare a verga a verga. Un sonno prepotente gli chiudeva le palpebre, ma il tormento della mano che non trovava posizione acconcia, gl’impediva di dormire. Ora serrava gli occhi, ora guardava al fuoco che gli pareva scarlatto, ora alla figura tarchiata e debole di Tuscin. I grandi e buoni occhi del piccolo capitano l’osservavano con interesse e con simpatia. Si vedeva che Tuscin con tutta l’anima avrebbe voluto aiutarlo, e non poteva.
Читать дальше