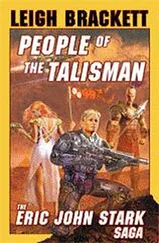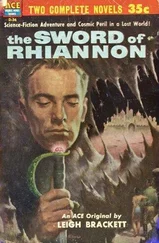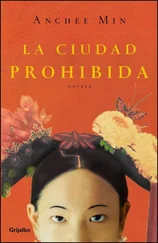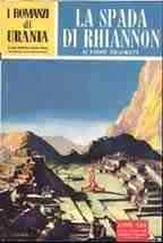«Non sei pronto?» domandò a Len. «Be’, sbrigati, con questa neve arriveremo tardi lo stesso!»
La testa di Hostetter spuntò dalle coperte.
«Cos’è tutta questa fretta?»
«Clementina!» esclamò Esaù, come se quella parola avesse spiegato tutto. «La grande macchina. La provano stamattina, ed Erdmann ha detto che possiamo assistere alla prova, prima di metterci al lavoro. Avanti, fa’ presto!»
«Lasciami infilare gli stivali, almeno,» brontolò Len. «Clementina non scapperà via».
Hostetter disse a Esaù:
«Speri di riuscire a lavorare su Clementina, un giorno o l’altro?»
«No,» disse malinconicamente Esaù, scuotendo la testa. «Occorre troppa matematica, troppa preparazione. Imparerò tutto sulla radio, invece. Dopotutto, è stata la radio a portarmi qui. Ma voglio veder pensare quel grosso cervello meccanico a tutti i costi! Sei pronto, Len, adesso? Sicuro? Va bene, andiamo!»
Il mondo era bianco, e cieco. La neve cadeva diritta, senza un alito di vento che la agitasse, e così dovettero cercare a tentoni la strada attraverso il villaggio, dove si potevano ancora seguire i sentieri scavati nella neve, intuendo la presenza delle case, più che vederle. Fuori, sulla strada, fu molto diverso. Era come nei campi, a casa, quando aveva nevicato così intensamente, senza alcun segno, senza alcuna direzione precisa, e Len fu pervaso dall’antico senso di stordimento. Tutto era scomparso, all’infuori del senso del sopra e del sotto , e presto anche quello spariva, e nel mondo ovattato non rimaneva neppure un suono.
«Stai andando fuori strada,» disse Esaù, e Len ritornò sulla pista appena abbozzata. Poi toccò a Esaù. Camminarono vicini, facendo i consueti commenti sulla malvagità del destino e sull’inclemenza del tempo, e Len disse, improvvisamente:
«Sei contento, qui?»
«Certo,» disse Esaù. «Non tornerei a Piper’s Run nemmeno se me lo regalassi tutto».
Parlava sinceramente. Poi chiese.
«E tu no?»
«Certo,» disse Len. «Sì, certo».
Arrancarono nel mondo bianco, e i freddi fiocchi piumati accarezzavano i loro volti, cercando di riempire la bocca e il naso, e soffocarli silenziosamente, dolcemente, nel loro silenzio bianco, perché la loro presenza turbava la bianca vastità uniforme della via.
«Cosa ne pensi?» domandò Len. «Troveranno mai la risposta? O giungeranno alla Soluzione Zero?»
«Diavolo,» disse Esaù, «E a me cosa importa? Io ho abbastanza cose da fare».
«Non t’importa mai niente?» domandò Len.
«Certo! Quello che voglio fare, a esempio, e il fatto di non avere un branco di vecchi stupidi a dirmi che non posso farlo. Ecco quello che mi importa davvero. Ecco perché sono qui».
«Sì,» disse Len. «Certo». È vero, pensò, puoi fare quello che vuoi e dire quello che vuoi e pensare quello che vuoi… con una sola eccezione. Non puoi dire che non credi in quello che loro credono, e in questo modo, non è poi così diverso da Piper’s Run.
Incespicarono e arrancarono sul bianco pendio, tra i massi rivestiti di bianco, artisticamente disposti in un aspetto di abbandono. Verso metà del pendio, Esaù imprecò e trasalì, e anche Len si fermò un momento, scorgendo confusamente un’indistinta figura scura in movimento, solitaria e furtiva in mezzo a tutto quel biancore.
La forma, parlò, chiamandoli, ed era Gutierrez. La neve si era accumulata sulle spalle e sul berretto, come se l’uomo fosse rimasto immobile per qualche tempo, in attesa. Ma era sobrio, e il suo volto era serio e composto, e amabile.
«Mi dispiace di avervi spaventato,» disse. «Temo di avere dimenticato la mia chiave del cancello. Vi dispiace se entro con voi?»
La domanda era puramente rettorica. I tre proseguirono insieme la strada. Len guardava con malcelato imbarazzo Gutierrez, pensando alle lunghe ore notturne che l’uomo aveva passato tra le carte e la tazza. Sentiva dispiacere per lui, e ne aveva anche un po’ paura. Avrebbe desiderato rivolgergli molte domande sulla Soluzione Zero, e sul motivo per cui non potevano essere sicuri che una cosa esistesse senza prima impiegare cento o duecento anni di lente e faticose ricerche per scoprirlo. Desiderava disperatamente interrogarlo, ma non disse niente. Neppure Gutierrez disse niente. E perfino Esaù parve comprendere la situazione, e tacque.
Dietro il cancello di sicurezza c’era un monticello di neve accumulata in quelle ore, e più avanti il corridoio era scuro e freddo, un luogo che non vedeva mai il sole. Gutierrez li precedette. Quella prima volta aveva incespicato, ma ora camminava con sicurezza, con la testa diritta e le spalle erette. Len sentiva il suo respiro, il respiro un po’ affannoso di un uomo che ha fatto una corsa faticosa, ma Gutierrez non aveva fatto nessuna corsa. Quando il corridoio girò a gomito, e apparvero le luci, lontano, sopra la porta interna, Gutierrez era già molto avanti, e Len ebbe la strana, inquietante impressione che l’uomo li avesse completamente dimenticati.
Lo raggiunsero davanti agli scrutatori, fermandosi per il tempo necessario. Gutierrez fissava direttamente la porta d’acciaio, e quando essa si aprì, egli s’incamminò con decisione lungo il corridoio. Jones uscì dalla stanza di controllo, e lo seguì con lo sguardo, borbottando:
«Cosa sta facendo, qui?»
Esaù scosse il capo.
«È entrato con noi. Ha detto di avere dimenticato la chiave. Immagino che abbia qualche lavoro da svolgere».
Jones scosse il capo a sua volta.
«Erdmann non sarà contento. Oh, be’, nessuno mi ha detto di lasciarlo fuori, quindi ho la coscienza a posto». Sogghignò. «Fatemi sapere che cosa succede, d’accordo?»
«L’altra sera era ubriaco,» disse Len. «Non credo che possa accadere nulla, adesso».
«Lo spero proprio!» protestò Esaù. «Io voglio vedere il cervello in funzione».
Lasciarono i giacconi in un ripostiglio, e si affrettarono a scendere al piano inferiore, passando davanti alle immagini di Hiroshima e delle sue vittime dai tragici, impassibili occhi. Quando furono davanti alla porta, udirono le voci.
«No, mi dispiace, Frank. Te lo assicuro. Lasciamelo dire, ti devo delle scuse».
«Non pensarci più, Julio. Sono cose che capitano a tutti. Ormai è acqua passata».
«Grazie,» disse Gutierrez, con immensa dignità, in tono molto contrito.
Len esitò, davanti alla porta, guardando obliquamente Esaù, il cui volto era il ritratto dell’indecisione.
«Come funziona?» domandò Gutierrez.
«Meravigliosamente,» rispose Erdmann. «Liscia come l’olio».
Le voci tacquero. D’un tratto, Len sentì che il cuore gli balzava in gola, e un freddo nodo di paura gli strinse lo stomaco, perché adesso si udiva una nuova voce nella stanza, una voce che lui non aveva mai udito prima. Una voce piccola, secca, fatta di bisbigli e ticchettii affaccendati, la voce di Clementina.
Anche Esaù la udì.
«Sia come sia, non m’importa,» bisbigliò. «Io entro!»
Entrò, e Len lo seguì, camminando in punta di piedi. Guardò Clementina, e lei non era più addormentata. I molti occhi dei pannelli erano luminosi e ammiccanti, e per tutto quel possente intreccio di fili c’era un’animazione, un brivido, un sottile pulsare di vita.
Lo stesso pulsare, pensò Len, che batte di sotto. Il cuore e il cervello.
«Oh,» disse Erdmann, quasi con sollievo. «Salve».
La velocissima tastiera di risposta ticchettò furiosamente, e Len trasalì violentemente. Gli occhi sui pannelli ammiccarono, come se stessero ridendo, e poi ci fu calma e silenzio, e gli occhi furono di nuovo bui, con l’eccezione di una luce fissa che continuava ad ardere per indicare che Clementina non stava dormendo, era vigile e sveglia.
Esaù respirò, piano. Ma non disse niente, perché Gutierrez fu più veloce di lui a parlare.
Читать дальше