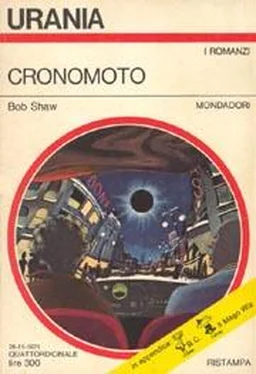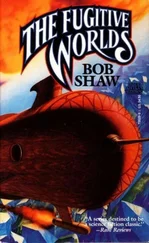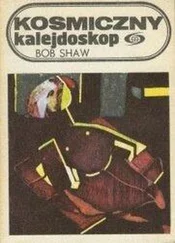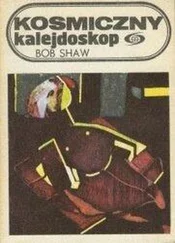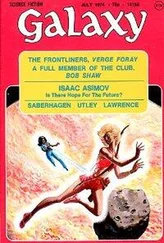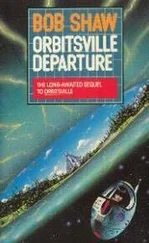— Cosa fai?
— Me ne vado dalla “tua” casa.
— Non ce n’è bisogno.
— Credi?
— No… siamo tutti e due in preda a una forte tensione. Io non…
— Me ne vado! — Kate chiuse la valigia, facendo sbattere il coperchio. — E tu non cercare d’impedirmelo.
— No. — La mente di Breton cominciava a riprendersi dalla paralisi, ad analizzare i suoi errori. Il principale era stato quello di considerare Kate alla stregua di un frutto maturo, che gli sarebbe caduto in mano non appena lui avesse scosso l’albero maritale. — Non so come scusarmi per…
— Avermi picchiato? Non preoccuparti, dopo tutto ti ho picchiato io per prima.
— Non mi lasciare, Kate. Non succederà mai più.
— Vorrei ben vedere! — esclamò lei in tono di sfida. Poi si voltò a guardarlo, quasi sorridente. — Mi prometti una cosa?
— Qualunque cosa vuoi.
— Se John si fa vivo, digli che ho bisogno di parlargli. Sarò su, al lago Pasco.
Breton si sentì mancare. — Dove? Al capanno da pesca?
— Sì.
— Non puoi andarci.
— E perché?
— È… è troppo isolato in questa stagione.
— A volte, preferisco stare sola… È così ora.
— Ma… — Breton annaspava disperato senza riuscire a trovare una scusa valida. — Puoi restare in città. Andare in albergo.
— Mi piace il lago. Per piacere, scostati. — Kate prese la valigia.
— Kate!
Breton sollevò le mani, quasi a formare una barriera, continuando a scervellarsi per trovare qualcosa da dire. Kate avanzò fino quasi a sfiorare quelle mani, poi, improvvisamente, impallidì. Lui la fissava affascinato, leggendo nella sua faccia la conclusione a cui era giunta per intuito.
— Il capanno — mormorò Kate. — John è al capanno.
— Ma è ridicolo.
— Che cosa gli hai fatto? Perché non vuoi che ci vada?
— Kate, dammi retta… non sai quel che dici.
Lei annuì, calma, depose la valigia davanti a lui, e fece per sorpassarlo. Breton l’afferrò per un braccio, e la costrinse a sedere sul letto. Kate si mise a graffiarlo e a scalciare. Mentre cercava di ridurla alla ragione, Jack riuscì finalmente a formulare la menzogna con cui sarebbe forse riuscito a salvare la situazione.
— D’accordo, Kate, hai vinto — ansimò, mentre lei continuava a guizzare e a contorcersi sotto di lui. — Hai vinto. Ti dirò tutto.
— Cos’hai fatto a John?
— Niente. Gli ho dato il mio cronomotore, ecco tutto. È andato al capanno per imparare a usarlo, in modo da poter andare a prendere il mio posto nel Tempo A. L’idea è stata sua. Gli è parso il modo migliore per risolvere la situazione.
— Io ci vado lo stesso! — Kate non si dava per vinta, e per poco non lo fece cadere.
— Mi spiace, Kate… ma non puoi, finché non sarò sicuro che John sia partito.
Anche in quel momento critico, Breton si rendeva conto di quanto fosse debole la sua scusa, ma gli offriva la scappatoia di cui aveva bisogno. Una volta che John fosse morto e atomizzato, nessuno al mondo avrebbe prestato fede a Kate se lo avesse accusato di assassinio. E, intanto, lui avrebbe potuto sopire tutti i sospetti di lei. La certezza nel suo destino, covata per nove anni d’angoscia, si ridestò viva in lui, spazzando via i dubbi sorti in quegli ultimi giorni. Lui aveva creato l’universo del Tempo B, lui aveva creato Kate… e li stringeva ancora in pugno. Per raggiungere lo scopo, gli ci sarebbe voluto un po’ più di tempo del previsto, ecco tutto…
Sollevò la testa un momento dopo la lotta con Kate, e si guardò intorno. La porta di un armadio a muro era rimasta aperta, da quando lei aveva tirato fuori gli abiti. Breton trascinò Kate giù dal letto, la spinse nel vano e richiuse le ante scorrevoli. Dopo averci ripensato, tirò fuori di tasca la lenza e ne avvolse un tratto intorno alle maniglie, trasformando così l’armadio a muro in prigione.
Ansimando pesantemente, e tamponandosi col fazzoletto la faccia graffiata, scese poi di corsa in giardino e montò in macchina. Aveva ancora una cosa da fare, quel giorno.
Una cosa relativamente semplice: proiettare John Breton non nel Tempo A, ma nell’eternità.
Blaize Convery portò alla scrivania una tazzina di plastica piena di caffè e la posò con cura sulla destra. Poi sedette sulla cigolante poltroncina girevole e aprì il cassetto della scrivania. Ne estrasse la pipa, la borsa del tabacco, e un fascio di nettapipe di lana bianca. Depose il tutto sul ripiano, formando un quadrato, con l’aria dell’abile artigiano che sistemi i suoi strumenti di lavoro. Poi aprì un cassetto profondo, ne trasse uno schedario di metallo colorato, lo piazzò al centro del quadrato che aveva preparato con tanta cura, e infine, con un sospiro, incominciò a sfogliarlo.
Era una monotona giornata di routine, in cui aveva camminato molto per tenere dietro a un caso, che, sebbene risolto felicemente un mese prima, si trascinava appresso un groviglio di conseguenze legali. Era salito e sceso di macchina almeno cinquanta volte per riuscire a ottenere tre firme importanti; ora sentiva male alla schiena e aveva i piedi gonfi. Ma era venuta la sua ora, l’ora che poteva dedicare alle sue occupazioni preferite; finito il turno, poteva seguire l’istinto, lungo il fantomatico sentiero che aveva scelto.
Sorseggiò il caffè, riempì e accese la pipa, e si lasciò trasportare nel regno della concentrazione dove le carte ingiallite e i caratteri a carbone sbiaditi sembravano prendere vita e sussurrargli i pensieri più reconditi degli uomini di cui portavano il nome. Dopo qualche minuto, Convery si lasciò andare a uno di quei viaggi a ritroso nel tempo che lo sprofondavano nel passato, e la stanza in cui si trovava incominciò lentamente a svanire.
— Andiamo, Blaize — gli rimbombò una voce nelle orecchie. — Piantala un po’ con questa roba.
Convery alzò gli occhi, facendo uno sforzo per tornare alla realtà, e vide le ciglia sbiadite e i denti radi di Boyd Leland, un altro tenente della Omicidi.
— Ciao, Boyd! — Convery nascose la sua irritazione. Leland era un caro amico e un bravo poliziotto. — Non sapevo che fossi di turno, oggi.
— Infatti non lo sono! — esclamò con aria trionfante Leland. — Questo mese ho il sabato libero, ma non abbandono la squadra. Non sono il tipo io.
Convery lo fissò senza capire per un secondo, poi ricordò. Era il mese di ottobre, e al sabato sera erano ricominciate le partite a bowling.
— Ah, avevo scordato che stasera si gioca — disse, senza entusiasmo.
— Ma certo! Su, andiamo! È ora!
— Senti, Boy! stasera non credo che mi sia possibile…
— Ti stanno facendo consumare il sedere a furia di lavorare? — chiese con aria comprensiva Leland. — La settimana scorsa ho fatto tre… — S’interruppe, guardando lo schedario aperto sulla scrivania di Convery. Lo fissò un momento, poi chiamò con un cenno alcuni colleghi che sostavano sulla soglia.
— Ehi, ragazzi, siamo daccapo! Sapete come passa le sere del sabato il professor Convery? A occuparsi del caso Spiedel! — L’incredulità rendeva acuta la voce di Leland. — Si occupa ancora di quel maledetto caso Spiedel!
— Sono troppo stanco per giocare a bowling, stasera — cercò di schermirsi Convery. — Me ne sto qua a riposare un poco.
— Balle! — Leland allungò le manacce rosse e chiuse lo schedario; dopodiché sradicò Convery dalla poltroncina. — Quest’anno ci occorrono tutti gli uomini di cui possiamo disporre — disse. — E poi, un po’ di esercizio non può farti che bene.
— D’accordo, d’accordo.
Convery capì che non sarebbe riuscito a spuntarla. Mentre gli altri aspettavano, riordinò con rimpianto la scrivania, e poi seguì i colleghi nel corridoio, fino all’ascensore. La gioia rumorosa di tutti gli altri colleghi alla prospettiva di una serata di gioco e birra non fece breccia in lui. “Ieri ho parlato con un uomo colpevole.”
Читать дальше