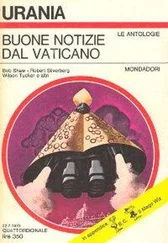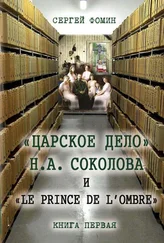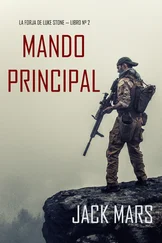Se la cavò abbastanza bene: una voce esile, ma intonata. E mentre io camminavo tra la folla verso lei, la canzone terminò (il pianista diede un taglio netto), e le persone raccolte attorno alla piattaforma applaudirono; ma il movimento delle mani era fiacco, pigro: un applauso ironico. Qualcuno urlò beffardamente: — Brava! — Jan scivolò giù dal pianoforte, e la sua testa si chinò di nuovo su quella del pianista. Lui annuì, con un sorriso rigido sulle labbra, e cominciò a suonare Sweet Sue a ritmo molto molto veloce.
Incredibilmente, Jan si mise a ballare, a ginocchia unite, con piedi e gomiti che piroettavano per aria. Il suo vestito era un arcobaleno in volo. Ed era brava , splendida. I suoi piedi guizzavano a ritmo impeccabile, le dita schioccavano, il viso era alzato verso il soffitto, a occhi socchiusi nell’estasi della danza. Erano spalle e braccia a muoversi di più, e le gambe, ma soprattutto dalle ginocchia in giù. A parte l’ondeggiare dei fianchi, il corpo si muoveva pochissimo, e non si spostava. Si sentivano le sue scarpe strusciare sul parquet, ed era una danza selvaggia, eccitante, primitiva, intrisa di un’innocente sessualità; e dopo che mi fui fatto strada fino all’orlo della piattaforma, restai lì a guardare Jan, arrabbiato, furibondo, e al tempo stesso preda di una ridicola sensazione d’orgoglio per quella stupefacente esibizione.
Il pianista concluse con uno scampanellio di note e un accordo, e quasi tutta la sala applaudì, questa volta in maniera sincera. Una dozzina di voci o più urlarono: — Ancora! — e dicevano sul serio. Jan si stava producendo in una serie di inchini quasi da professionista: prima a sinistra, poi a destra, ruotando lentamente su se stessa per abbracciare l’intero pubblico. Nel girarsi, mi vide intento a fissarla, e si portò sull’orlo della piattaforma, direttamente di fronte a me. — Prendimi, Nick! — disse. E si buttò giù dalla piattaforma, all’indietro, fra le mie braccia. I miei tre bicchieri vuoti si frantumarono sul pavimento.
Non mi permisi di pensare al significato di tutto quello. Non per il momento. Con l’eterno sorriso sulle labbra, appoggiai a terra Jan, le passai un braccio attorno alla vita, e le afferrai il polso sinistro con la sinistra. Con l’altra mano le presi il polso destro, e tenendo le mani basse, nascoste agli occhi degli altri, la guidai (la spinsi a forza, in effetti) tra la gente attorno alla piattaforma che ancora sorrideva e applaudiva. La folla si aprì a malincuore per lasciarci passare. Su quel lato della stanza avevo visto una porta a vetri che dava su uno dei portici laterali, e su una breve scala che portava a un prato. Ci dirigemmo in fretta verso la porta. L’avevamo quasi raggiunta, passando davanti al bar, quando Jan si fermò così di scatto che il suo polso sinistro si liberò. Mi girai a guardarla, continuando a tenere stretto l’altro suo braccio, e lei mi tese il palmo della mano libera. — Dammi venti dollari.
— Fuori — mormorai, in tono dolce, per calmarla. — Andiamo fuori e ti…
— No. — Lei agitò la mano nell’aria, spazientita. — Qui. E subito. O non farò un altro passo.
Osservato da tutti, tirai fuori il portafoglio, trovai un biglietto da venti, e lo diedi a Jan. A quel punto, dovetti lasciarla andare. Lei prese i soldi, girò attorno alla signora dai capelli grigi che la fissava a occhi strabuzzati, e raggiunse il bar. Prese una bottiglia ancora chiusa di gin Gordon, si girò, sbatté i venti dollari davanti alla donna, e, seguita da me, si avviò all’uscita. Sorrideva, soffiava baci d’addio alla sala sorridente, mormorante, incredula.
Sulla Packard, ero talmente confuso che ebbi qualche problema a inserire la chiave nell’avviamento; e quando feci marcia indietro sul sentiero d’accesso, per poco non tamponai l’automobile parcheggiata dietro di noi. Svoltai sulla strada bianca e per mezzo isolato guidai con la faccia incollata al parabrezza, cercando di vedere qualcosa al chiaro di luna, prima di ricordarmi di accendere i fari. Volevo trovare un posticino isolato dove fermarci a parlare; al momento, non riuscivo ad aprire bocca.
Ma la capote era abbassata, l’aria della sera mi rinfrescava le guance, e dopo un po’ avevo ritrovato il controllo della voce. Così dissi: — Jan. — Ma lei mi ignorò. Era alle prese col cerchio di plastica attorno al coperchio della bottiglia che teneva in grembo. Impaziente, cominciò a svitare il tappo senza togliere la plastica. I miei nervi erano molto tesi, e mi venne da strillare: — Per la miseria! — Avevamo raggiunto la campagna più o meno aperta. Alle nostre spalle non c’erano più edifici. Accostai sul ciglio della strada e fermai, con una frenata brusca. — Jan, rispondimi, se no, il cielo mi aiuti, io ti…
Lei mi sorrise dolcemente. — Chiamami col mio nome, e ti risponderò.
Restai a fissarla, ma anche questa volta sapevo; e mi sembrava di sapere da molto tempo. Sapevo chi fosse stato, quel pomeriggio, a comperare il vestito sgargiante con l’orlo della gonna venti centimetri sopra le ginocchia, chi conoscesse quasi tutte le parole di Bye Bye, Blackbird , e chi fosse in grado di ballare il charleston come se lo avesse appena inventato. — Marion?
— Parlerò con l’intero mondo sbronzo. Apri questa maledetta bottiglia, Nickie. Hai bisogno di un goccetto!
Aveva ragione. Afferrai la bottiglia e cominciai a togliere il cerchietto di plastica. L’autista di una Volkswagen di passaggio si girò a guardarci. E tre drink e sei chilometri dopo, sulla serpeggiante strada bianca (avevamo superato i limiti della città e l’ultima delle case, eravamo in piena campagna), sentii il bisogno di un altro sorso. Bevvi, reggendo il volante con una sola mano. Il gin scendeva dalla bottiglia direttamente nella mia gola.
— Passa qui. — Obbedii. Lei tracannò, poi sorrise. — Questa non è roba da due soldi fatta in casa, baby. Questo è vero gin di prima della guerra!
— Dobbiamo parlare. — Un sentierino davanti a noi portava al recinto di un campo, e io rallentai per imboccarlo.
— Sicuro, ma non adesso. Mi sto divertendo. Guida! — Lei appoggiò il suo piede sul mio e pigiò l’acceleratore a tavoletta. L’automobile fece un balzo in avanti, e io sterzai di colpo per non finire diritto nel fossato sotto il sentiero. — Dai gas! Forza con quel motore! — strillò lei. Si girò, si arrampicò sul sedile, andò a sistemarsi sulla capote abbassata. — Iuuuupiiiii! — urlò, e un frammento della mia mente riuscì a notare che stavo sorridendo, e che il mio piede continuava a tenere schiacciato l’acceleratore.
Era pericoloso. Non c’erano argini nelle curve, e la metà posteriore dell’automobile sbandava a ogni svolta. Ma senza rallentare, mi chinai in avanti e con una mano allentai i due grossi dadi ad alette del parabrezza, e abbassai dolcemente il parabrezza sul cofano.
L’aria della sera, fresca e fragrante degli aromi della campagna, mi arruffò i capelli, mi premette gli occhiali contro la fronte e gli zigomi, mi costrinse a socchiudere gli occhi. Imboccammo un’altra curva. Questa volta le ruote posteriori viaggiarono nel vuoto per un metro buono prima di ritrovare il contatto col terreno. Il cuore mi salì in gola per l’eccitazione, e strillai: — Iuuuupiiiiii! — Seduta sulla capote abbassata, Marion sventolava in aria la bottiglia di gin. In quel momento, nei suoi occhi socchiusi c’era un’espressione di piacere totale. Il sorriso sulle sue labbra esprimeva una pura, incosciente, gioia animale.
— Al diavolo gli sbirri! — strillò lei, e bevve una lunga sorsata di gin. La sua gola era candida nel chiarore lunare. Poi mi passò la bottiglia. Io la afferrai e mandai giù quello che restava del liquore senza sollevare il piede dall’acceleratore. Un albero stava correndo verso noi, e io mi sollevai a metà dal sedile, e con tutta la forza del mio braccio scaraventai la bottiglia contro l’albero. Lo centrò in pieno. Si frantumò in un modo splendido. Schegge di vetro volarono via come punte di ghiaccio, e tutti e due lanciammo un ululato di gioia. Mi sentivo libero e selvaggio, come non ero più stato dall’infanzia, più di quanto ricordassi possibile.
Читать дальше