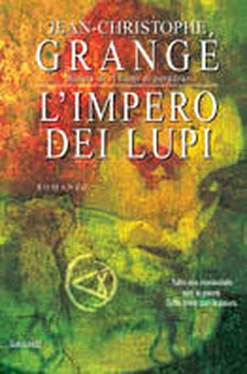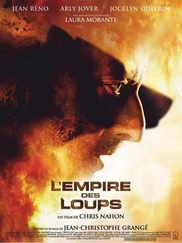Sul marciapiede opposto, una vetrina mostrava un ritratto colorato. Anna attraversò la strada. Era la riproduzione di un quadro. Un viso sconvolto, distorto, pesto, dai colori violenti. Avanzò ancora, come ipnotizzata: quella tela le ricordava, tratto per tratto, le sue allucinazioni.
Cercò il nome del pittore. Francis Bacon. Un autoritratto del 1956. Al primo piano di quella galleria era in corso una sua personale. Qualche porta più in là, a destra, in rue de Téhéran, trovò l’entrata e salì le scale.
Le sale bianche erano separate tra loro da pesanti tendaggi rossi che davano alla mostra un carattere solenne, quasi religioso. Davanti ai quadri si accalcava una folla cospicua. Ciononostante, regnava un silenzio assoluto. Lo spazio era riempito da una sorta di gelido rispetto, un rispetto imposto dalle opere stesse.
Nella prima sala, Anna scorse delle tele alte due metri che rappresentavano tutte lo stesso soggetto: un ecclesiastico seduto su di un trono. Vestito di porpora, egli urlava come se friggesse sulla sedia elettrica. Una volta era dipinto in rosso; un’altra volta in nero; un’altra ancora in blu violetto. Ma c’erano dettagli che tornavano sempre. Le mani strette sui braccioli, già bruciate, come incollate al legno carbonizzato. La bocca urlante, aperta su di un buco che somigliava a una ferita, mentre da ogni parte si alzavano fiamme violacee…
Anna oltrepassò la prima tenda.
Nella stanza seguente, degli uomini nudi, raggomitolati, erano intrappolati da pozze di colore o da gabbie primitive. I loro corpi attorcigliati, deformi, evocavano quelli di bestie selvatiche. O quelli di creature zoomorfe frutto di incroci tra specie molteplici. I loro volti non erano altro che rosoni scarlatti, grugni sanguinanti, facce tranciate. Dietro quei mostri, le pennellate ricordavano le piastrelle di una macelleria o di un mattatoio. Un luogo di sacrificio dove i corpi venivano portati allo stato di carcasse, di masse scorticate, di carogne. Il tratto era sempre tremolante, agitato, come immagini di un documentario ripreso con la macchina a spalla, mosse per la fretta.
Anna sentiva crescere il suo malessere, ma non trovava quello che era venuta a cercare: i volti della sofferenza.
La attendevano nell’ultima sala.
Una dozzina di tele di dimensioni più modeste, protette da cordoni di velluto rosso. Ritratti violenti, lacerati, smembrati: caos di labbra, di nasi, d’ossa o di occhi che cercavano disperatamente la loro strada.
I quadri erano raggruppati in trittici. Il primo, intitolato Tre studi della testa umana , era datato 1953. Facce blu, livide, cadaveriche, che mostravano le tracce delle prime ferite. Il secondo trittico appariva come la naturale continuazione del precedente, raggiungendo un più alto livello di violenza: Studio per tre teste , 1962. Volti bianchi che si sottraevano allo sguardo per risaltare con maggior forza e mostrare le loro cicatrici sotto un cerone da clown. Oscuramente, quelle ferite sembravano voler far ridere, come accadeva nel medioevo quando si sfiguravano i bambini per farne dei pagliacci, dei buffoni senza via d’uscita.
Anna avanzò ancora. Non riconosceva le sue allucinazioni. Semplicemente era circondata da maschere d’orrore. Le bocche, gli zigomi, gli sguardi volteggiavano, avvitando le loro difformità in spirali insostenibili. Sembrava che il pittore si fosse accanito su quei visi. Li aveva attaccati, tagliuzzati con le armi più affilate. Pennellò, pennellessa, spatola, coltello: aveva aperto tutte le ferite, raschiato le croste, lacerato le guance…
Anna camminava con la testa incassata tra le spalle, piegata dalla paura. Guardava le tele con rapide occhiate, a tratti, con le palpebre che fremevano. Una serie di studi dedicati a una certa «Isabel Rawsthorne» segnava il culmine della crudeltà. La faccia della donna era letteralmente esplosa. Anna indietreggiò, cercando disperatamente un’espressione umana in quell’ammasso di carni. E invece trovava solo frammenti sparsi, bocche-ferite, occhi fuori dalle orbite, occhiaie rosseggianti come tagli.
All’improvviso cedette al panico e fece dietrofront, affrettandosi verso l’uscita. Stava attraversando l’atrio della galleria, quando, posato su un bancone bianco, scorse il catalogo della mostra. Si fermò.
Doveva vederlo, doveva vedere il suo viso.
Sfogliò febbrilmente il volume, vide le fotografie dell’atelier, le riproduzioni delle opere e alla fine trovò un ritratto dello stesso Francis Bacon. Una foto in bianco e nero, dove lo sguardo intenso dell’artista brillava più intensamente della carta argentata.
Anna piazzò bene le sue mani sulle pagine, per affrontarlo.
I suoi occhi erano infiammati, avidi, in una faccia larga, quasi lunare, sostenuta da solide mascelle. Naso corto, capelli ribelli, la fronte come una falesia; così si completava il viso di quell’uomo che sembrava essere fatto apposta per tenere testa ogni mattina alle masse scorticate dei suoi quadri.
Ma fu soprattutto un dettaglio ad attirare l’attenzione di Anna.
Il pittore aveva un’arcata sopraciliare più alta dell’altra. Un occhio da rapace, fisso, stupefatto, spalancato su un punto preciso. Anna capì l’incredibile verità: Francis Bacon assomigliava fisicamente alle sue tele. La sua fisionomia condivideva la loro follia, le loro distorsioni. Era stato quell’occhio asimmetrico a ispirare al pittore le sue visioni deformi? O, al contrario, i quadri avevano finito per sconvolgere il loro autore? In un caso come nell’altro, le opere si fondevano con il volto dell’artista…
Quella semplice constatazione fu come una rivelazione.
Se le deformità delle tele di Bacon avevano un’origine reale, perché le sue allucinazioni non avrebbero dovuto avere anch’esse un fondamento di verità? Perché i suoi deliri non avrebbero potuto originare da un segno, da un dettaglio realmente esistente?
Fu gelata da un nuovo sospetto. E se dal fondo della sua follia lei avesse ragione? Se Laurent, se il Signor Velluto, avessero realmente cambiato volto?
Si appoggiò contro il muro e chiuse gli occhi. Ogni cosa andava al suo posto. Laurent, per un motivo che non riusciva a immaginare, aveva approfittato della sua amnesia per cambiare i propri tratti. Aveva fatto ricorso alla chirurgia estetica per nascondersi all’interno del proprio viso. Il Signor Velluto aveva effettuato la stessa operazione.
I due erano complici. Avevano compiuto insieme un’azione atroce e, per questo motivo, avevano cambiato fisionomia. Ecco perché provava disagio di fronte ai loro volti.
Con un fremito passò sopra a tutte le impossibilità, a tutte le assurdità che quel ragionamento comportava. Sentì semplicemente che stava sfiorando la verità, per quanto demenziale potesse sembrare.
Era il suo cervello contro gli altri.
Contro tutti gli altri.
Corse verso la porta. Sul pianerottolo scorse una tela che prima non aveva notato, proprio alla fine della scala.
Un ammasso di cicatrici che tentavano di sorriderle.
All’inizio dell’avenue de Messine, Anna trovò un caffè-brasserie. Ordinò una Perrier al banco, poi andò direttamente nel seminterrato, alla ricerca delle pagine gialle.
Aveva già vissuto quella scena, quel mattino stesso, quando in boulevard Saint-Germain aveva cercato il numero di uno psichiatra. Forse era una specie di rituale, un atto da ripetere, come il superamento di cerchi iniziatici, di prove ricorrenti, per accedere alla verità…
Sfogliando le pagine gualcite, cercò la categoria «Chirurgia estetica». Non guardò i nomi, ma gli indirizzi. Le occorreva un medico che avesse lo studio lì vicino. Il suo dito si fermò su una riga: «Didier Laferrière, 12, rue Boissy-d’Anglas.» Se ricordava bene, quella strada era vicino alla piace de la Madeleine, cioè a cinquecento metri di là.
Читать дальше