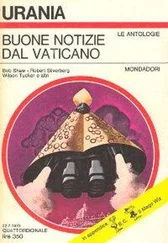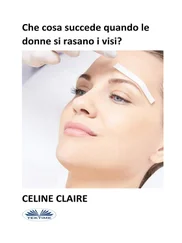Caddi bocconi sul pavimento della cella mentre la porta cigolante veniva chiusa a doppia mandata.
Il sangue formicolava nelle mie mani intorpidite. Tutto intorno a me era silenzio, quasi che la stanza fosse insonorizzata. Mi colse il sospetto di trovarmi in una delle vecchie celle di tortura usate sotto il franchismo. Se avevano intenzione di spaventarmi ci stavano riuscendo benissimo. Per fortuna potevo contare su Oscar e Gloria. I miei due amici nutrivano un’antipatia inveterata per lo stato, la polizia e i loro metodi fascisti: avrebbero fatto fuoco e fiamme per tirarmi fuori di lì. Inizialmente si sarebbero serviti delle vie e dei diritti previsti dalla legge, ma se si fosse reso necessario non avrebbero esitato a usare le foto pornografiche del ministro e della sua amante come strumento di pressione.
Quel pensiero mi rincuorò vagamente, mentre a fatica mi rimettevo in piedi e raggiungevo il tavolaccio accostato a una delle pareti. Ero vittima di un tentativo di intimidazione. Che prove potevano avere contro di me? Non avevano nemmeno seguito la procedura che prevedeva che fossi fotografato e si rilevassero le mie impronte digitali.
Dal soffitto pendeva una lampadina anch’essa chiusa in una gabbia metallica. Le pareti, nude e color giallo sporco non riportavano scritte né incisioni. Un buco in un angolo fungeva da gabinetto. C’erano un lavandino sporco di ruggine e un tavolino fissato al muro con dei bulloni. Ai piedi del tavolaccio su cui sedevo giaceva una coperta lisa ripiegata. Non mi avevano tolto né la cintura, né il pettine, né i lacci delle scarpe. Forse non gli sarebbe importato se mi fossi suicidato. Probabilmente sarebbero stati addirittura contenti. Mi stesi supino, raccolsi le ginocchia contro il petto e provai a volgere lo sguardo all’interno. Gradualmente, il mio cervello si svuotò, il respiro si fece regolare, il dolore ai polsi e alle ginocchia si placò e percepii soltanto il puntino luminoso in mezzo ai miei occhi. Raggiunsi quel nada , o wa , che Suzuki mi aveva insegnato a trovare.
Quando verso sera vennero a prendermi, ero affamato e assetato, ma il mio spirito era tranquillo e battagliero. Erano gli stessi due agenti del pomeriggio, più un secondino grasso. Senza rimettermi le manette, gli agenti si limitarono ad afferrarmi saldamente per i gomiti. Dissi loro che dovevo chiamare un avvocato oppure casa, ma non risposero. Mi condussero in una stanza al piano superiore e mi sistemarono contro una parete bianca.
Era arrivato il momento delle foto e delle impronte. Tutto si svolse in silenzio eccetto che per le istruzioni seccamente impartite da uno degli agenti. Poi mi portarono in una minuscola aula, di fronte al giudice incaricato di stabilire se fosse stato commesso un crimine, se ci fossero le basi per aprire un’indagine sul mio conto o se invece dovessi essere rilasciato.
Il giudice istruttore era un uomo di mezza età. Mi guardava al di sopra di un paio di occhiali da lettura che teneva appollaiati sul naso, che era grosso e sovrastato da due spesse sopracciglia grigie e irsute. Era corpulento e cercava di nascondere i chili di troppo con un abito scuro di buon taglio.
La stenografa evitò di incrociare il mio sguardo.
Gli agenti mi indicarono una sedia e quando fui seduto rimasero in piedi alle mie spalle. Di fronte a me il giudice si avvalse del suo diritto di guardarmi dall’alto in basso, scartabellò tra i documenti che aveva davanti e mi chiese se mi chiamassi Peter Lime, se fossi in possesso del permesso di soggiorno numero tot, e se ero residente in Plaza Santa Ana a Madrid. E se comprendessi la lingua spagnola. Risposi di sì a tutte le domande sforzandomi di mantenere la calma. Una volta confermata la mia identità, dissi:
«Non mi è stato concesso di parlare con un avvocato. Da quando sono stato arrestato ingiustamente non mi hanno dato né pane né acqua. La mia famiglia sarà certamente in preda all’angoscia, si starà chiedendo che fine ho fatto».
Il giudice impassibile replicò:
«Si limiti a rispondere alle domande».
Abbassò brevemente gli occhi sui documenti.
«Si trovava a Llanca, Catalogna, il 3 di giugno.» Poiché la frase era risuonata come un’affermazione piuttosto che una domanda, rimasi in silenzio.
«Ripeto, era a Llanca, in Catalogna, il 3 giugno corrente mese?» Ero nei guai. Il ministro, mi dissi, aveva tentacoli lunghissimi. E mi aveva consegnato nelle mani di un giudice ostile. La sensazione di non avere controllo sulla mia vita mi dava la nausea, mi faceva girare la testa.
«Sì, mi trovavo a Llanca» risposi.
«Conferma l’accusa di aggressione ai danni di un funzionario del Ministero di giustizia e di minaccia nei confronti di un secondo funzionario?»
«Questa non è un’interpretazione corretta dei fatti» obiettai.
«E quella giusta sarebbe?»
«Mi sono difeso da due sconosciuti che hanno cercato di rubarmi le macchine fotografiche e quindi di compromettere il frutto del mio lavoro» risposi.
«Che lavoro fa?»
«Il fotografo.»
«Che cosa ha fotografato quel giorno a Llanca?»
«Non sono tenuto a rivelarlo. Chiedo di poter parlare con un avvocato» mi sforzai di reprimere un improvviso attacco di rabbia.
«Ci sono dei testimoni» disse il giudice istruttore. Il suo viso era completamente inespressivo e gli occhi freddi come pesci morti.
«Chiedo di essere messo a confronto con loro» dissi.
«Sono stranieri. Ci vorrà tempo perché siano rintracciati.»
«E il mio avvocato?»
«Quando sarà il momento.»
«Allora risponderò volentieri a qualunque domanda.»
Lui tornò ad abbassare gli occhi sui documenti:
«Qui risulta che lei pratica da molti anni il karate. Si può dunque affermare che il suo corpo sia un’arma, un’arma letale».
Non avendo colto alcuna sfumatura interrogativa nel tono della sua voce rimasi zitto.
«È vero che lei è cintura nera di karate?»
«Sì, è vero.»
Sul suo volto si disegnò un’espressione di compiacimento. Consultò altri documenti. Avevo l’impressione che faticasse a trovare le domande. Il caso non stava in piedi. Il mio arresto non era che un favore accordato a un amico, un favore cui andava applicata una sottile mano di vernice giuridica.
«Qui risulta che nell’arco degli anni lei abbia avuto ripetuti contatti con membri del gruppo terroristico dell’ETA.»
L’affermazione mi colpì come uno schiaffo.
«Cosa significa?»
«Risponda, è esatto?»
«No!» risposi con foga.
«Ho qui i documenti relativi a diverse intercettazioni, timbrati con la dicitura “segreto”. I contatti ci sono stati.»
«In che anno?»
«Non ha importanza…»
«Invece sì. Gli ex membri dell’ETA con cui sono entrato in contatto esclusivamente per motivi di lavoro, sono stati tutti amnistiati nel 1977» precisai.
Capii che la mia replica aveva colto nel segno. Era tutta una messa in scena, una manovra intimidatoria improvvisata. Erano andati a pescare il mio esile dossier dai loro straripanti archivi segreti, e avevano montato in fretta e furia una farsa che avrebbero faticato a tenere in piedi per più di due giorni.
Il giudice concluse:
«È necessario far luce su questi fatti. Lei verrà trattenuto in isolamento per le settantadue ore previste dalla legge, mentre le indagini proseguiranno. Dopodiché dovrà comparire di nuovo. Questa volta insieme al suo avvocato.»
Incommunicado fu la parola spagnola che usò per «isolamento». Si trattava di una pratica molto diffusa nel sistema giudiziario spagnolo. Dava alla polizia settantadue ore di tempo per produrre il materiale necessario al prolungamento della custodia cautelare, la quale poteva protrarsi per mesi prima di sfociare in un processo o un rilascio definitivo. Cominciavo a innervosirmi sul serio. Nella Spagna democratica esisteva un intricato sistema sommerso di clientelismi che coinvolgeva i personaggi di potere a tutti i livelli, e io avevo gettato lo scompiglio in ambienti molto potenti.
Читать дальше