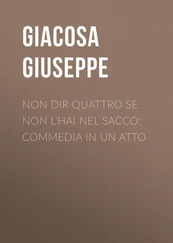Mi misi a correre più forte.
Lo stesso fece lui.
Ci separavano una cinquantina di metri, ma lui doveva portarsi dietro la bambina, quindi avrei potuto raggiungerlo. Il poliziotto di prima gridò: «Alt!», forse per il gusto di cambiare. Speravo proprio che non gli venisse in mente di sparare.
«È tornato sulla strada!» gridai. «Ha con sé mia figlia!»
Non sapevo se mi avevano sentito. Arrivato alle scale, scesi tre gradini alla volta. Ero uscito dal parco e mi trovavo di nuovo in Fort Washington Avenue, all’altezza della rotonda Margaret Corbin. Nel campo giochi non vidi nulla, allora guardai lungo la strada e vidi qualcuno che correva davanti al liceo Madre Cabrini, vicino alla chiesa.
La mente fa strane associazioni, a volte. La chiesa Cabrini è uno dei luoghi più surreali di New York. Zia mi ci aveva trascinato a messa, una volta, per mostrarmi perché quella chiesa era una specie di attrazione turistica. Non tardai ad accorgermene. Madre Cabrini è morta nel 1901 e le sue spoglie imbalsamate riposano all’interno di una specie di blocco di plexiglas. Che fa da altare, nel senso che il sacerdote vi celebra la messa. No, non me lo sto inventando. L’imbalsamatore che ha lavorato sul corpo di Madre Cabrini è lo stesso che ha poi imbalsamato Lenin a Mosca. La chiesa è aperta al pubblico e c’è anche un negozio di souvenir.
Non mi fermai, nonostante mi sentissi le gambe pesanti. Non udivo più i poliziotti. Mi guardai velocemente alle spalle, ma le torce elettriche erano lontane.
«Qui! Vicino al liceo Cabrini!» gridai.
Scattai nuovamente e raggiunsi il portone della chiesa, ma era chiuso a chiave. Dell’uomo con la camicia a scacchi nemmeno l’ombra. Con gli occhi spalancati per il panico, guardai dappertutto, ma invano. Li avevo persi.
«Da questa parte!» gridai ancora, nella speranza di essere sentito dalla polizia o da Rachel, oppure da entrambi.
Ma la disperazione mi travolse. Mi ero lasciato sfuggire un’altra occasione, la mia bambina era nuovamente scomparsa e quel pensiero mi opprimeva come un peso che mi schiacciasse il petto. In quel momento sentii il rombo di un’auto che veniva messa in moto.
Voltai di scatto la testa a destra, e mi rimisi a correre. Un’auto si stava muovendo, a una diecina di metri da me, una Honda Accord. Mi fissai nella mente la targa, pur sapendo che sarebbe stato inutile. L’uomo alla guida stava ancora facendo manovra per uscire dal parcheggio e non riuscivo a vedere chi fosse. Ma non volevo lasciare nulla di intentato.
La Honda aveva appena girato attorno al paraurti dell’auto di fronte e stava per partire quando afferrai la maniglia dello sportello dalla parte del guidatore. Finalmente un po’ di fortuna, la sicura non era inserita. Non ne avevano avuto il tempo per la fretta, pensai.
Nel giro di pochi secondi successero diverse cose. Mentre stavo accanto allo sportello guardai attraverso il finestrino, ed ebbi la conferma che alla guida c’era l’uomo con la camicia a scacchi. Che reagì immediatamente, cercando di impedirmi di salire. Io tirai forte dall’altra parte, lo sportello si aprì di uno spiraglio e lui premette sull’acceleratore.
Tentai di correre di fianco all’auto, come fanno nei film. Il fatto, purtroppo, è che le auto sono più veloci degli uomini. Ma non mi arresi. Ogni tanto si sente di qualcuno che in certe circostanze diventa incredibilmente forte, di uomini normalissimi che riescono a sollevare un’auto per liberare la persona amata, rimasta sotto le ruote. Mi fanno sorridere queste storie, e forse fanno sorridere anche voi.
Io non sollevai l’auto, ma vi rimasi aggrappato serrando come una morsa le dita delle mani attorno al montante tra lo sportello anteriore e quello posteriore. Deciso a non staccarmene per nessuna ragione.
Se rimango attaccato mia figlia vive, se lascio la presa mia figlia muore.
Fregatene della concentrazione, della divisione in compartimenti. Quel pensiero, quell’equazione, era semplice come respirare.
L’uomo con la camicia a scacchi continuò a premere sull’acceleratore e l’auto stava prendendo velocità. Sollevai le gambe da terra, sempre correndo accanto all’auto, ma non c’era alcuna sporgenza sulla quale puntare i piedi, che scivolavano sullo sportello posteriore ricadendo al suolo. Sentii l’asfalto scorticarmi la pelle delle caviglie e tentai nuovamente di tenere i piedi sollevati, ma senza successo. Del dolore, anche se terribile, in quel momento non me ne importava niente.
Ma mi resi conto che quella situazione era insostenibile, che per quanto mi sforzassi di rimanere aggrappato non avrei potuto resistere ancora per molto. Dovevo fare qualcosa. Tentai di infilarmi dentro l’auto, ma non avevo abbastanza forza. Tenni le braccia tese e provai di nuovo a saltare: ora il mio corpo si trovava in posizione orizzontale, cioè parallela al suolo. La gamba destra trovò qualcosa e vi si aggrappò, era l’antenna sul cofano dell’auto. Avrebbe retto al mio peso? Temevo di no. Avevo il viso premuto contro il vetro dello sportello posteriore. Guardai sul sedile.
Era vuoto.
Ancora una volta fui preso dal panico, sentii che le mani stavano perdendo la presa. Avevamo percorso venti, forse trenta metri. Con il viso premuto contro il finestrino e il naso che sbatteva contro il vetro, il corpo e la faccia graffiati e contusi, guardai il piccolo seduto accanto al guidatore e un’atroce consapevolezza mi indusse a staccare le mani dal finestrino.
La mente, come dicevo, a volte funziona in modo strano. Il mio primo pensiero fu quello tipico del dottore: i bambini devono stare seduti dietro. La Honda Accord ha l’airbag anche per il passeggero, e i bambini sotto i dodici anni non dovrebbero sedere davanti. I bambini piccoli, poi, vanno tenuti negli appositi seggiolini. Questo prevede il codice. Se un bambino non è seduto sul seggiolino e sta sul sedile davanti è doppiamente pericoloso.
Un pensiero ridicolo, il mio. O forse naturale. Ma comunque non era stato quello a togliermi la volontà di combattere.
L’uomo con la camicia a scacchi sterzò bruscamente a destra, udii lo stridio degli pneumatici. L’auto sbandò e le mie dita lasciarono la presa. Volai via, letteralmente, e atterrai sull’asfalto rotolando come una pietra. Alle mie spalle udii le sirene della polizia, immaginai che avrebbero inseguito la Honda Accord. Ma non m’importava. Avevo avuto una visione fugace, ma sufficiente per conoscere la verità.
Il bambino nell’auto non era mia figlia.
Mi trovavo un’altra volta in ospedale, questa volta era il New York Presbyterian, dove avevo mosso i primi passi da medico. Non mi avevano ancora portato in radiologia, ma ero sicuro di avere una costola incrinata. In questi casi c’è poco da fare, a parte imbottirsi di antidolorifici. Mi avrebbe fatto male, ma non mi dispiaceva. Ero conciato da fare schifo, sulla gamba destra avevo una lesione che sembrava provocata dai denti di un pescecane. Avevo i gomiti spellati, ma delle mie condizioni fisiche non m’importava nulla.
Lenny arrivò a tempo di record. L’avevo chiamato perché temevo di non essere all’altezza della situazione. All’inizio mi ero quasi convinto di aver preso un abbaglio. Una bambina cambia crescendo, no? E io non vedevo Tara da quando aveva sei mesi, hai voglia a crescere da allora! Ormai doveva aver imparato a camminare. E io ero attaccato a un’auto in corsa, santo cielo, e avevo potuto dare soltanto un’occhiata rapidissima.
Ma lo sapevo.
Il bambino seduto accanto al guidatore sembrava un maschietto, e doveva essere più vicino ai tre anni che ai due. E la sua pelle, il suo incarnato erano troppo chiari.
Non era Tara.
Sapevo che Tickner e Regan avevano delle domande da farmi e avevo intenzione di collaborare. Volevo anche scoprire come diavolo avevano saputo dell’appuntamento per la consegna del riscatto. Non avevo visto Rachel e mi chiesi se fosse lì in ospedale. Mi chiesi anche che fine avessero fatto il denaro, l’Honda Accord, l’uomo con la camicia a scacchi. L’avevano arrestato? Era stato lui a rapire la mia bambina, oppure anche la prima consegna di riscatto era stata un imbroglio? In tal caso, che ruolo aveva avuto mia sorella Stacy?
Читать дальше