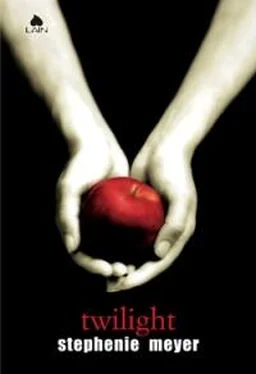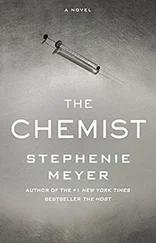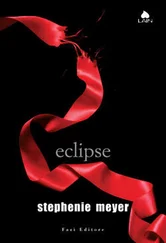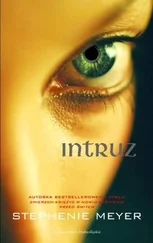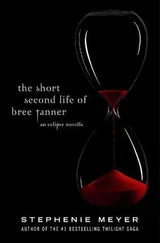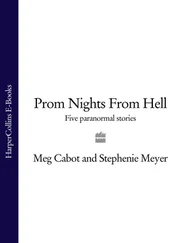Il sole gettava sull’asfalto le ombre oblique delle palme, definite, più aguzze di quanto ricordassi, più chiare di quanto avrebbero dovuto essere. Dietro quelle ombre non poteva nascondersi nulla. L’autostrada luminosa e aperta sembrava un luogo benevolo. Ma non provavo alcun sollievo, non era un vero ritorno a casa.
«Qual è la strada per l’aeroporto?», aveva chiesto Jasper, spaventandomi, malgrado la sua voce bassa e tranquilla. Fu il primo suono, a parte le fusa del motore, a spezzare il lungo silenzio di quella notte.
«Resta sulla I-101», avevo risposto meccanicamente, «e ci passeremo davanti».
Ricordavo come il mio cervello lavorasse lentamente, annebbiato dalla privazione di sonno.
«Prendiamo l’aereo?», avevo chiesto ad Alice.
«No, ma è meglio restare qui vicino, non si sa mai».
Ricordavo che avevamo imboccato la circonvallazione attorno all’aeroporto internazionale di Sky Harbor ma non che ne fossimo usciti. Probabilmente mi ero addormentata in quel momento.
Eppure, dopo aver ripescato i ricordi, mi restava un’immagine vaga di come ero scesa dall’auto - il sole stava per tramontare all’orizzonte - abbrancata alle spalle di Alice, che mi stringeva forte, trascinandomi in mezzo a ombre calde e asciutte.
Non ricordavo la stanza.
Guardai la radiosveglia sul comodino. Secondo le cifre rosse luminose erano le tre in punto, chissà se di notte o di pomeriggio. Dalle tende spesse non trapelava un filo di luce, la stanza era illuminata soltanto dalle lampadine.
Mi alzai, contratta, e barcollai fino alla finestra per guardare fuori.
Era buio. Perciò erano le tre di notte. La mia stanza dava su un tratto deserto di autostrada e sul nuovo parcheggio dell’aeroporto. Fu quasi rassicurante, riuscire a identificare tempo e spazio.
Indossavo ancora gli abiti di Esme e non mi andavano affatto bene. Mi guardai intorno e notai con piacere la mia sacca sopra il letto.
Mi avvicinai per tirarne fuori qualche vestito, ma qualcuno bussò piano alla porta, spaventandomi.
«Posso entrare?», chiese Alice.
Respirai a fondo. «Certo».
Entrò e mi rivolse un lungo sguardo indagatore. «Sembri strapazzata, potresti concederti qualche altra ora di sonno», disse.
Feci cenno di no.
Si avvicinò in silenzio alle tende e le chiuse con cura, prima di rivolgersi di nuovo a me: «Ci toccherà restare al chiuso».
«D’accordo». La voce mi si incrinò; era debole e rauca.
«Hai sete?».
«No, sto bene. E tu?».
«Niente di ingestibile». Sorrise. «Ti ho ordinato qualcosa da mangiare, è di là, nell’altra stanza. Edward ha detto di ricordarmi che voi vi nutrite molto più spesso di noi».
Subito mi sentii più vigile. «Ha chiamato?».
«No», rispose, notando la mia espressione delusa. «È stato prima di partire».
Mi prese per mano con delicatezza e mi guidò nel salotto della suite. Dalla TV arrivava un cupo brusio di voci. Jasper era immobile, seduto alla scrivania nell’angolo, e osservava il notiziario senza il minimo interesse.
Mi sedetti per terra, accanto al tavolino sul quale mi attendeva un vassoio pieno di cibo, e iniziai a mangiucchiare qualcosa, senza neppure badare a cosa fosse.
Alice si appollaiò sul bracciolo del divano e si mise a fissare a vuoto la TV, come Jasper.
Mangiavo piano, guardando lei e lanciando di tanto in tanto un’occhiata a Jasper. Erano immobili, fin troppo. Non staccavano gli occhi dallo schermo, nemmeno quando c’era la pubblicità. Spinsi via il vassoio: improvvisamente avevo la nausea. Alice si voltò verso di me.
«Cosa c’è che non va, Alice?», le chiesi.
«Niente». I suoi occhi erano grandi, sinceri... ma non mi fidai.
«Cosa facciamo adesso?».
«Aspettiamo la telefonata di Carlisle».
«Avrebbe già dovuto chiamare?». Quasi centro. Lo sguardo di Alice incrociò il mio e per un istante schizzò sul telefono, sopra la borsa di pelle.
«Cosa significa...», la voce mi tremava, faticavo a controllarla, «che non ha ancora chiamato?».
«Significa soltanto che non hanno niente da dirci». Ma la sua voce era troppo piatta, e l’atmosfera troppo tesa.
Immediatamente Jasper affiancò Alice, avvicinandosi a me più del solito.
«Bella», disse, con una voce dolce, fin troppo sospetta, «non c’è niente di cui preoccuparsi. Qui sei al sicuro, fidati».
«Questo lo so».
«E allora, perché hai paura?», chiese perplesso. Poteva percepire le mie emozioni, ma non riusciva a coglierne l’origine.
«Hai sentito anche tu cos’ha detto Laurent». La mia voce era un flebile sussurro, ma di certo riuscivano a sentirla. «Ha detto che James è letale. E se qualcosa non funziona, se si dividono? Se succede qualcosa a uno qualsiasi di loro, Carlisle, Emmett... Edward...». Restai senza fiato. «Se quella femmina selvaggia fa del male a Esme...». Nella mia voce risuonò una nota più stridula, isterica: «Come potrei vivere sapendo che è colpa mia? Nessuno di voi dovrebbe rischiare così tanto per me...».
«Bella, Bella, smettila». Jasper parlava troppo in fretta, quasi non lo capivo. «Ti preoccupi delle cose sbagliate. Credimi, se ti dico che nessuno di noi rischia niente. Sei già abbastanza sotto pressione: non caricarti del peso di preoccupazioni superflue. Ascoltami», mi rimproverò, perché avevo distolto lo sguardo, «la nostra famiglia è forte. L’unica paura che abbiamo è quella di perderti».
«Ma perché dovreste...».
A interrompermi fu Alice, che mi sfiorò la guancia con le dita fredde: «Edward è rimasto solo per quasi un secolo. Ora ha trovato te. Dopo tutti questi anni passati insieme a lui, certi cambiamenti non ci sfuggono, e lui è diverso, adesso. Pensi che avremmo il coraggio di guardarlo in faccia per i prossimi cent’anni, se ti perde?».
Il mio senso di colpa sbiadiva lentamente, mano a mano che sprofondavo in quegli occhi neri. Malgrado la calma mi stesse invadendo, però, sapevo di non potermi fidare delle mie sensazioni, se c’era Jasper.
Fu una giornata lunghissima.
Restammo nella stanza. Alice chiese alla reception di non preoccuparsi delle pulizie in camera. Le finestre erano sempre chiuse, la TV sempre accesa, benché nessuno la guardasse. I pasti arrivavano a intervalli regolari. Il telefonino argentato che spiccava sopra la borsa di Alice sembrava sempre più gigantesco.
I miei due baby-sitter sopportavano la tensione molto meglio di me. Più diventavo irrequieta e impaziente, più loro si facevano immobili, due statue i cui occhi mi seguivano con spostamenti impercettibili. Mi distraevo memorizzando i dettagli della stanza, le righe colorate dei cuscini: marrone chiaro, pesca, nocciola, oro opaco, e ancora marrone. Di tanto in tanto osservavo le stampe astratte appese alle pareti cercando di identificare delle figure, come facevo da piccola con le nuvole. Vidi una mano blu, una donna che si pettinava, un gatto che si stirava. Ma quando un cerchio rosso chiaro divenne un occhio spalancato, lasciai perdere.
Con l’avanzare del pomeriggio me ne tornai a letto, tanto per fare qualcosa. Speravo che da sola, al buio, avrei potuto dare sfogo alle paure terribili che incombevano ai margini della mia coscienza, frenate dall’attenta supervisione di Jasper.
Ma Alice, come se si fosse stancata anche lei del salotto, mi seguì. Forse aveva ricevuto da Edward istruzioni precise che io ignoravo. Mi sdraiai sul letto, lei si sedette al mio fianco, a gambe incrociate. Sulle prime semplicemente la ignorai, mi sentivo tutt’a un tratto abbastanza stanca da poter dormire. Dopo qualche minuto, però, il panico trattenuto dalla presenza di Jasper iniziò a riaffiorare. Rinunciai all’idea di addormentarmi in fretta e mi raggomitolai su me stessa.
«Alice?».
«Sì?».
Cercavo di mantenere un po’ di calma almeno nella voce. «Secondo te cosa stanno facendo?».
Читать дальше