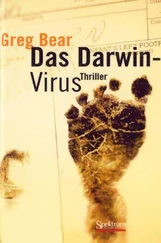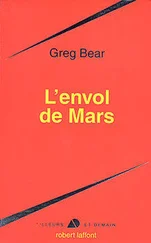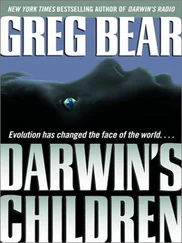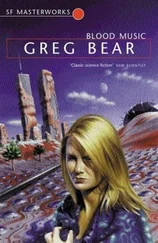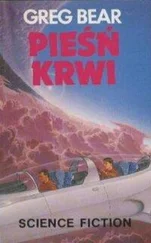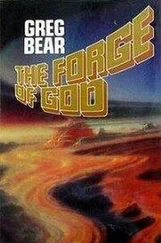Un bernoccolo sulla fronte, una gamba che non voleva piegarsi più molto bene, poco cibo e niente acqua, spaurita, dolorante, e con altri trenta piani da fare. Poi la torcia elettrica sfarfallò e si spense, lasciandola nel buio più completo. — Merda! — disse. Sua madre aveva detestato quella parola quanto il pronunciare il nome di Dio invano. Poiché non erano stati una famiglia molto religiosa quella veniva giudicata un’infrazione minore, oscena solo quando fatta davanti a chi se ne sarebbe offeso. Ma dire merda era peggio, era un’ammissione di cattive maniere e cattiva educazione, o semplicemente il sintomo che si stava cedendo a emozioni degradanti.
Suzy tentò di alzarsi e cadde di nuovo, stordita dalla fitta di dolore che le partiva dal ginocchio. — Merda, merda, MERDA! — gridò. — Non farmi tanto male! Oh, non farmi male! — Provò a massaggiarsi la rotula ma toccarla era peggio che lasciarla stare.
A tentoni cercò la torcia e la recuperò. Dopo qualche colpetto riuscì a farla accendere, e subito girò il raggio attorno per controllare che il lenzuolo marrone e i filamenti non l’avessero raggiunta. Guardò la porta dell’ottandaduesimo piano e seppe che non avrebbe potuto continuare l’ascesa per un po’, forse per il resto del giorno. Vacillò al battente, s’appoggiò alla maniglia e si volse a cercare la radio. Era finita sul pianerottolo inferiore, dopo avere preso alcuni brutti colpi. Per un momento pensò che tanto valeva lasciarla là; ma per la radio rappresentava ancora qualcosa di speciale. Era il solo oggetto umano che le restava, il solo oggetto che le parlava. Frugando nell’edificio avrebbe sempre potuto trovarne un’altra, ma abbandonarla significava rischiare il silenzio. Tenendo rigida la gamba sofferente scese a riprenderla.
Oltrepassare carponi la pesante porta antincendio risultò tragicamente difficile, e si procurò un’altra escoriazione quando il battente le si chiuse su un braccio; infine, però, giacque sul tappeto del corridoio davanti all’ascensore e sospirò, con gli occhi fissi al rivestimento antiacustico del soffitto. Si girò bocconi, tesa a captare ogni movimento.
Silenzio, immobilità.
Pian piano, cercando di dosare le forze, avanzò nel corridoio e girò un angolo.
Al di là di una porta a vetri c’era un vastissimo locale pieno di tavoli da disegno, le cui gambe smaltate poggiavano su una moquette gialla, e da ciascuno di essi si levavano lampade nere come fenicotteri dal collo regolabile. La porta era tenuta aperta da un cuneo di gomma. Barcollò oltre una scrivania e un divano e si appoggiò al più vicino dei tavoli, gli occhi senza espressione per la stanchezza e il dolore. Sul piano c’erano dei disegni tecnici. Quello era l’ufficio di un architetto, dunque. Si chinò a osservare meglio gli schemi e vide che erano gli interni di un’imbarcazione. Lì aveva lavorato gente che disegnava barche. — E che diavolo me ne importa? — gemette fra sé.
Sedette su un alto sgabello fornito di ruote girevoli. Per mezzo minuto armeggiò con un piede sulla leva che sbloccava le ruote, quindi lo usò per avanzare nella fila di centro sfruttando i bordi dei tavoli per spingersi oltre.
Una larga vetrata separava il locale dei disegnatori da un serie di uffici. Si fermò a scrutarli. La paura l’aveva abbandonata, adesso. Fuggendo se l’era lasciata indietro. Il mattino dopo ci sarebbero state altre paure per lei, rifletté, ma intanto ne avava abbastanza. Ora si limitava a osservare.
I cubicoli degli uffici erano pieni di cose in movimento. Erano così strane che per un poco pensò di non saperle descrivere neppure a se stessa. Su e giù per il vetro si spostavano dei dischi dai piedi artigliati, i cui bordi emanavano luce. In un altro cubicolo c’era qualcosa di fluido e senza forma, come cera liquida, che emetteva pseudopodi e bolle bianche; in un terzo si contorcevano dei cavi neri da cui sprizzavano scintille; nel quarto tutto era ricoperto da una sostanza verde fluorescente. Nell’ultimo ufficio una foresta di bastoncelli simili a zampe di gallina, di altezza diversa, si piegavano e oscillavano come sotto l’impatto di un vento irreale.
— È pazzesco — sussurrò. — Questo non ha nessun significato. E se nulla ha senso, allora non sta succedendo nulla.
Spinse lo sgabello a rotelle lontano dagli uffici, fino alla finestra sul lato opposto. Nel resto dei locali sembrava non esserci niente, neppure vestiti vuoti. Visti da quella distanza i cubicoli oltre la vetrata le parvero un acquario di creature esotiche.
Forse lì era al sicuro. Solitamente quello che stava dentro un acquario non ne usciva fuori. Cercò di convincersi che nulla la minacciava, e tuttavia neppure questo le importava più. Per il momento non c’era nessun altro posto in cui potesse andare.
Il ginocchio le si gonfiava, aderendo ai jeans stretti. Pensò che avrebbe potuto tagliare la stoffa, ma poi stabilì che era più saggio levarseli. Con un mugolio scese dallo sgabello e si appoggiò a uno scaffale. In equilibrio su una gamba si slacciò i jeans e contorcendosi un poco li sfilò, togliendone via il ginocchio gonfio con cautela.
Non aveva un brutto aspetto, a parte il lieve gonfiore e una chiazza violacea sotto la rotula. Se lo tastò e le vennero le lacrime agli occhi, non tanto per il dolore quanto per la situazione in cui si trovava. Lì non restava più niente per Suzy McKenzie. Il suo vecchio mondo se n’era andato finché di esso non erano rimasti che nudi edifici, e senza la gente essi erano soltanto scheletri. E presto anche la ragazza di nome Suzy McKenzie se ne sarebbe andata, senza lasciare di sé neanche il ricordo della sua ombra.
Si volse alla finestra che, sopra i bassi scaffali allineati contro la parete, si apriva verso nord.
C’era una nuova Manhattan là fuori, una città-tenda i cui pali erano grattacieli, una città di cubi giocattolo su cui era steso un lenzuolo aderente. Baluginava di un caldo color giallo-miele nel tramonto. Nuova New York, piena di vestiti afflosciati al suolo.
Suzy McKenzie si accovacciò sulla moquette, arrotolò i jeans sotto il ginocchio per tenerlo sollevato e si coprì il volto con le braccia. — Quando mi sveglierò — disse a se stessa, — io sarò Wonder Woman, forte e intelligente. E saprò cosa sta succedendo.
Nel profondo della sua mente, tuttavia, capiva che si sarebbe risvegliata trovandosi abbastanza normale, e che il mondo sarebbe stato sempre il solito.
— Non è una bella prospettiva — mormorò.
Nell’oscurità lunghi filamenti strisciarono avanti sulla moquette, penetrarono negli uffici-cubicolo oltre la vetrata e spensero le bizzarre attività creative dentro di essi.
— Io non appartengo a nessuno. Non sono ciò che ero una volta. Non ho passato. Sono stato liberato da ogni catena e non ho alcun posto dove andare, salvo quello in cui loro vogliono portarmi.
«Ero separato fisicamente dal mondo esterno, e ora lo sono anche mentalmente.
«Il mio lavoro qui è finito.
«Io sto aspettando.
«Sto aspettando.
Davvero tu VUOI viaggiare fra noi, essere fra noi?
— Sì.
Fissa gli occhi sul verde e sull’azzurro e sul rosso del VDT. In quel momento le immagini perdono ogni significato per lui, come se fosse un bambino appena nato. Poi lo schermo, il tavolo che lo sorregge, la tenda della doccia e i muri della camera di contenimento vengono sostituiti da un nulla argenteo.
Michael Bernard sta attraversando un interfaccia.
Egli è codificato.
Non è più conscio delle sensazioni di chi possiede un corpo. Non più movimenti automatici della muscolatura involontaria, non più brontolio di fluidi nell’addome, non più pulsare di sangue e battiti cardicaci. Non più senso dell’equilibrio, tensioni o rilassamenti. È come lasciare una città per entrare di colpo nel cuore di una caverna silenziosa.
Читать дальше