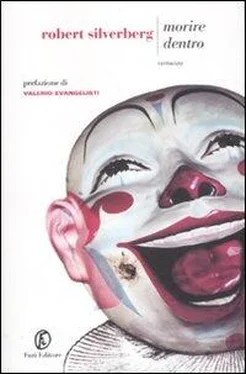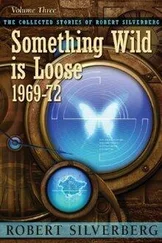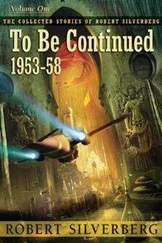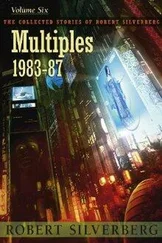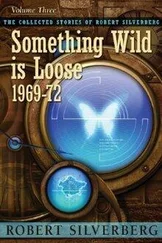Oggi c’è un accenno d’inverno abusivo: l’aria pizzica sulle guance. Ottobre sta morendo troppo presto. Il cielo è screziato e sembra malato, ingombro di nubi fosche, pesanti, basse. Ieri è piovuto, spogliando gli alberi delle ultime foglie gialle, e adesso giacciono lì, appiccicate sul pavimento del viale del College, con le punte che si agitano disordinatamente nella brezza pungente. Ci sono pozzanghere un po’ dappertutto. Appena sistemato accanto alla massiccia forma dell’Alma Mater distendo affettatamente le pagine del giornale, parti scelte dell’edizione di oggi del Columbia Daily Spectator , sui freddi umidi gradini di pietra. Un po’ più di vent’anni fa, quando ero uno studentello scioccamente ambizioso, che sognava la carriera di giornalista — che furbacchione, un reporter che legge nel pensiero! — Spec mi pareva il centro della vita; adesso mi serve soltanto per tenere asciutto il fondo dei calzoni.
Io sto seduto qui. Nelle ore d’ufficio. Sulle ginocchia tengo una cartella in carta di manila, chiusa da una grossa fascia elastica. Dentro, elegantemente battuti a macchina, ognuno fermato con il suo clip in rame, ci sono i prodotti della mia laboriosa settimana. I racconti di Kafka. Shaw come drammaturgo. L’analisi dei concetti sintetici a priori. Odisseo come simbolo sociale. Eschilo e la tragedia aristotelica. Le vecchie bagatelle dell’università, riconfermate nella loro disperata essenzialità fecale dalla buona volontà di questi giovani che permettono a un laureato di vecchia data di stendere la relazione per loro. È questo il giorno fissato per consegnare la merce e, forse, per ricevere qualche nuovo incarico. Cinque minuti alle undici. I miei clienti arriveranno tra poco. Nel frattempo scruto tutta la gente che passa. Studenti frettolosi, con montagne di libri. I capelli scarmigliati dal vento, i petti ansimanti. Tutti quanti mi sembrano spaventosamente giovani, anche quelli che portano la barba. Soprattutto quelli che portano la barba. Ma voi riuscite a credere che ogni anno ci sono sempre più giovani nel mondo? La loro tribù aumenta sempre più di numero e le vecchie merde scivolano giù verso il fondo e io mi avvio verso la tomba. In questi giorni anche i professori mi sembrano giovani. C’è della gente con tanto di dottorato che ha 15 anni meno di me. Questo non è un ammazzare la gente? Immaginate un ragazzo nato nel 1950 che ha già preso il dottorato. Nel 1950 io mi facevo la barba tre volte alla settimana e mi masturbavo ogni mercoledì e ogni sabato; ero un adolescente sano taurino alto un metro e 75, pieno di ambizioni e di angosce e di sapere, avevo un’identità. Nel 1950 quelli che oggi si fregiano di un recente Dott. erano infanti sdentati appena schizzati dal ventre, i volti raggrinziti, la pelle viscidamente ricoperta di succhi amniotici. Com’è possibile che abbiano preso il dottorato così presto? Quei bambocci mi hanno doppiato, e io faccio fatica a tener loro dietro.
La compagnia di me stesso diventa fastidiosa, quando arrivo all’autocommiserazione. Per distrarmi provo a sondare le menti dei passanti, e imparare quel che posso imparare. Gioco al mio vecchio gioco, al mio unico gioco. Selig il voyeur, il vampiro-delle-anime, che strappa l’intimità di estranei innocenti per rallegrare il suo cuore di ghiaccio. Ma no: oggi la mia testa è avvolta nella bambagia. Mi arrivano soltanto mormoni sommessi, indistinti, senza senso. Niente parole ben precise, niente sprazzi di identità, niente visioni dell’essenza dell’anima. Questo è un brutto giorno. Tutto quello che afferro costituisce un insieme inintelligibile; ogni frammento di informazione è identico a tutti gli altri. È il trionfo dell’entropia. Mi viene in mente la signora Moore di Forster, tutta tesa nelle echeggianti caverne di Marabar, in attesa di una rivelazione. E invece riesce a sentire l’identico monotono disturbo, l’identico suono senza senso che spazza via tutto: Bum. La sintesi e l’essenza degli sforzi calorosi dell’intera umanità: Bum. Le menti che mi lampeggiavano dentro mentre passavano sul viale del College adesso mi trasmettevano soltanto: Bum. Forse è tutto quello che merito. Amore, paura, fede, spilorceria, ingordigia, autocompiacimento, ogni forma di monologo interiore, tutto mi arriva sotto la stessa identica forma. Bum. Devo mettermi sotto per modificare questa situazione. Non è troppo tardi per cominciare a far guerra all’entropia. Con gradualità, sudando, lottando, cercando a tentoni dei risultati consistenti, spalanco la mia apertura mentale, lavoro le mie percezioni per spingerle a funzionare. Sì. Sì. Ritornate a vivere! Risuscita, spia miserabile! Dammi quel che mi spetta! I miei poteri stanno agitandosi in me. L’oscurità interiore sta un po’ dissipandosi; frammenti erranti di pensieri isolati ma coerenti trovano il modo di entrare in me. “Nevrotico ma non ancora completamente psicotico. Andare a trovare il capo del dipartimento per dirgli di dargli una spinta. I biglietti per l’opera, però devo andarci. Andare a donne è divertente, andare a donne è molto importante, ma ci sono cose più divertenti e più importanti. Come starsene su un trampolino molto alto prima di spiccare il tuffo.” Questo dissonante caotico cicaleccio non mi dice niente, se non che il potere non è ancora morto, e questo mi conforta molto. Mi raffiguro il potere come una specie di verme attorcigliato attorno al cervello, un povero verme stanco, raggrinzito e tutto accartocciato, la sua pelle una volta bella hicida adesso piena di ulcere con chiazze logore e squamose. Questa è un’immagine relativamente recente, però anche nei tempi più felici ho sempre pensato al potere come qualcosa di staccato da me, un intruso. Un inquilino. Lui e io, io e lui. Ero solito discutere di cose del genere con Nyquist. (Lui è già entrato a far parte di questi sfoghi? Forse no. Si tratta di una persona che ho conosciuto una volta, un certo Tom Nyquist, uno dei miei amici di una volta. Che si portava nel cranio un intruso simile a questo mio). A Nyquist non piaceva il mio punto di vista. — È da schizoide, impostare una dualità simile. Il tuo potere sei tu stesso. Tu sei il tuo potere. Perché cerchi di estraniarti dal tuo stesso cervello? — È probabile che Nyquist avesse ragione, ma è troppo tardi. La dualità, lui e io, sarà così finché non ci separerà la morte.
Ecco il mio cliente, il massiccio mediano, Paul F. Bruno. Ha la faccia tutta gonfia e rossa, e non sorride per niente, come se le bravate di sabato gli fossero costate qualche dente. Io sfilo la fascia elastica ed estraggo I romanzi di Kafka e gli porgo il dattiloscritto. — Sei pagine — dico. Mi aveva anticipato dieci dollari. — Mi devi ancora 11 dollari. Vuoi prima leggerlo?
— È buono?
— Non ti dispiacerà.
— Ti credo sulla parola. — Mi fa una smorfia dolorosa, a bocca chiusa. Tirando fuori il suo portafoglio ben gonfio, mi mette in mano alcuni biglietti di banca. Io mi intrufolo svelto nella sua mente se non altro perché, maledizione, adesso questo mio potere è di nuovo in funzione, una rapida scorsa psichica, e capto i livelli più superficiali: i denti persi durante la partita di pallone, un delizioso lavoretto consolatorio in una casa d’appuntamenti sabato notte, progetti piuttosto vaghi da mandare in porto prima della partita di sabato prossimo, eccetera. Per quel che riguarda la trattativa in atto scorgo senso di colpa, imbarazzo, anche un po’ di risentimento nei miei riguardi, per averlo aiutato. Ma bene: la gratitudine del gentile. Mi metto in tasca i soldi. Lui mi favorisce un secco cenno di assenso e ripone I romanzi di Kafka sotto l’enorme avambraccio. Precipitosamente, con vergogna, si affretta a scendere i gradini e si allontana in direzione dell’Hamilton Hall. Osservo il suo groppone in fuga. Un’improvvisa raffica di vento astioso, proveniente dall’Hudson, da est, mi dà una coltellata e mi penetra nelle ossa.
Читать дальше