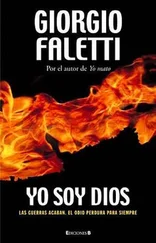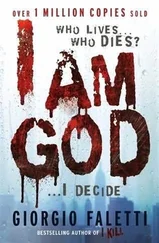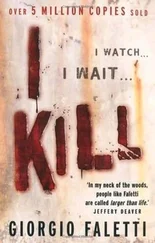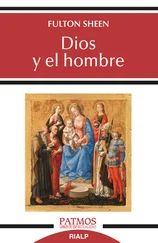Quando l’ho trovata, mi sono chiuso dentro e ho steso il primo articolo. Ci ho messo giusto il tempo di scriverlo, come se qualcuno dietro me mi stesse dettando le parole, come se fossi stato da sempre padrone di quella storia, come l’avessi vissuta mille volte e altrettante volte l’avessi raccontata.
Poi l’ho allegato a una e-mail e l’ho mandato al giornale.
Il resto è storia conosciuta. E quello che manca vedrò di costruirmelo giorno dopo giorno.
Sono passate due settimane dal funerale della sorella di Vivien. Due settimane dall’ultima volta che l’ho vista, dall’ultima volta che ci siamo parlati. Da quel momento la mia vita è salita su una giostra così veloce che le immagini parevano sovrapporsi senza che avessi modo di distinguerle una dall’altra. Adesso è tempo che quel giro si fermi, perché continuo a provare un vuoto che le luci degli studi televisivi e le interviste e le mie foto in prima pagina, questa volta senza vergogna, non possono riempire.
Questa vicenda assurda mi ha insegnato che le parole non del tutto espresse a volte sono più pericolose e più dannose di quelle urlate a piena voce. Mi ha insegnato che l’unico modo per non correre rischi, in certi casi, è rischiare. E che l’unico modo per non avere debiti è non farli.
O pagarli.
Ed è esattamente la prima cosa che farò non appena ritorno a New York.
Per questo sono qui davanti alla tomba di mio fratello e guardo il suo viso che mi sorride. Restituisco quel sorriso, sperando che possa vederlo.
Poi gli dico con tutto l’affetto di questo e dell’altro mondo una cosa che sognavo da anni.
«Ce l’ho fatta, Robert.»
Poi giro le spalle e mi allontano.
Adesso siamo liberi tutti e due.
L’ascensore arriva al mio piano e appena le porte scorrevoli si aprono una cosa mi accoglie e mi sorprende. Sul muro di fronte alla cabina, appesa al muro con del nastro adesivo trasparente, c’è una foto.
Mi avvicino a osservarla.
Il soggetto sono io, di profilo, nell’ufficio di Bellew, con un’espressione assorta e i capelli che danno un poco di ombra al viso. Lo scatto mi ha colta in un attimo di riflessione ed è riuscita a catturare alla perfezione il dubbio e il senso d’inutilità che in quel momento provavo.
Giro la testa e sul muro alla sinistra, appesa sopra il campanello, c’è un’altra foto.
La prendo in mano e nella luce del pianerottolo osservo anche questa con attenzione.
Il soggetto sono ancora io.
Nel salotto della casa di Lester Johnson, a Hornell. Ho gli occhi cerchiati di stanchezza ma un’espressione volitiva, mentre guardo la foto di Wendell Johnson e Matt Corey in Vietnam. Ricordo bene quell’istante. Era un momento in cui tutto sembrava perduto e invece di colpo si è riaccesa la speranza.
La terza foto è appesa sul legno in mezzo alla porta.
Io di nuovo, mentre nella casa di Williamsburg sto studiando per la prima volta i disegni della cartellina. Quando ancora non sapevo che non erano solo delle pessime opere d’arte ma il modo ingegnoso che un uomo aveva trovato per tracciare la mappa della sua follia. Ricordo il mio stato d’animo, in quel momento. Non ero tuttavia cosciente dell’espressione, forse perché a quel punto non ne ero più padrona.
A quel punto mi accorgo che la porta è solo accostata. Spingo la maniglia e il battente si apre con un cigolio.
Sul muro di fronte all’ingresso c’è un’altra foto.
Nella luce incerta che arriva da fuori e si infila nella penombra della casa, non riesco a distinguerla. Immagino che mi raffiguri anche questa.
La luce nel corridoio si accende. Faccio un passo all’interno, più incuriosita che preoccupata.
Giro la testa e qualcosa arriva da chissà dove a prendere possesso del mio stomaco. È enorme e leggero e frulla come tutte le ali del mondo messe insieme, senza possibilità di scelta.
Alla mia destra, in mezzo al salotto, c’è Russell. Mi sorride e mi fa un gesto buffo con le mani.
«Sarò arrestato per violazione di domicilio?»
Prego Dio che non mi faccia dire qualcosa di stupido. E invece, prima che Dio abbia il tempo di intervenire, ci riesco da sola.
«Come hai fatto a entrare?»
Mi mostra il palmo della mano sinistra, sul quale stanno posate le chiavi di casa.
«Con l’altro mazzo. Non te l’ho mai restituito. Almeno non ho l’aggravante dello scasso.»
Mi avvicino e lo fisso negli occhi. Non riesco a crederci ma mi sta guardando come avrei voluto che mi guardasse fin dal primo momento che l’ho visto. Lui si fa da parte e mi indica il tavolo. Giro lo sguardo e vedo che è apparecchiato per due, con una tovaglia bianca di lino e piatti di porcellana e posate d’argento e una candela accesa al centro.
«Ti avevo promesso una cena, ricordi?»
Forse non sa di avere già vinto. Oppure lo sa e mi vuole annientare. In tutti e due i casi non ho nessuna intenzione di fuggire. Non so che espressione ho in viso ma nella confusione in cui sono riesco ancora a pensare che è un delitto non averne una foto.
Russell si avvicina al tavolo e indica i cibi.
«Ecco qua, cena preparata dallo chef preferito di mio padre. Abbiamo aragosta, ostriche, caviale e un sacco di altre cose di cui non ricordo il nome.»
Indica con un gesto elegante una bottiglia in fresco dentro un secchiello.
«Per il pesce abbiamo dell’ottimo champagne.»
Poi prende in mano una bottiglia di vino rosso con un’etichetta colorata.
«E per il resto Il Matto, un grandioso vino italiano.»
Il battito del cuore è arrivato a un limite non superabile e il respiro a un livello in cui è quasi inutile.
Mi avvicino e gli butto le braccia al collo.
Mentre lo bacio sento che tutto passa e tutto arriva nello stesso momento. Che tutto esiste e che niente esiste solo perché lo sto baciando.
E quando lo sento ricambiare il mio bacio penso che morirei senza di lui e forse morirò per lui, ora, in questo momento.
Mi stacco un attimo. Solo un attimo, perché di più non riesco.
«Andiamo a letto.»
«Ma la cena?»
«Al diavolo la cena.»
Mi sorride. Sorride sulle mie labbra e il suo alito è un profumo meraviglioso.
«C’è la porta aperta.»
«Al diavolo anche la porta.»
Arriviamo in camera da letto e per un tempo che pare infinito mi sento sciocca e stupida e puttana e bellissima e amata e adorata e io comando e imploro e obbedisco. Infine resta il suo corpo accanto al mio e un chiarore smorzato oltre le tende e il suo respiro calmo mentre dorme. Allora mi alzo dal letto, infilo l’accappatoio e vado alla finestra. Lascio che il mio sguardo, finalmente senza ansia e senza paura, superi la barriera dei vetri.
Fuori, senza curarsi delle luci e degli uomini, un vento leggero risale il fiume.
Forse insegue qualcosa o forse da qualcosa è inseguito. Ma è piacevole stare qui per qualche istante a sentirlo passare e frusciare tra gli alberi. È una brezza fresca e sottile, di quelle che asciugano le lacrime degli uomini e impediscono agli angeli di piangere.
E io finalmente posso dormire.
La fine di un romanzo è come la partenza di un amico: lascia sempre un poco di vuoto. Fortunatamente, il percorso ne fa rincontrare di vecchi e ne fa conoscere di nuovi. Per cui voglio ringraziare:
– la dottoressa Mary Elacqua di Rensselaer, insieme a Wonder Janet e Super Tony, i suoi adorabili genitori, per avermi accolto a Natale con l’affetto di una persona di famiglia
– Pietro Bartocci, il suo inimitabile marito, l’unica persona al mondo che riesce a russare anche da sveglio e concludere affari nel contempo
– Rosanna Capurso, geniale architetto a New York, dai capelli rosso fuoco e dal senso dell’amicizia che scalda nello stesso modo
Читать дальше