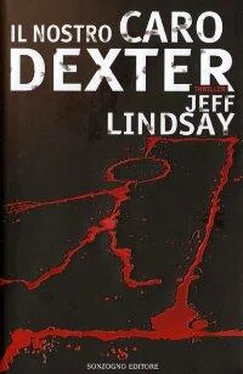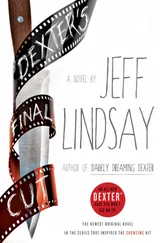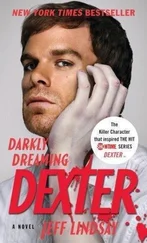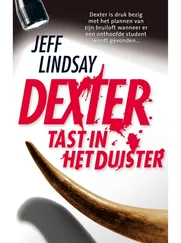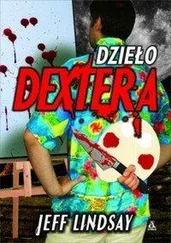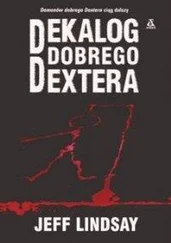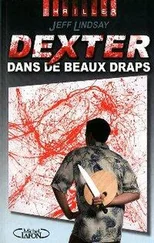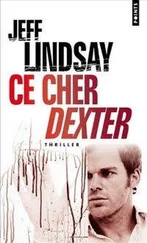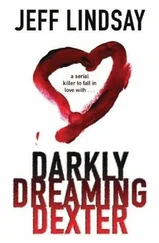Allungò una mano (la destra, ovvio) e mi prese per il braccio. «Ti prego», supplicò. «Non lasciarmi solo.»
«Ci metto un secondo», lo tranquillizzai e cercai di staccarmi. Ma lui aumentò la stretta, ancora sorprendentemente forte dopo quello che aveva passato.
«Per favore», ripeté. «Lasciami almeno la tua pistola.»
«Non ce l’ho», ammisi e lui spalancò gli occhi.
«Oddio, che cosa diavolo aspettiamo? Cristo, dobbiamo andarcene di qui.» Sembrava prossimo al panico, come se a ogni secondo stesse per ricominciare a piangere.
«Va bene», acconsentii. «Adesso alzati in, ehm… piedi.» Sperai che non avesse colto la mia gaffe. Non volevo fare la figura dell’insensibile, ma questa storia degli arti mancanti richiedeva un piccolo restyling al vocabolario. Comunque Chutsky non replicò, si limitò a tendermi il braccio. Lo aiutai a tirarsi su e lui si appoggiò al tavolo. «Dammi solo qualche secondo per controllare le altre stanze», ripetei. Lui mi guardò con occhi umidi e imploranti, ma non obiettò e io feci un rapido giro della casa.
Nella stanza principale, quella in cui avevo trovato Chutsky, non c’era nient’altro da vedere, a parte gli attrezzi da lavoro del dottor Danco. Aveva interessanti strumenti da taglio. Dopo averne attentamente considerato le implicazioni etiche, ne presi uno dei migliori: una splendida lama studiata apposta per tagliare la carne più sottile. C’erano parecchi flaconi di droghe; i loro nomi non mi dicevano quasi nulla, a parte alcune bottigliette di barbiturici. Non trovai nessun indizio, né taccuini spiegazzati con sopra numeri di telefono o bigliettini della lavanderia, nulla.
La cucina era praticamente una copia esatta di quella della prima casa. C’era un piccolo frigorifero che cadeva a pezzi, una piastra, un tavolino con una sedia pieghevole e basta. Sul fornello, una scatola piena per metà di ciambelle con un’enorme blatta che ne sgranocchiava una. Mi guardò, come se fosse pronta a lottare per mantenerne il possesso e io gliela lasciai.
Tornai nell’altra stanza e trovai Chutsky ancora appoggiato al tavolo. «Sbrigati», disse. «Andiamocene, per Dio.»
«Ancora una camera», feci. Aprii la porta di fronte alla cucina. Una camera da letto, come pensavo. In un angolo c’era una branda con sopra un mucchio di vestiti e un cellulare. La camicia mi era familiare e avevo un’idea sulla sua provenienza. Estrassi il mio telefono e feci il numero del sergente Doakes. Il cellulare in cima alla montagna di vestiti cominciò a suonare.
«Ah, ecco», brontolai. Lo spensi e andai a prendere Chutsky.
Era ancora dove l’avevo lasciato, ma si vedeva che se avesse potuto sarebbe scappato via. «Avanti, per Dio, sbrigati», mi implorò. «Cristo, me lo sento quasi ansimare sul collo.» Si voltò verso la porta sul retro, quindi guardò la cucina. Quando mi avvicinai per aiutarlo, i suoi occhi saltarono sullo specchio appeso alla parete.
Restò a lungo a fissare il suo riflesso, poi si lasciò cadere come se le ossa non lo reggessero più. «Gesù», mormorò e riprese a piangere. «Oh, Gesù.»
«Avanti», lo sollecitai. «Muoviamoci.»
Chutsky alzò le spalle e scosse la testa. «Non potevo neanche muovermi, dovevo solo stare qui e sentire che cosa faceva a Frank. Sembrava così contento… ’Indovina… Non lo sai? Va bene allora, un braccio.’ Poi il rumore della sega e…»
«Chutsky», lo interruppi.
«E quando mi coricò qui sopra e disse ’Sette’ e poi ’Indovina’. E dopo…»
Certo, è sempre interessante ascoltare le tecniche altrui, ma sembrava che Chutsky stesse perdendo il controllo che gli era rimasto. Non potevo permettere che si asciugasse un’altra volta il naso sulla mia camicia. Allora mi avvicinai e lo presi per il braccio buono. «Chutsky. Avanti. Usciamo di qui», intimai.
Lui mi guardò come se non sapesse dove si trovava, gli occhi spalancati; si girò un’altra volta verso lo specchio. «Oh, Gesù», ripeté. Poi emise un respiro profondo e incerto e si alzò come se stesse rispondendo a un immaginario squillo di tromba. «Non mi lamento», dichiarò. «Sono vivo.»
«Infatti. E se ce ne andiamo può darsi che lo rimarremo entrambi.»
«Giusto», mormorò. Allontanò con forza la faccia dallo specchio e mi mise il braccio buono sulla spalla. «Andiamocene.»
Naturalmente Chutsky non aveva una grossa esperienza nel camminare su una gamba sola, ma sbuffò e zoppicò, appoggiandosi con forza a me a ogni gradino. Anche se gli mancava qualche pezzo, era ancora un uomo robusto e per me fu davvero dura. Poco prima del ponte si fermò un istante e indicò oltre la rete. «È lì che ha buttato la mia gamba», disse, «agli alligatori. Si è assicurato che stessi guardando. L’ha sollevata in aria perché la potessi vedere, quindi l’ha lanciata e l’acqua si è riempita di bolle come se…»
Percepii una crescente nota isterica nella sua voce, ma se ne accorse anche lui e si zittì. Inspirò, tremando, poi con voce ruvida dichiarò: «D’accordo. Andiamocene di qui».
Tornammo al cancello senza altre digressioni nel viale dei ricordi e, mentre lo aprivo, Chutsky si appoggiò a un palo. Poi lo aiutai a salire davanti, saltai al volante e accesi il motore. Mentre accendevo i fari, Chutsky si accasciò sul sedile e chiuse gli occhi. «Grazie, amico», sussurrò. «Ti sono grato. Grazie.»
«Prego», risposi. Feci manovra e infilai di nuovo Alligator Alley. Credevo che Chutsky si fosse addormentato, ma a metà strada cominciò a parlare.
«Sono contento che tua sorella non sia qui a vedermi in questo stato», disse. «È che… Ascolta, devo davvero rimettermi a posto prima che…» Si interruppe bruscamente e per un po’ tacque. La macchina proseguì sobbalzando per la strada buia, con noi dentro, in silenzio. Il che non mi dispiacque affatto. Mi chiesi dove fosse Doakes e che cosa stesse facendo. O, forse, che cosa gli stessero facendo. A tal proposito, mi domandai dove fosse Reiker e quando avrei potuto portarlo da un’altra parte. In un posto tranquillo, dove avrei potuto meditare e lavorare in pace. Chissà a quanto lo affittavano l’Allevamento di Alligatori Blalock.
«Un’idea potrebbe essere non darle ulteriori preoccupazioni», riattaccò Chutsky all’improvviso e mi ci volle un attimo per capire che stava parlando di Deborah. «Lei non vorrà più stare con me ora che sono ridotto così e io non ho bisogno della pietà di nessuno.»
«Tranquillo», replicai. «Deborah è totalmente priva di pietà.»
«Le dirai che sto bene e che sono tornato a Washington», continuò. «È meglio così.»
«Forse sarà meglio per te», obiettai. «Ma io sarò morto.»
«Tu non capisci…»
«No, sei tu a non capire. Deborah mi ha detto di venirti a riprendere. È stata lei a decidere e io non posso disobbedirle. È molto violenta.»
Chutsky tacque per un po’. Lo sentii singhiozzare. «Non so se me la sento», mormorò.
«Posso riportarti all’allevamento di alligatori», dichiarai allegramente.
Lui non aggiunse altro; io arrivai al fondo di Alligator Alley, svoltai nella strada principale e guidai verso le calde luci aranciate di Miami che brillavano all’orizzonte.
Viaggiammo in silenzio finché non raggiungemmo i primi segni di civiltà, un’area di sviluppo urbano con una fila di centri commerciali sulla destra, a pochi chilometri dal casello. Poi Chutsky si tirò su e guardò le luci e i palazzi. «Mi serve un telefono», disse.
«Puoi usare il mio, se paghi la chiamata», risposi.
«Mi serve un fisso», fece. «Un telefono pubblico.»
«Non sei proprio al passo con i tempi», gli feci presente. «Al giorno d’oggi sono un po’ difficili da trovare. Nessuno li usa più.»
«Usciamo qui», replicò lui. Anche se questo mi allontanava dalla mia meritata notte di riposo, imboccai la rampa. Dopo nemmeno due chilometri trovammo un minimarket che aveva ancora un telefono pubblico appeso alla parete d’ingresso. Aiutai Chutsky a saltellargli incontro; lui si appoggiò alla cabina e alzò il ricevitore. Mi guardò e mi ordinò: «Aspetta laggiù», il che mi sembrò un po’ autoritario detto da uno che non era neppure in grado di camminare senza assistenza. Comunque tornai alla macchina e mi sedetti sul cofano mentre Chutsky chiacchierava.
Читать дальше