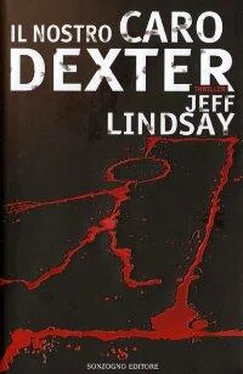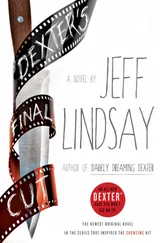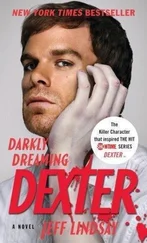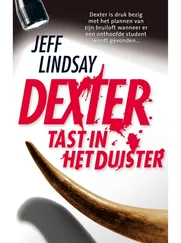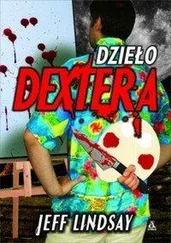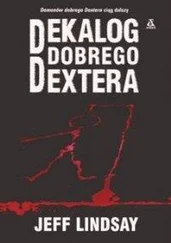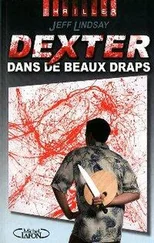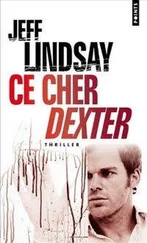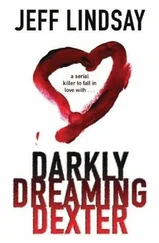«Non è possibile», replicò con voce flebile e roca. «Devo trovare Kyle.»
«No», mi opposi. «Tu devi andare al pronto soccorso. Se vai in giro in queste condizioni, finirai legata e impacchettata al suo fianco e non sarai d’aiuto a nessuno.»
«Io devo fare qualcosa», mormorò.
«Deborah, ti ho appena tirato fuori da un’auto immersa nell’acqua, danneggiando una splendida camicia da bowling. Vuoi vanificare il mio eroico salvataggio?»
Lei riprese a tossire e grugnì: bastava che respirasse e la clavicola le doleva. Immaginai che avesse ancora voglia di discutere, comunque si stava anche rendendo conto del gran male che aveva. Dato che la nostra conversazione non stava portando a nulla, Doakes arrivò a proposito, seguito da un paio di infermieri.
Il buon sergente mi guardò in cagnesco, neanche fossi stato io a spingere l’auto nello stagno e a capovolgerla. «Li avete persi, eh?» commentò. Lo trovai davvero maleducato.
«Già, non pensavo che sarebbe stato così difficile stargli dietro sott’acqua e con la macchina capovolta», ribattei. «La prossima volta ci provi tu e noi stiamo qui a lamentarci.»
Doakes mi fissò e grugnì. Poi si inginocchiò accanto a Deborah e chiese: «Sei ferita?»
«La clavicola», mormorò lei. «Si è rotta.» Stava superando rapidamente il trauma e cercava di combattere il dolore mordendosi le labbra e ansimando. Sperai che gli infermieri avessero qualche cura più efficace. «Doakes», disse Deborah e lui la guardò, «prendilo». Lui si limitò a fissarla, mentre lei stringeva i denti e lottava contro un’altra ondata di dolore.
«Da questa parte», disse un infermiere, un giovanotto muscoloso con i capelli sparati in su. Lui e il suo collega più vecchio e robusto fecero passare la barella dove la macchina di Debs aveva aperto un buco nella recinzione. Doakes cercò di alzarsi perché potessero sollevare Deborah, ma lei lo tenne per un braccio con una forza sorprendente.
«Prendilo», ripeté. Doakes si limitò a fare cenno di sì con la testa, ma a Deborah bastò. Lasciò andare il braccio del sergente che si alzò per far passare gli infermieri. Loro le piombarono addosso, le diedero un’occhiata e poi la caricarono sulla barella, la sollevarono e la spinsero verso l’ambulanza. La guardai allontanarsi, chiedendomi che fine avesse fatto il nostro amico del furgone bianco. Aveva una gomma bucata… non poteva andare troppo lontano. Era chiaro che avrebbe cambiato veicolo, anziché chiamare il soccorso stradale per farsi aiutare a cambiare la ruota. Quindi molto probabilmente avremmo trovato nei dintorni il furgone abbandonato e la segnalazione di un’auto rubata.
Animato da un’estrema generosità, vista la considerazione che Doakes aveva di me, gli andai incontro per renderlo partecipe delle mie congetture. Avevo appena fatto un passo nella sua direzione quando sentii un gran trambusto. Mi voltai a guardare.
Un cinquantenne ben piantato con addosso soltanto un paio di mutande correva verso di noi in mezzo alla strada. La pancia gli toccava la cintura e ballonzolava su e giù: ovviamente non era molto abituato a fare jogging e faticava a correre e insieme agitare la mano gridando: «Ehi! Ehi! Ehi!» Aveva attraversato la sopraelevata della I-95 e quando ci raggiunse era trafelato e ansimava così forte da non riuscire a formulare un discorso coerente. Comunque una certa idea su ciò che avrebbe detto l’avevo.
« El fugone », rantolò. Gli mancava il fiato e per di più aveva l’accento cubano ma stava cercando di dire: «Il furgone».
«Un furgone bianco? Con una ruota sgonfia? E la tua macchina è scomparsa», lo anticipai, mentre Doakes mi guardava.
L’individuo ansimante scuoteva la testa. «Un furgone bianco, sicuro. Mi è sembrato di sentire un cane lì dentro, credo ferito», spiegò e fece una pausa per prendere fiato e descrivere meglio la scena orribile a cui aveva assistito. «E poi…»
Ma aveva sprecato fiato inutilmente. Doakes e io ci eravamo già precipitati in strada nella direzione da cui era venuto.
Forse il sergente Doakes non si ricordava più che era lui a dovermi stare dietro, perché nella corsa al furgone mi distaccò di una ventina di metri. Naturalmente aveva il vantaggio per niente trascurabile di possedere entrambe le scarpe; comunque era stato bravo.
Il furgone era arenato su un marciapiede, davanti a una casa arancione pallido circondata da un muro di pietra color corallo. Il paraurti anteriore aveva sbattuto contro uno spigolo sgretolando il muro, mentre la parte posteriore era di sbieco in mezzo alla strada, il che ci permetteva di ammirare la targa giallo vivo con scritto SCEGLI LA VITA.
Quando lo raggiunsi, notai che la portiera sul retro era già aperta e udii il lamento proveniente dall’interno. Stavolta non sembrava un cane, o forse ero io che ci avevo fatto l’abitudine. Era più acuto e meno ripetitivo, più vicino a un gorgoglio stridulo piuttosto che a un urlo. Era comunque il verso inconfondibile di uno di quei morti viventi.
Era legato con delle cinghie a un sedile d’auto senza schienale che era stato messo di traverso, in modo da tenere tutta la lunghezza. In quelle cavità prive di palpebre, gli occhi si muovevano avanti e indietro e la bocca, senza labbra né denti, era congelata in una specie di O. La cosa si agitava come un bambino, ma non avendo braccia né gambe non riusciva a fare granché.
Doakes si era accovacciato al suo fianco e guardava ciò che restava della sua faccia con una commovente mancanza di espressione. «Frank», disse, e la cosa roteò gli occhi nella sua direzione. Per un attimo l’ululato si interruppe, poi riprese più acuto, impegnato in un diverso tipo di agonia, simile a una supplica.
«Lo hai riconosciuto?» domandai.
Doakes annuì. «È Frank Aubrey», rispose.
«Come fai a dirlo?» chiesi. Sul serio, credo che avrei avuto un’enorme difficoltà a riconoscere una persona in quelle condizioni. L’unico segno visibile erano le rughe sulla fronte.
Doakes continuava a fissarlo, quindi grugnì e indicò la zona laterale del collo. «Quel tatuaggio. È di Frank.» Grugnì un’altra volta, si piegò in avanti e diede un colpetto a un piccolo pezzo di carta attaccato alla panca. Mi avvicinai a vedere: con la stessa grafia filiforme della volta scorsa il dottor Danco aveva scritto:
ONORE
«Chiama i paramedici», ordinò Doakes.
Corsi verso l’ambulanza: gli infermieri stavano già chiudendo i portelli. «Ve ne sta ancora un altro?» chiesi. «Non occupa tanto spazio, però ha urgente bisogno di sedativi.»
«In che condizioni è?» mi domandò il giovanotto con i capelli sparati.
Dal punto di vista professionale la sua richiesta era davvero sensata, ma tutte le risposte che mi vennero in mente mi parvero frivole, così mi limitai a dire: «Credo che anche tu potresti averne bisogno, di quei sedativi».
I due mi guardarono come se li stessi prendendo in giro e non afferrarono la gravità della situazione. Poi si lanciarono un’occhiata e alzarono le spalle. «D’accordo, amico», borbottò il più vecchio. «Gli diremo di stringersi un po’.» Il ragazzo con i capelli sparati scosse il capo, ma tornò indietro, aprì il portello posteriore e fece uscire la barella.
Mentre i due la spingevano lungo l’isolato diretti al furgone di Danco, salii sul retro dell’ambulanza per vedere che cosa faceva Deborah. Aveva gli occhi chiusi ed era molto pallida, ma sembrava respirare debolmente. Aprì un occhio e mi guardò. «Siamo fermi», disse.
«Il dottor Danco ha fracassato il furgone.»
Lei si irrigidì e spalancò gli occhi. «L’avete preso?»
«No, Debs. Abbiamo solo il suo passeggero. Credo che lo stesse per consegnare, visto che è già pronto.»
Se prima pensavo che fosse pallida, ora divenne quasi evanescente. «Kyle», fece.
Читать дальше