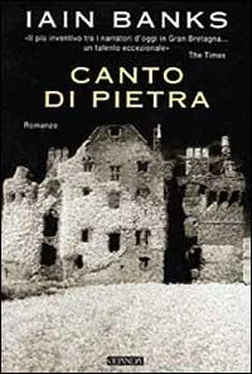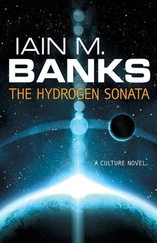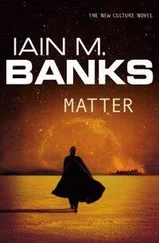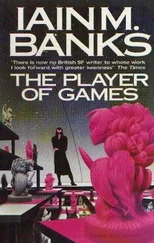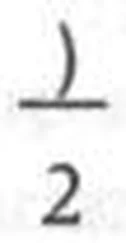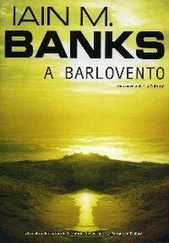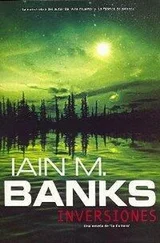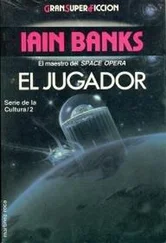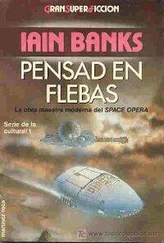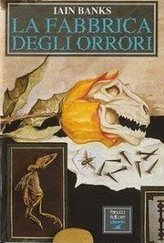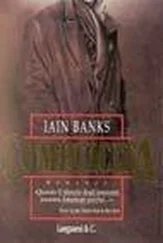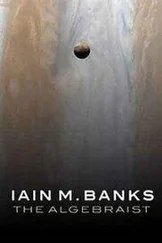Mi chiedo chi abbia gridato. Sei stata tu, mia cara, o lei? O io, forse? Per qualche ragione mi sembra importante proprio adesso, sapere chi ha gridato, ma so solo che qualcuno l’ha fatto. Ricordo quell’urlo, mi torna in mente il suono, posso ripeterlo nella mia mente anche al di sopra del rombo della tempesta, ma nel ricordo potrebbe essere stato chiunque di noi tre. Forse siamo stati tutti e tre insieme. No.
«…on qui!» dice una voce. Ma di chi?
Uno scuro rombo postumo mi consuma. Adesso è arrivata la tempesta. L’ultima cosa che sento è «Non qui, non qui. Non…»
Castello, sono nato dentro di te. Adesso mi rivedi come un bambino inerme portato attraverso le tue sale devastate. Sulla stessa barella che era servita per la granata vengo condotto davanti ai soldati, alle loro temporanee conquiste e ai nostri domestici, tutti in piedi, a bocca aperta. I detriti che avevo attraversato e le forme assopite che solo pochi minuti fa avevo sfiorato — unica creatura animata, unica in piedi e capace di stare in equilibrio, sprezzante di fronte alla loro rumorosa letargia — adesso sono gli ebbri testimoni della mia espulsione: vengo spazzato via, impotente e disarmato. Ciascuno con una candela in mano, i membri di quella congregazione mi osservano, come una vergine abbagliante e pacchiana condotta per la processione annuale in mezzo all’usuale squallore dei fedeli.
La luogotenente allarga le braccia mentre avanza a grandi falcate, infilandosi il giubbotto. Tranquillizza la folla, dicendo a tutti di tornarsene a letto, schiacciandosi per superare me e i miei portatori, sistemandosi il colletto mentre scendiamo le scale. Il sangue scorre alla testa. No, no, un incidente. Troveremo aiuto. So dove si può trovare un dottore, l’ho visto l’altro giorno. Anche la signora è ferita ma di striscio. Tutti e due sembra che stiano peggio di come stanno in realtà. A letto; tornatevene a letto. Continuate a dormire. Andrà tutto bene.
Vedo un altro viso, calmo, pallido ma composto in cima alle scale mentre scendiamo rumorosamente (mani bianche sul legno scuro e straziato, l’altro braccio avvolto in bende, stretto al tuo seno latteo)? Credo di sì, ma poi la rampa di scale mi fa voltare e mi toglie quella visione.
L’atrio, e sono di nuovo orizzontale. Vedo un’armatura accanto alla porta, con una cappa nera foderata di rosso sulle spalle. Cerco di toccarne l’orlo quando le passiamo accanto, e il braccio si protende in una supplica, mentre la bocca tenta di articolare parole. Il braccio ricade, toccando il pavimento, e le nocche colpiscono il gradino della porta, crocchiando su di esso mentre usciamo in cortile. La porta viene chiusa con violenza. Sento stivali che corrono sui ciottoli, poi urla e grida.
Non il pozzo, cerco di dire. Abbiate pietà. (Forse lo dico, credo, mentre mi scaricano dalla barella e mi buttano sul pianale tra i sedili di una jeep.) Il fondo odora di fango e olio. Qualcosa di freddo e rigido viene gettato sopra di me, sopra tutto il mio corpo, togliendomi la poca luce che c’è. Le sospensioni del veicolo cedono, viene mormorata qualche parola, un lontano rumore metallico viene coperto quando il motore si avvia rombando e l’acciaio sotto di me si mette a tremare.
Cigolano gli ammortizzatori, l’aria sibila; due pesanti paia di stivali si posano su di me, schiacciandomi la testa e le ginocchia. Il motore tossisce e si imballa, le marce stridono e partiamo con uno strattone. I ciottoli del cortile mi scuotono, il passaggio sotto il corpo di guardia amplifica il rombo del motore, e poi siamo fuori, oltre le mura, sopra il ponte — altre grida e un unico colpo di pistola — e scendiamo per il viale d’accesso.
Cerco di seguire la strada, sforzandomi di combinare la mappa della memoria con i movimenti ciechi della jeep; qui la testa è spinta contro la fiancata, qui gli stivali pesano di più, o scivolano all’indietro o in avanti. Credevo di conoscere bene questo territorio, ma penso di aver perso l’orientamento prima ancora di lasciare il parco. Giriamo a sinistra alla fine del viale, credo, ma sono ancora confuso. Mi fanno male la testa e le costole. Anche le mani, e questo mi sembra così ingiusto, dato che le loro ferite risalgono a un tempo molto più remoto, e ormai dovrebbero essere guarite da un pezzo.
Vogliono uccidermi. Mi pare di averli sentiti dire ai domestici che mi avrebbero portato da un dottore, ma non ci sono dottori. Non mi portano dove mi aiuteranno, a meno che non vogliano aiutarmi a morire. Qualunque cosa sia mai stato per loro, adesso sono nulla; non un uomo, un altro essere umano, solo qualcosa di cui sbarazzarsi. Solo una cosa.
La luogotenente crede che abbia voluto uccidere lei, o te, mia cara, o tutte e due. Anche se avessi la facoltà di parlare, non c’è nulla che potrei dirle che non sembri una misera scusa, una storia mal congegnata. Volevo vedere; sono stato solo curioso, nulla di più. Lei si era impadronita della nostra casa, si era impadronita di te eppure io non ne ero risentito, non la odiavo. Volevo solo guardare, avere conferma, essere testimone, condividere una minima parte della vostra gioia. La pistola? La pistola si era semplicemente presentata, è una creatura per natura promiscua, una cosa raccolta per caso, un invito rivolto alla mano per riempire la quale è stata disegnata e poi — nello stato in cui ero, attaccato a essa com’ero — era più facile tenerla che abbandonarla. Me ne stavo andando. Non avreste mai saputo che ero stato lì; la sorte, il puro destino ha decretato la mia caduta.
Non qui. Non qui. Sei stata davvero tu a dirlo? È quello che ho sentito davvero? Le parole mi echeggiano nella testa. Non qui. Non qui…
Così fredde, mia cara. Le parole, il loro significato così pratico, così oggettivo. Anche tu hai pensato che fossi venuto come un innamorato ardente e furioso a uccidervi entrambe? La nostra vita comune non ti ha insegnato chi e cosa sono io? Tutte le nostre giudiziose imprudenze, i nostri piaceri largamente diffusi, le reciproche libertà non ti hanno ancora convinto della mia mancanza di gelosia?
Oh, che dovessi ferire proprio te, che anche adesso tu debba cullare vicino al tuo petto quella ferita, pur leggera, pensando che l’abbia fatto apposta, e che volessi fare di peggio: questo è ciò che fa male, che mi ferisce. Vorrei poter soffrire io per quella ferita che con tanta imprudenza ti ho procurato. Le mie mani si stringono, sotto la tela cerata. Sembrerebbe che le mani siano diventati i miei occhi, e il mio cuore: perché entrambe piangono, e soffrono.
Il piano d’acciaio sotto di me ronza e vibra, la cerata s’increspa e sbatte, e un angolo mi picchietta in continuazione su una spalla come un villano fanatico che cerca di attrarre la mia attenzione. Il rumore dell’aria mi riempie le orecchie, vorticando e riverberandosi, lacerante, ossessivo, feroce nella sua insensata intensità, eppure capace di creare una calma più decisa di quella a cui avrebbe potuto aspirare il semplice silenzio. Mi ronza la testa, malata di questo vuoto risonante.
La mano destra è accanto alla fronte; trovo il comando che la porta più vicino, e la tela cerata copre il movimento. Sfioro la tempia: tocco qualcosa di bagnato, e sento il dolore della carne esposta; una lunga ferita che sanguina ancora, non più copiosamente, una scanalatura lungo un lato della testa, che parte dalle vicinanze dell’occhio e finisce oltre l’orecchio. Il sangue mi gocciola dalla fronte. Prendo qualche goccia e la strofino tra le dita, pensando a nostro padre.
Che triste razza è la nostra, che triste fine continuiamo a escogitare per tutti noi. Senza volerlo, mia cara, eppure quanti danni abbiamo provocato. A te, a noi, e a me, già ferito ma ormai vicino al momento in cui non potrò subire altro male. Dovrei andare così rassegnato alla mia fine? Non sono sicuro di avere molta scelta.
Читать дальше