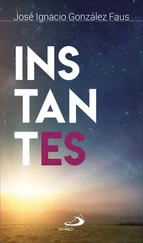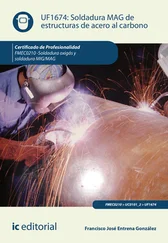Un luogo spesso frequentato da Escrivá era “El Sotanillo”, che si trovava nei pressi della Porta de Alcalá. Era rinomato soprattutto per la cioccolata calda. Pur trovandosi in un piccolo seminterrato, disponeva di diversi tavolini che permettevano di parlare tranquillamente. Pepe Romeo, Pedro Rocamora o Julián Cortés−Cavanillas —quest’ultimo era uno studente dell’Accademia Cicuéndez [67]— andarono lì molte volte per fare merenda con José María Escrivá. Mentre assaporavano una cioccolata calda o una bibita, conversavano con il sacerdote di realtà divine e di realtà umane. Qualche volta don José María portava schemi o quadri sinottici sull’Opera e li commentava. Poi, ricorda Rocamora: «uscivamo e percorrevamo la calle di Alcalá e la Gran Vía fino ad arrivare alla Red de San Luis dove era solito prendere il tram che lo portava a calle Santa Engracia. Se non ricordo male, era il tram n. 28 che aveva un cartello che diceva “Linea di San Luis−Guindalera−Prosperidad”. Altre volte, arrivati a Cibeles, piegavano per Recoletos, passeggiando per calle Genova» [68].
Quando stava per iniziare l’anno accademico 1930−1931, Escrivá decise di modificare il suo lavoro pastorale. Il ruolo di cappellano del Patronato non gli assicurava la stabilità a Madrid. Egli rimaneva un sacerdote extradiocesano, trasferito per motivi di studio, e, viste le severe leggi ecclesiastiche sulla residenza dei presbiteri nella capitale, correva il rischio certo di essere rimandato nella sua diocesi [69]. Inoltre la cappellania del Patronato de Enfermos gli assorbiva la maggior parte del tempo, dedicato generosamente ai penitenti, alla catechesi e alla visita domiciliare dei malati. Ora —così ragionava— doveva impegnarsi maggiormente per l’Opera, stimolando l’apostolato e formando i primi membri [70]. D’altra parte, non sembrava opportuno che cercasse donne per l’Opera nel confessionale delle Dame Apostoliche, che era la sede centrale della congregazione. Infine, c’era anche un motivo umano, anch’esso rilevante: l’attività del Patronato era così logorante che, pensava: «lì mi annichilo, mi annullo. Intendo sul piano fisico: di questo passo finirò con l’ammalarmi e non potrò quindi svolgere un lavoro intellettuale» [71].
A questa situazione si aggiungeva l’evoluzione politica e sociale della Spagna. Il 14 aprile 1931 veniva proclamata la Seconda Repubblica. Niceto Alcalá−Zamora assunse l’incarico di presiedere un Governo provvisorio che aveva il compito di convocare le elezioni per una Costituente e governare il paese fino all’approvazione di una nuova Costituzione. Il re Alfonso XIII abbandonò la Spagna per evitare una possibile guerra civile.
La Repubblica annunciò la separazione tra la Chiesa e lo Stato. La Spagna non era più ufficialmente cattolica, interrompendosi così una tradizione secolare. La vita religiosa —Messa e altri atti di culto— non fu turbata dal nuovo sistema repubblicano. Cosa ben diversa fu da quel momento l’abitudine degli insulti per strada contro i sacerdoti che portavano l’abito talare [72].
Come molti cattolici, José María Escrivá accolse il nuovo regime —la Seconda Repubblica— con una certa preoccupazione. Il motivo stava nell’ideologia anticlericale di cui faceva sfoggio la maggior parte dei partiti politici del Governo provvisorio. Comunque, personalmente fece buon viso alla richiesta della Gerarchia della Chiesa che chiedeva ai cattolici spagnoli di accettare il nuovo potere costituito [73]. Tuttavia, ci fu un fatto congiunturale che lo riguardò: l’avvento della Repubblica fece tramontare la possibilità di essere nominato cappellano della giurisdizione palatina [74].
Quattro settimane dopo —l’11 maggio— avvenne “l’incendio dei conventi”, che interessò diverse località spagnole. A Madrid circa trecento giovani —in maggioranza dell’estrema sinistra repubblicana e anarchici— incendiarono nove conventi, cinque scuole e una dipendenza parrocchiale. Il Governo provvisorio mantenne per tutta la giornata un atteggiamento indolente finché, data la gravità degli avvenimenti, decretò lo stato di guerra e ordinò che l’esercito presidiasse le strade [75].
Come altri sacerdoti e i religiosi, José María Escrivá visse questa giornata vivamente preoccupato. A metà mattina, quando lo informarono che i rivoluzionari stavano dando alle fiamme la casa professa dei gesuiti in calle de la Flor, andò nella cappella del Patronato de Enfermos. Lì si vestì in borghese e, insieme a suo fratello Santiago, al padre e al fratello di Pepe Romeo, e a Julián Cortés−Cavanillas, uscì «con una pisside piena di Ostie consacrate avvolta in una veste talare e in un po’ di carta» [76]. Un taxi li portò da Santa Engracia 13 —dov’era il Patronato— fino all’abitazione della famiglia Romeo, al numero 134 della stessa strada [77].
Le minacce anticlericali e la sensazione di insicurezza provata durante “l’incendio dei conventi” facevano presagire nuove aggressioni alle istituzioni ecclesiastiche. Siccome il Patronato de Enfermos era un possibile obiettivo per gli incendiari, José María Escrivá cercò una casa sicura per la famiglia. Il 13 maggio gli offrirono un piccolissimo appartamento in calle Viriato 22, secondo interno a destra, di proprietà di Luz Rodríguez−Casanova. Per quanto sembrasse inadeguato ad alloggiare quattro persone, gli Escrivá Albás vi si trasferirono appena possibile. In questa «casa modesta» [78]sarebbero rimasti un anno e mezzo.
Nel frattempo, don José María proseguiva la ricerca di un nuovo incarico sacerdotale che gli permettesse di dedicare più tempo all’Opera. Conobbe nuove persone in grado di comprendere il messaggio di cui si sentiva depositario e conservò i suoi impegni accademici e pastorali. Nei primi mesi del 1931 gli avevano presentato altri giovani. Ad alcuni fece la proposta di seguirlo nell’Opera. Più precisamente, all’inizio di maggio —rispettivamente, nei giorni 1 e 6— due ragazzi si mostrarono disposti a formarsi nello spirito dell’Opus Dei: José Muñoz Aycuéns [79], un pittore, e Adolfo Gómez Ruiz [80], studente di medicina, amico di Pepe Romeo.
Nella Casa Sacerdotale delle Dame Apostoliche Escrivá conobbe anche un altro sacerdote secolare che poteva capire il messaggio dell’Opera. Si chiamava Sebastián Cirac. Lavorava come archivista della Curia diocesana di Cuenca, ma veniva spesso a Madrid per seguire i corsi di dottorato nella Facoltà di Filosofia e Lettere [81]. Dopo alcune conversazioni tra i due, Cirac decise di incorporarsi nell’Opera nel mese di luglio [82].
Il caso di Pedro Cantero —un sacerdote che Escrivá aveva conosciuto mesi prima all’Università Centrale— fu un po’ diverso [83]. Il 14 agosto parlarono dell’Opera e, come frutto di questa conversazione, Cantero si propose obiettivi più ambiziosi per la sua azione pastorale e apostolica. In particolare, durante i mesi che seguirono, i due sacerdoti visitarono i malati in alcuni ospedali. In seguito, però, i rapporti si attenuarono a causa dei rispettivi impegni pastorali [84].
Come era la personalità di José María Escrivá? Chi lo frequentava notava il suo «carattere aperto, l’aspetto cordiale e la simpatia irresistibile» [85], una personalità attraente che parlava «senza alcuna leziosaggine, perché non era per nulla, assolutamente per nulla, presuntuoso» [86]. Si distingueva soprattutto nella celebrazione dei sacramenti e negli atti di culto. Nella cappella del Patronato le Dame Apostoliche osservavano che Escrivá passava «lunghe ore vicino al Tabernacolo in conversazione con il Signore. Era solito stare in chiesa nei momenti in cui era vuota» [87]. Secondo Rocamora, «senza prediche, senza omelie, semplicemente con la maniera di dir messa, l’emozione con cui compiva il Sacrificio era talmente potente che si trasmetteva a chi gli stava vicino» [88].
Читать дальше