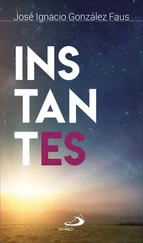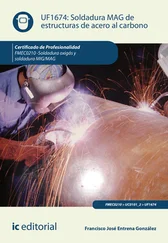Diario 3, intitolato “Quaderno N. 3. Diario della Casa dell’Angelo Custode”, scritto tra il 10 aprile e il 15 settembre 1935. Sono 107 pagine: 91 di fila più 16 aggiunte. Lo scrissero Manuel Sainz de los Terreros dal 10 aprile al 19 maggio 1935; Ricardo Fernández Vallespín, dal 9 giugno al 15 settembre 1935; e Julio Roca, dal 9 agosto al 20 agosto 1935. Vi sono inoltre tre annotazioni isolate di Fernández Vallespín: una del settembre 1935, senza data; un’altra del 20 ottobre 1935 e una terza del 28 gennaio 1936.
Diario 4, intitolato “Diario N. 3” [ sic ]. Sono 181 pagine, scritte tra il 24 settembre 1935 e il 3 maggio 1936. I redattori del diario furono: Álvaro del Portillo, dal 24 settembre al 12 novembre 1935; Juan Jiménez Vargas, dal 14 novembre al 4 dicembre 1935; Álvaro del Portillo, dal 5 dicembre 1935 al 22 gennaio 1936 (con alcune annotazioni di Manuel Sainz de los Terreros, il 16 dicembre 1935); Pedro Casciaro, dal 23 gennaio al 16 febbraio 1936; Josemaría Escrivá, dal 24 al 25 febbraio 1936; Ricardo Fernández Vallespín, il 26 febbraio 1936; Pedro Casciaro, dal 26 febbraio al 31 marzo 1936; e Juan Jiménez Vargas, dall’1 aprile al 3 maggio 1936.
Diario 5, intitolato semplicemente “5”. 202 pagine, scritte tra il 4 maggio e il 28 luglio 1936. Fu scritto esclusivamente da Juan Jiménez Vargas.
Ringrazio Mons. Javier Echevarría, vescovo e prelato dell’Opus Dei, per la fiducia dimostratami, permettendomi di fare ricerche nell’Archivio della Prelatura, anche se attualmente sottoposto ad un riordino. Sono anche in debito di gratitudine verso i professori Mercedes Alonso, Constantino Ánchel, Eduardo Baura, José Luis Illanes, Jesús Longares, José Manuel Martín, Lucas Francisco Mateo-Seco, Fernando de Meer, Ignacio Olábarri, María Eugenia Ossandón, Santiago de Pablo, Cristóbal Robles e Alfredo Verdoy, che hanno letto una delle versioni del manoscritto del libro e mi hanno inviato preziosi suggerimenti.
Torna all'indice
Prossimo capitolo
[1]Siccome l’oggetto storico del nostro studio si colloca negli anni trenta del secolo scorso, utilizzeremo i modi usati allora per riferirsi alle persone e agli avvenimenti. Così, il nome del fondatore dell’Opus Dei apparirà come era: José María Escrivá Albás. Fu più tardi, negli anni sessanta, che sulla carta intestata riunì in uno i due primi nomi di battesimo, “Josemaría”, per devozione a san Giuseppe e alla Vergine Maria.
Allo stesso modo, salvo che in questa introduzione, il primo cognome apparirà come egli lo utilizzava negli anni trenta: Escrivá. Successivamente —nell’ottobre del 1940— adottò la dizione “Escrivá de Balaguer” (Balaguer è il territorio di Lérida in cui, nei secoli passati, si erano stabiliti gli Escrivá). Il motivo del cambiamento fu il desiderio di distinguersi da altri rami della famiglia, perché talvolta col suo cognome si faceva un po’ di confusione. Per esempio, nello stesso edificio in cui aveva sede la Residenza DYA, a Madrid, c’era una famiglia che si chiamava “Escrivá de Romaní”, che non era imparentata con gli Escrivá Albás.
D’altra parte, l’espressione “Opus Dei” fu utilizzata da José María Escrivá dopo la guerra civile spagnola. Negli anni trenta impiegò l’espressione “l’Opera di Dio” o, semplicemente, “l’Opera”. Per questo motivo, menzioneremo l’Opus Dei solo in contesti generici.
[2]Cfr. John F. Coverdale, La fundación del Opus Dei , Ariel, Barcelona 2002, pp. 123−165.
[3]Cfr. Constantino Ánchel, “Fuentes para la historia de la Academia y de la Residencia DYA”, Studia et Documenta 4 (2010) 45-101; e José Carlos Martín de la Hoz — Josemaría Revuelta Somalo, “Un estudiante en la Residencia DYA. Cartas de Emiliano Amann a su familia (1935−1936)”, Studia et Documenta 2 (2008) 299−358. Citeremo l’Archivio Generale della Prelatura con la sigla AGP perché è quella adottata da molte pubblicazioni sulla storia dell’Opus Dei. In Spagna questa sigla è usata dai ricercatori per indicare l’Archivio Generale di Palazzo (Madrid).
[4]Cfr. Santiago Casas Rabasa, “Las relaciones escritas de san Josemaría sobre sus visitas a Francisco Morán (1934−1938)”, Studia et Documenta 3 (2009) 371−411; Beatriz Comella Gutiérrez, Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid (1931−1945) , Rialp, Madrid 2010; Idem, “Introducción para un estudio sobre la relación de Josemaría Escrivá de Balaguer con el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid”, Studia et Documenta 3 (2009) 175−200.
[5]Cfr. Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer , Monte Carmelo — Instituto Histórico San Josemaría Escrivá, Burgos 2013.
[6]Cfr. Andrés Vázquez de Prada, Il Fondatore dell’Opus Dei , vol. I (“Signore, che io veda!”), Leonardo International, Milano 1998; vol. II (“Dio e audacia”), Leonardo International, Milano 2003; vol. III (“I cammini divini della terra”), Leonardo International, Milano 2004.
[7]In quanto estranei all’oggetto, questa monografia non si occupa neppure di altri elementi che mostrano la ricchezza interiore del fondatore dell’Opus Dei —la sua vita di relazione amorosa con Dio— o del significato teologico e giuridico del messaggio dell’Opera. Ci limitiamo a mostrare la vita del fondatore dell’Opus Dei negli aspetti più inerenti alla storia dell’Accademia e della Residenza DYA.
[8]Molti ricordi sono estratti dalle dichiarazioni presentate in occasione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Josemaría Escrivá. Qui appaiono sotto il titolo “Ricordo di”, seguito dal luogo e dalla data in cui furono firmati.
[9]Sugli Apuntes íntimos del fondatore dell’Opus Dei, cfr. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez , Rialp, Madrid 2004, pp. 18−27, e Pedro Rodríguez, “Apuntes íntimos (obra inédita)”, in Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer , o.c., pp, 131−135. Non abbiamo potuto consultare questa fonte.
[10]Poco dopo aver cominciato il diario, Josemaría Escrivá diede al suo primo redattore, Manuel Sainz de los Terreros, la seguente istruzione: «da ora in avanti metteremo in questo diario non solo quello che succede o si progetta, ma tutte le osservazioni che facciamo, che pensiamo siano di qualche interesse in futuro e tutto ciò che riteniamo opportuno, con assoluta libertà» ( Diario de Luchana , 22−III−1934, pp. 58 e 59, in AGP, serie A.2, 7−2−1); lì si dice che il sacerdote Pedro Poveda confidò a Josemaría Escrivá che si pentiva di non aver fatto lo stesso con l’Istituzione Teresiana (cfr. ibidem , p. 58). Anche Ricardo Fernández Vallespín, direttore di DYA, ricevette l’indicazione di «annotare qualche fatto o dettaglio della nostra vita che col tempo ci aiuterà a ricordare» (Scritto da Ricardo Fernández Vallespín, 29−V−1934, in AGP, serie A.2, 7−2−1).
[11]Cfr. Diario de Luchana , 23−IV−1934, pp. 88-89; Diario de Ferraz , 15−I−1935, p. 111; 17−I−1935, p. 115; e 19−I−1935, p. 118.
[12] Apuntes íntimos , n. 1097 (30−XII−1933), in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. Edición crítico-histórica , o.c., p. 885.
[13]Conosciamo il metodo che seguì uno di loro, Juan Jiménez Vargas: durante la giornata prendeva nota nella sua agenda degli avvenimenti che considerava rilevanti e la sera li passava in bella nel diario (cfr. Diario di Ferraz , 19-VI-1936, p. 43a).
[14]Cfr. Diario 1, in AGP, serie A.2, 7−2−1; Diario 2, con la stessa segnatura; Diario 3, in AGP, serie A.2, 7−2−2; Diario 4, in AGP, serie A.2, 7−2−3; e Diario 5, AGP, serie A.2, 7−2−4. Al fine di evitare ripetizioni, non scriveremo di nuovo i riferimenti archivistici di questi documenti, né ricorderemo le persone che ne furono i redattori.
Читать дальше