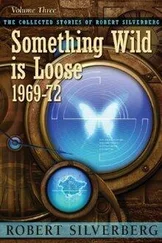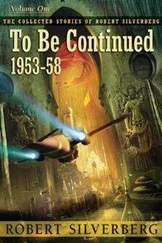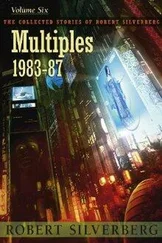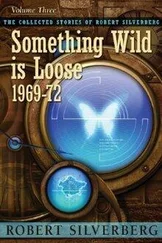— Voglio finirla. Voglio finirla. — La donna trovò la forza sufficiente per inarcare il corpo, sollevandolo per metà dal fluido che quasi le nascondeva la parte inferiore. Qualcosa si mosse, provocando un rigonfiamento sotto la sua pelle. Gundersen toccò la pancia tesa e sentì un movimento dentro, e quel tremito rapido fu la sensazione più spaventosa che avesse mai provato in vita sua. Toccò anche il corpo di Dykstra: anch’esso aveva quel tremito interiore.
Costernato, Gundersen si rimise in piedi e arretrò. Alla pallida luce della torcia, studiò i corpi raggrinziti, nudi e senza sesso, ossa e legamenti, privi di carne e di spirito, eppure vivi. Una paura terribile lo assalì. — Na-sinisul! — chiamò. — Vieni qui! Entra!
Il sulidor, pochi momenti dopo, fu al suo fianco. Gundersen disse: — C’è qualcosa dentro i loro corpi. Un parassita? Si muove. Cos’è?
— Guarda qui — disse Na-sinisul, indicando il cesto spugnoso da cui colava il liquido scuro. — Portano i suoi piccoli. Sono diventati ospiti. Un anno, due anni, forse tre, e le larve emergeranno.
— Perché non sono morti?
— Si nutrono da questo — disse il sulidor, sferzando con la coda il liquido nero. — Penetra nella pelle. Li nutre e nutre ciò che hanno dentro.
— Se li trasportassimo all’hotel su delle zattere…?
— Morirebbero — disse Na-sinisul — non appena fossero tolti dal liquido. Non c’è speranza di salvarli.
— Quando finisce? — chiese la donna.
Gundersen tremava. Tutto il suo addestramento gli diceva di non accettare mai l’inevitabilità della morte. Qualsiasi essere umano in cui restasse qualche brandello di vita poteva essere salvato, ricostruito a partire da pochi resti di cellule in una ragionevole replica dell’originale. Ma non c’erano attrezzature per far questo, sul Mondo di Holman. La sua mente passò vertiginosamente in rassegna una serie di possibilità. Lasciarli lì, perché le cose aliene si nutrissero delle loro interiora; cercare di portarli allo spazioporto e imbarcarli per il più vicino ospedale tectogenetico; sollevarli immediatamente dalla loro agonia; cercare lui stesso di liberare i loro corpi da ciò che li rendeva schiavi. Si inginocchiò di nuovo. Si costrinse a sentire ancora quel fremito interiore. Toccò lo stomaco della donna, le cosce, le anche ossute. Sotto la pelle, era un ammasso di sostanza aliena. Eppure la sua mente ancora funzionava, anche se aveva dimenticato il suo nome e la sua lingua natale. L’uomo era più fortunato: benché fosse anch’egli infestato, almeno non doveva attendere al buio la morte che sarebbe giunta solo quando le larve sarebbero uscite dalla carne resa schiava. Era questo che avevano desiderato, rifiutando il rimpatrio da quel mondo che amavano? Un terrestre può essere catturato da Belzagor, gli aveva detto il nildor molte-volte-nato, Vol’himyor. Ma quella era una cattura troppo letterale.
Il fetore di putrefazione gli diede i conati di vomito.
— Uccidili tutti e due — disse a Na-sinisul. — E fai in fretta.
— È questo che mi istruisci di fare?
— Uccidili. E strappa quella cosa dal muro, e uccidi anche lei.
— Non ha fatto nulla di male — disse il sulidor. — Ha fatto solo ciò che è naturale per la sua specie. Uccidendo quei due, la priverò dei suoi piccoli, ma non sono disposto a privarla anche della vita.
— Va bene — disse Gundersen. — Soltanto i terrestri, allora. In fretta.
— Faccio questo come atto di misericordia, dietro tuo ordine diretto — disse Na-sinisul. Si chinò e sollevò un braccio potente. Gli artigli ricurvi emersero interamente dalle loro guaine. Il braccio scese due volte.
Gundersen si costrinse a guardare, i corpi si aprirono come gusci secchi. Le cose all’interno rotolarono fuori, ancora informi. In un inconcepibile riflesso i due corpi si contorsero, sussultarono. Gundersen fissò le loro viscere erose. — Mi sentite? — chiese. — Siete vivi o morti? — La bocca della donna si aprì, ma non ne uscì alcun suono, e non capì se si trattava di un tentativo di parlare o soltanto dell’ultima convulsione dei nervi devastati. Portò la torcia a fusione alla massima potenza e la puntò sulla pozza scura. Sono la resurrezione e la vita, pensò, riducendo Dykstra in cenere, e la donna accanto a lui, e le larve che si contorcevano. Un fumo acre e soffocante si alzò; neppure la torcia poteva distruggere l’umidità dell’edificio. Riportò la torcia a livello di illuminazione. — Vieni — disse al sulidor, ed uscirono insieme.
— Avrei voglia di bruciare l’intero edificio, e di purificare questo posto - disse Gundersen a Na-sinisul.
— Lo so.
— Ma tu me lo impediresti.
— Ti sbagli. Nessuno su questo mondo ti impedirebbe di fare alcunché.
Ma a cosa sarebbe servito… si chiese Gundersen. La purificazione era già stata fatta. Aveva rimosso gli unici esseri in quel posto che fossero estranei a esso.
La pioggia era cessata. A Srin’gahar in attesa Gundersen disse: — Mi porti via da qui?
Raggiunsero gli altri quattro nildor. Poi, essendosi fermati troppo a lungo lì, ed essendo la terra della rinascita ancora lontana, ripresero la marcia, benché fosse notte. Verso il mattino, Gundersen poté sentire il rombo delle Cascate di Shangri-la, che i nildor chiamano Du’jayukh.
Era come se una parete bianca di acqua scendesse dal cielo. Nulla sulla Terra poteva uguagliare il triplo salto di quella cataratta, con cui il Fiume di Madden, o il Seran’nee precipitava di 500 metri, poi di 600, poi di altri 500, da un cornicione all’altro, nella sua corsa verso il mare. Gundersen e i cinque nildor si fermarono ai piedi della cascata, dove l’intera, violenta massa d’acqua precipitava in un vasto bacino circondato da rocce, da cui il fiume serpentino proseguiva nel suo corso verso sud-est; il sulidor aveva preso congedo durante la notte, e procedeva verso nord lungo la sua strada. Alle spalle di Gundersen giaceva, verso destra, la pianura costiera, e verso sinistra l’altopiano centrale. Davanti a lui, in cima alle cascate, iniziava l’altopiano settentrionale, che controllava l’accesso al paese delle nebbie. Così come una titanica fenditura da nord a sud separava la pianura costiera dall’altopiano centrale, un’altra fenditura, da est a ovest, divideva tanto l’altopiano centrale quanto la pianura costiera dalle terre alte davanti a loro.
Si tuffò in una pozza cristallina, appena prima del tumulto della cataratta, poi iniziarono la salita. La stazione di Shangri-la, una delle più importanti della Compagnia, era invisibile dal basso, essendo posta a una certa distanza dall’inizio delle cascate. Una volta c’erano state delle stazioni intermedie, ai piedi delle cataratte e in cima a quella di mezzo, ma nessuna traccia di queste strutture rimaneva. La giungla le aveva completamente inghiottite nel giro di otto anni. Una strada tortuosa, con un’infinità di tornanti, portava fino alla cima. La prima volta che l’aveva vista, Gundersen aveva pensato che fosse opera degli ingegneri della Compagnia, ma apprese in seguito che era un cornicione naturale, che i nildor stessi avevano allargato per rendere più facili i loro viaggi verso la rinascita.
L’ondeggiare della sua cavalcatura gli conciliava il sonno. Strinse forte le corna simili a pomelli di Srin’gahar, sperando di non cadere, nel dormiveglia. Una volta si svegliò d’improvviso, e si trovò aggrappato solo con la sinistra, con il corpo che per metà penzolava su un precipizio di almeno 200 metri. Un’altra volta, venne risvegliato da una doccia fredda, e vide l’intera cascata precipitare a non più di una dozzina di metri da lui. In cima alla cataratta inferiore, i nildor si fermarono per mangiare, e Gundersen si spruzzò la faccia con acqua gelida, per uscire dal suo torpore. Proseguirono. Ebbe meno difficoltà a rimanere sveglio, questa volta; l’aria era più sottile, e la brezza fresca. Un’ora prima del tramonto raggiunsero la cima delle cascate.
Читать дальше