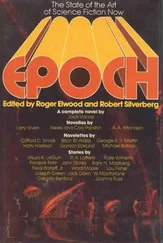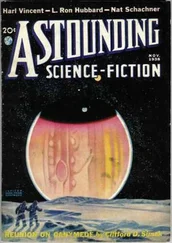Si avvicinò allo scaffale dei diari, tolse l’ultimo e incominciò a sfogliarlo. Scoprì che gli restavano pochissime pagine, forse neppure sufficienti a descrivere gli ultimi avvenimenti. Avrebbe dovuto inaugurare un nuovo quaderno, pensò.
Rimase a fissare le righe che aveva scritto solo due giorni prima. L’altro ieri, pensò, e sembravano già pagine sbiadite dal tempo. Forse era proprio così, in fondo: un’altra epoca. L’ultima annotazione prima che il mondo gli crollasse addosso.
A che sarebbe servito continuare il diario? Ormai aveva scritto tutto quello che importava. La stazione sarebbe stata chiusa e la Terra perduta. A prescindere da quello che sarebbe capitato a lui, trasferito in un’altra stazione o lasciato dov’era, per il suo pianeta era la fine.
Chiuse il quaderno con uno scatto rabbioso e lo rimise a posto. Poi tornò alla scrivania.
La Terra era perduta e anche lui. Era furente contro il destino (posto che ci fosse un destino) e contro la stupidità intellettuale non solo del pianeta, ma della stessa galassia, che a causa di inutili battibecchi rischiava di arrestare la propria espansione in quel settore dello spazio. Anche lassù, come succede nel nostro mondo, la complessità della tecnologia, i nobili pensieri, la saggezza e l’erudizione potevano determinare una cultura ma non una civiltà. Per essere veramente civili, occorreva qualcosa di più sottile di una macchina o del pensiero.
Enoch si sentì in preda a una tensione che l’avrebbe spinto a fare qualunque cosa, dall’aggirarsi nella stazione come un leone in gabbia a correre fuori gridando a pieni polmoni, a rompere e a fracassare oggetti per sfogare in qualche modo rabbia e delusione.
Allungò una mano per prendere il fucile, aprì il cassetto dove teneva le munizioni e lacerò il pacchetto, riempiendosi le tasche di cartucce.
Rimase dov’era, con il fucile in mano. Per un attimo si sentì oppresso dal silenzio della stanza, così fredda e muta, poi tornò a posare l’arma.
Che infantilismo sfogare rabbia e risentimento contro cose irreali. Inoltre, non c’era un vero e proprio motivo che giustificasse la sua irritazione. Negli avvenimenti c’era un significato che poteva essere capito e accettato. Era il genere di cosa cui un uomo avrebbe dovuto essere abituato da tempo.
Si guardò intorno e gli parve che la stazione silenziosa e deserta fosse in attesa di un evento previsto nel naturale flusso del tempo.
Rise piano e impugnò nuovamente il fucile.
Irreale o no, gli avrebbe tenuto la mente occupata e per un po’ lo avrebbe liberato dai problemi che lo assillavano. E poi erano dieci giorni che non si esercitava.
Lo scantinato, enorme, si estendeva in una nebbiosa semioscurità appena interrotta dalle luci che Enoch aveva acceso in una stanza dopo l’altra, un corridoio dopo l’altro, il tutto scavato profondamente nella roccia della collina.
Laggiù erano i grandi serbatoi pieni delle soluzioni che servivano ai viaggiatori di passaggio, ma anche le pompe e i generatori azionati da un’energia sconosciuta all’uomo. Sotto il pavimento della cantina stavano i recipienti pieni di acidi e altre sostanze, fra cui i corpi temporanei in cui i viaggiatori avevano preso vita arrivando alla stazione, e che si erano lasciati dietro al momento di proseguire il viaggio. Corpi inutili che lui aveva l’incarico di distruggere.
Oltrepassati i serbatoi e i generatori, Enoch arrivò a un corridoio che si perdeva nell’oscurità. Trovò l’interruttore e lo premette, in modo da fare luce; quindi proseguì. Alle pareti si allineavano scaffalature metalliche traboccanti di manufatti, congegni tecnologici e regali portati dai viaggiatori. Dal pavimento al soffitto, l’accumulo di oggetti ricordava quello di un rottamaio galattico. In realtà, pensò Enoch, c’era ben poco da rottamare nella sua collezione. Tutto serviva e aveva uno scopo, pratico o estetico che fosse; anche se non sempre si trattava di uno scopo applicabile agli esseri umani.
In uno scaffale in fondo al corridoio c’erano degli oggetti sistemati con cura particolare e contrassegnati da etichette numerate che si riferivano a determinate pagine di diario. Erano gli oggetti di cui Enoch conosceva l’uso. Alcuni erano insignificanti, altri di grandissimo valore, anche se per il momento non servivano all’uomo; e ve n’erano alcuni, con l’etichetta rossa, che al solo pensarci mettevano i brividi.
Enoch continuò a scendere, fra il rimbombo dei suoi passi che echeggiavano in quel labirinto di fantasmi extraterrestri.
Il corridoio sfociava in una stanza ovale con le pareti rivestite da una spessa sostanza grigia, efficace nel trattenere i proiettili e nell’impedirne il rimbalzo.
Enoch si accostò a un pannello inserito in una profonda rientranza della parete, premette un pulsante e tornò in fretta al centro del locale.
Lentamente le luci si spensero e quando si riaccesero, in un fulgore abbagliante, Enoch scoprì di non essere più nella stanza ma in un posto che non aveva mai visto prima.
Stava sulla sommità di una piccola altura, il cui pendio digradava fino a un fiumiciattolo che scorreva in un pantano. Il terreno era coperto da una distesa d’erba folta e alta che ondeggiava senza vento, perché era abitata da un’infinità di animaletti. Dal mare d’erba usciva un grugnito simile a quello di centinaia di maiali affamati che s’azzuffassero davanti al truogolo. Dall’altra riva del fiume veniva un muggito roco e monotono.
Enoch si sentì accapponare la pelle e tenne pronto il fucile. Era incredibile: fiutava e conosceva il pericolo, pur sapendo che non c’era ancora pericolo. L’aria del posto — di qualunque posto si trattasse — era impregnata di minacce.
Si guardò intorno e vide che dietro di lui una fitta boscaglia si arrampicava su una catena di colline, per fermarsi davanti al mare d’erba che scorreva sotto l’altura dove egli si trovava. Oltre le colline si scorgeva il profilo blu scuro d’una catena di monti che parevano fondersi con il cielo, violacei sulla cima ma senza traccia di neve.
Due animali uscirono trotterellando dal bosco e si fermarono ai limitare della radura, mettendosi a sedere con la coda avvoltolata intorno alle zampe. Assomigliavano a lupi, o a cani, e la pelliccia luccicava al sole come se fosse unta; la testa e il muso erano senza peli. Si sarebbero potuti prendere per due vecchiacci travestiti con pelli di lupo, ma il trucco era svelato dalla lingua che pendeva dalla bocca, aguzza e d’un bel rosso vivo che spiccava sul muso bianco.
Il bosco era silenzioso. C’erano solo le due bestie fameliche sedute sulle zampe posteriori; sedute e con un ghigno senza denti rivolto a Enoch.
Il bosco era fitto e scuro; le foglie, di un verde tanto carico da sembrare nero, parevano verniciate.
Enoch tornò a girarsi dalla parte del fiume e vide, ferma sulla riva, una fila di creature mostruose; erano simili a rospi lunghi quasi due metri e di un colore indefinito. E avevano un unico occhio sfaccettato che occupava quasi tutto il muso e brillava nel sole vago della foresta, come quello di un felino in caccia che riflette un raggio di luce.
Da oltre il fiume veniva sempre il lontano muggito, intercalato da un ronzio simile a quello della zanzara, ma molto più forte e acuto.
Enoch alzò lo sguardo al cielo e vide una fila di puntini, così lontani che si distinguevano appena. Troppo in alto per decidere cosa fossero.
Abbassò la testa per guardare di nuovo gli enormi rospi acquattati in riva al fiume, ma con la coda dell’occhio notò qualcosa che si muoveva alle sue spalle e si girò di scatto verso il bosco.
I due esseri-lupo con il cranio a forma di teschio risalivano in fretta la collina, ma non era esatto dire che corressero. Piuttosto, si muovevano come se fossero stati espulsi da un tubetto.
Читать дальше