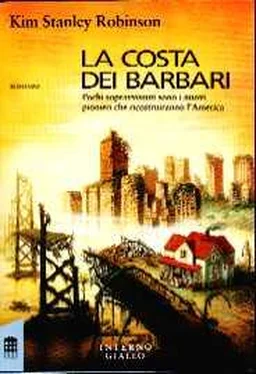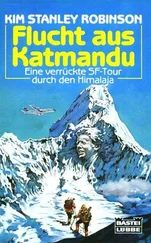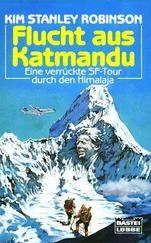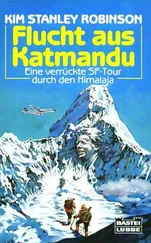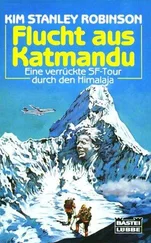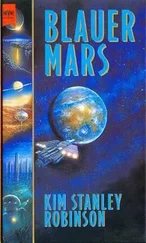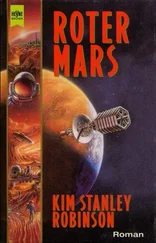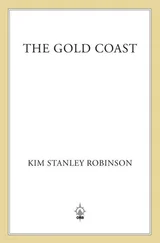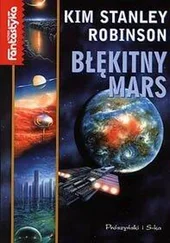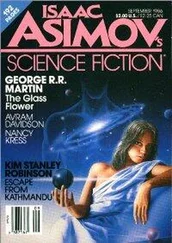«C’è già riuscito anche senza quella trappola sulla testa.»
Gabby e Kristen ci raggiunsero in fondo al pendio. Gabby era infangato dalla testa ai piedi per una caduta; il suo timido sorriso pareva ancora più bianco per contrasto. Trascinammo un altro rotolo su per la salita. Il vento colpiva gli alberi più in alto; i rami sobbalzavano e si piegavano, come se il fianco della montagna fosse un grosso animale che si dibatteva sotto la tempesta, emettendo il suo gemito, uhuuuu, uhuuuu, e facendo sembrare smisurata la valle. L’acqua scorreva sui teloni di plastica già stesi. Nel tornare indietro, Gab e io ci soffermammo a lisciare le grinze al telone in modo che si piegasse correttamente nei solchi. Il canale di scolo alla fine dei campi straripava, ma tanto l’acqua finiva comunque nel fiume.
Tom ci venne incontro. Nonostante l’ombrello, era bagnato in viso come chiunque altro. «Ciao Gabriel, Henry. Ciao Armando, Kristen. Bentornati. Kathryn dice che le serve aiuto per il granturco.»
Risalimmo in fretta la riva del fiume fino ai campi di granturco; avevamo brividi di freddo, battevamo le mani lungo il corpo per scaldarci. Kathryn, al limitare inferiore dei campi, correva da tutte le parti a formare i gruppi, spingeva a calci su per la montagna i rotoli riluttanti, indicava i cedimenti dei teloni già legati. Era nera di fango quanto Gabby. Ci urlò degli ordini: nell’udire il tono acuto della sua voce, ci mettemmo a correre.
I germogli di granturco erano alti due spanne: impossibile stendere i teloni sulle piantine senza romperle. Per ovviare all’inconveniente, a intervalli di qualche metro c’erano blocchi di cemento ai quali legare i teloni di plastica mediante appositi occhielli metallici. Quindi i blocchi dovevano trovarsi in posizione corrispondente agli occhielli. Steve e John Nicolin lavoravano insieme a spostare blocchi e legare nodi. Lì tutti gocciolavano fango nero. Kathryn ci aveva mandati all’estremità superiore del campo; lassù c’erano già le sue due sorelle più giovani, Doc e Carmen Engloff, impegnati con uno dei teloni più stretti. «Ehi, papà, fai rotolare quella roba» disse Mando, mentre ci avvicinavamo.
«Dateci una mano» replicò Doc, stancamente. Loro continuarono a srotolare, mentre noi legavamo ai blocchi il telone. Kathryn aveva posizionato i blocchi alcune settimane prima ed ero stupito quanto fossero vicini alla posizione corretta, però ciascuno doveva essere comunque spostato un poco. Ci vollero un mucchio di scivoloni nel fango prima di sistemarli. Finalmente terminammo di stendere il telone e passammo subito a quello seguente.
Faticammo per un bel pezzo, di nuovo su per il pendio. Raffiche di vento afferravano la plastica e me la strappavano dalle dita gelate. Faceva male, reggerla con forza. Legare i nodi divenne quasi impossibile: mi sentivo frustrato, nel vedere come le mie dita bianche e rosse sbagliassero in continuazione. E da parecchio non sentivo più i piedi. Arrivarono nubi più dense e aumentò l’oscurità. I teloni già stesi mandavano un debole riflesso luminoso. Ginocchioni nel fango, in preda ai brividi, staccai lo sguardo dal nodo per un attimo: il campo era punteggiato di sagome nere, accosciate, striscianti o miserevolmente piegate in due, schiena al vento. Con aria torva strinsi il nodo.
Steso il terzo telone — non eravamo una squadra da record di velocità — la maggior parte dei campi era coperta. Sciaguattando intorno al nostro ultimo telo, scendemmo lungo la sponda del fiume, da Kathryn. Il fiume spinse davanti a noi un pino di Torrey e lo trascinò sotto il ponte. L’albero pareva derelitto, sbatacchiato dalla corrente, con gli aghi ancora verdi, le radici bianche e nude.
Quasi tutti si erano radunati al canale di scolo, sommerso dalla pioggia: venti di noi, o anche più, guardavano i Mendez e i Nicolin correre intorno ai teloni e strisciarvi sotto, a tenderli, allentarli, sistemarli in maniera che drenassero nel modo dovuto. Alcuni si diressero allo stabilimento per i bagni; gli altri rimasero sotto gli ombrelli a parlare dei teloni stesi. I campi ora brillavano, distese di plastica ondulata; la pioggia colpiva i teloni e rimbalzava in aria, ogni goccia si divideva in una miriade di goccioline che subito ricadevano, tanto che la plastica era quasi invisibile sotto lo strato di nebbiolina bagnata. Ruscelli d’acqua si riversavano dai teloni nel canale di scolo, senza portarsi via il fango e il nostro raccolto estivo. Era uno spettacolo soddisfacente.
Sistemati i teloni, attraversammo tutti in gruppo il ponte, diretti allo stabilimento. Nella stanza principale Rafael si era dato da fare; faceva già caldo e i bagni fumavano. Alcuni si congratularono con Rafael per il fuoco, “un magnifico falò al coperto”, come disse Steve. Mentre mi toglievo gli abiti inzuppati, ammirai per la centesima volta il complicato sistema di tubi, pompe e vasche di raccolta escogitato da Rafael per riscaldare l’acqua da bagno. Entrai nella vasca per lo sporco, già piena di gente; era la più calda delle due e l’aria risuonava dei gemiti di piacere dei bagnanti scottati. Non sentivo i piedi, ma il resto bruciava. Poi il calore penetrò nella pelle e mi sembrò di avere, al posto dei piedi, due dei puntaspilli di Pa’. Ululai a gran voce. Il foglio di lamiera che formava il fondo della vasca era bollente; la maggior parte di noi si teneva a galla, si urtava, si schizzava, parlava della tempesta. Rafael pompava acqua a tutta velocità, con un ghigno da rana.
Il bagno pulito aveva sedili di legno fissati alle pareti; presto la gente vi si raccolse intorno, chiacchierando e rilassandosi nel tepore. Il rumore sordo della pioggia sul tetto di lamiera ondulata soffocava di tanto in tanto le chiacchiere; l’intensità del rumore era un segno esatto della violenza della pioggia; quando divenne più intenso, la gente smise di parlare e rimase in ascolto. Alcuni avevano collaborato a stendere i teloni prima ancora di coprire il proprio orto; si rimisero gli abiti bagnati (se non ne tenevano uno di scorta nello stabilimento) e uscirono, assicurandoci che sarebbero tornati in un baleno. E c’era da crederlo.
La luce del fuoco lanciava sul soffitto l’ombra danzante del sistema di tubazioni; le pareti d’assi brillavano del colore del fuoco. Tutti avevano la pelle arrossata. Le donne erano bellissime: Carmen Eggloff metteva sterpi sul fuoco e le costole le risaltavano sulla schiena; le ragazze si tuffavano come foche attorno a un sedile; Kathryn parlava, in piedi davanti a me, soda e tonda, la pelle lentigginosa imperlata di goccioline; la signora Nicolin si dimenava e strillava, mentre John le schizzava addosso acqua calda in una rara esibizione d’allegria. Me ne stavo seduto nel mio solito angolo, contento, ad ascoltare Kathryn e a guardarmi intorno: una stanza di animali dalla pelle di fuoco, bagnata e fumante, la chioma scompigliata, belli come cavalli.
La maggior parte ormai usciva dalla vasca e Carmen distribuiva la sua collezione d’asciugamani, quando una voce chiamò dall’esterno.
«Ehilà! Ehi, lì dentro!»
Tutti si zittirono. Nel silenzio (tamburellare sul tetto) udimmo con maggiore chiarezza: «Ehi, lì dentro! Salve a tutti! Siamo viaggiatori, veniamo dal sud! Americani!»
Istintivamente le donne, e gran parte degli uomini, afferrarono asciugamani o vestiti. M’infilai i calzoni infangati e freddi, seguii Steve alla porta. Tom e Nat Eggloff erano già sulla soglia; Rafael si unì a noi, ancora nudo; reggeva una pistola. John Nicolin si fece strada fra noi, tirandosi su le mutande, e uscì fuori.
«Cosa vi porta da queste parti?» chiese. Non riuscimmo a udire la risposta. L’attimo dopo, Rafael riaprì la porta. Due uomini con il poncho precedettero John all’interno; parvero sorpresi nel vedere Rafael. Erano inzuppati fradici, e per questo sembravano stanchi e male in arnese. Uno, pelle e ossa, aveva il naso lungo e una sottile striscia di barba nera lungo la mascella. L’altro, basso e tozzo, portava sotto il poncho un berretto floscio e bagnato. Si tolsero il poncho e misero in mostra giacche scure e calzoni bagnati. Il basso vide Tom e disse: «Ciao, Barnard. Ci siamo incontrati al raduno di scambio, ricordi?»
Читать дальше