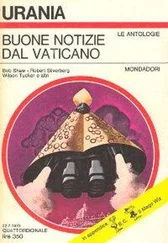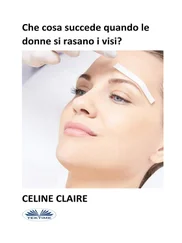Prima di cancellare anche il suo messaggio, annotai i due recapiti telefonici che mi lasciava su un foglietto che infilai in tasca.
«Chi era?» chiese Gloria. La mia espressione assorta doveva averla incuriosita.
«Una faccenda di cui mi ero dimenticato. Un agente dei servizi segreti danesi si è messa in contatto con me subito prima della tragedia. Cercava informazioni su una vecchia foto.»
«Ah, quella» disse Oscar.
«Di cosa state parlando?» domandò Gloria.
«Niente di importante» risposi alzando le spalle.
«La foto avrà fatto la stessa fine delle altre» disse Oscar.
«Sicuramente è nella valigia» dissi.
«Quale valigia?» insisté Gloria.
«Niente» risposi. «Lascia perdere.»
Gloria si fece seria e assunse la sua voce da avvocato, quel tono stridulo e affilato che in tribunale faceva venire i sudori freddi ai suoi avversari.
«Sei in possesso di foto e di negativi che non sono andati distrutti nell’esplosione? In caso affermativo, io, in qualità di tuo avvocato, ho bisogno di saperlo. Abbiamo preparato una bozza di richiesta di risarcimento per la compagnia di assicurazioni. Chiediamo un mucchio di soldi, sulla base del fatto che hai perso il frutto di tutta una carriera. Peter, non ho intenzione di sostenere la tua causa in tribunale se esiste il rischio che la controparte all’improvviso tiri fuori dal cilindro una foto di grande valore. Vuoi spiegarmi cos’è questa storia della valigia?»
La segretaria di Oscar fece capolino alla porta.
«È Londra» disse semplicemente e Oscar uscì dalla stanza.
«Allora, Lime?» insisté Gloria.
«Nell’arco degli anni di tanto in tanto ho selezionato alcuni negativi e li ho nascosti.»
«E perché?»
«Non lo so. C’è chi tiene un diario, io ho le foto. C’è chi fa collezione di francobolli. Io faccio collezione di istantanee.»
«Di che genere di fotografie si tratta?»
«Professionali, private, importanti, insignificanti, brutte, belle. Le mie foto.»
«Il negativo di Jacqueline Kennedy?» disse.
«Per esempio.»
«Quella da sola vale almeno un milione di corone. Dove è questa valigia? Voglio farle stimare, tutte quante.»
«Non se ne parla.»
«Peter!»
«Scordatelo.»
«Dove è la valigia?»
«Dimenticatene. Non ha importanza.»
«Con la tua ostinazione comprometterai la causa, Peter.»
«Allora lascia perdere tutto.»
«Neanche per sogno. Abbiamo le carte in regola per costringere quegli stronzi a sborsare un bel mucchio di soldi, sempre che tu la smetta di mettermi i bastoni tra le ruote.»
A motivare l’accanimento di Gloria non erano i soldi, ma la prospettiva dello scontro. Non replicai, e tra noi calò un silenzio imbarazzato. Entrambi ci accendemmo una sigaretta. Quando Oscar rientrò in ufficio avvertì la tensione nell’aria e inarcò le sopracciglia perplesso.
«Cosa è successo? Avete fatto fuori qualcuno?»
Gloria lo ignorò. «Vai a fare la tua gita, Peter. Ci sentiamo al tuo ritorno. Tanto, prima di ottobre non succederà niente.»
Mi parve che Oscar volesse aggiungere qualcosa, ma Gloria lo fulminò con lo sguardo.
Gloria e Oscar mi accompagnarono alla porta chiacchierando disinvoltamente di progetti per le vacanze. L’orribile agosto madrileno era alle porte, Gloria sarebbe andata a Londra, che amava moltissimo. Oscar avrebbe trascorso un paio di settimane in Irlanda e poi avrebbe raggiunto Gloria in Inghilterra. Mi strapparono una mezza promessa di unirmi a loro. Avrebbero voluto che tornassi a essere il vecchio Peter Lime, ma non si poteva riavvolgere la pellicola della vita.
Dall’ufficio mi recai all’ambasciata danese per ritirare il mio passaporto nuovo, poi tornai a casa per fare i bagagli e salutare Don Alfonso.
Mio suocero non era in casa. Aveva lasciato un biglietto sul tavolo della cucina: era andato in città per un paio di giorni per occuparsi della “nostra faccenda” e mi augurava buon viaggio.
Preparai lo zaino e lo assicurai al portapacchi della motocicletta. Le cavallette cantavano e dalle aiuole di Don Alfonso si levava una fragranza di polvere e fiori di pomodori. Chiusi la casa, inforcai l’Honda e mi avviai lentamente verso il cimitero. Accanto al biglietto, Don Alfonso aveva lasciato una splendida orchidea che avevo appoggiato di traverso sul serbatoio.
Le croci bianche e le lapidi di marmo cominciavano a tingersi di rosso nell’incipiente tramonto. Avevamo scelto una pietra semplice con i nomi di Amelia e Maria Luisa e le date di nascita e morte. Vi deposi l’orchidea e rimasi in attesa. Di una voce, di Dio, di una qualche rivelazione o anche solo di un momento di pace interiore. Ma non accadde nulla, così dopo poco montai in sella e ripartii.
Dai sobborghi di Madrid mi immisi sulla vecchia statale che portava verso nord. La conoscevo come le mie tasche, l’avevo percorsa centinaia di volte. Il sole tramontava alla mia sinistra in uno spumeggiare rosso che si allungò sulle montagne per poi scivolare come una lenta marea vermiglia sopra la pianura. Il traffico si fece più rado, fatto solo di piccole automobili e vecchi camion i cui conducenti non volevano pagare il pedaggio dell’autostrada. L’incendio rosso dell’orizzonte dava l’impressione di guidare verso un mare di sangue.
Guidai, nella tiepida oscurità notturna, per ore, fermandomi solo a fare benzina. Andare in moto di notte è viaggiare in silenzio, con il rombo del motore nelle orecchie e la solitudine addosso.
La Honda ronzò e fremette tra le mie gambe, finché le mie natiche si fecero insensibili, poi doloranti. Quando il cielo stellato finì di risucchiare il calore del giorno, mi misi il casco.
Ero esausto, ma mi dispiacque quando, una ventina di chilometri dopo San Sebastián, svoltai per la strada che si arrampicava su per le colline fino al rifugio mio e di Amelia. Il viaggio, l’andare, rappresentavano la mia condizione ideale. In lontananza le montagne s’incurvavano massicce come dorsi d’elefante nella tenue alba.
La casa era una vecchia costruzione di granito grande abbastanza per ospitare venti persone. L’avevo comprata all’inizio degli anni Ottanta; Amelia se n’era innamorata a prima vista, quando ancora non avevo l’assoluta certezza che amasse anche me. Insieme l’avevamo ristrutturata. C’erano due piani e una grande cantina per i vini e i formaggi, ma di solito trascorrevamo gran parte del tempo in cucina, dove la grossa stufa spandeva un bel tepore nel freddo inverno basco e nelle sere nebbiose d’estate.
La casa più vicina era quella di Arregui, un paio di chilometri più in su. Arregui allevava pecore da quando aveva dieci anni. In quell’epoca uno dei suoi zii era rimasto ucciso in uno scontro con la guardia civile: per lui pecore e nazionalismo andavano a braccetto, erano tutta la sua vita. Ogni mese gli mandavo una busta con un po’ di soldi perché tenesse d’occhio la casa, la rifornisse di legna asciutta e tenesse lontano i banditi. Lui lo avrebbe fatto gratis, ma ero riuscito a convincerlo ad accettare quel compenso spiegandogli che avrei potuto detrarre l’importo dalle tasse, e quindi versare qualche soldo in meno al potere centrale. A dispetto dell’età decisamente avanzata, Arregui sollevava macigni, spaccava tronchi e giocava alla pelota a mani nude negli annuali tornei estivi. Il suo primogenito era rimasto vittima del regime franchista nel 1972; il secondo figlio, Tómas, di cui ero diventato amico, aveva passato tre anni nel braccio della morte, fino all’amnistia del 1977. La sua unica figlia stava scontando l’ergastolo in un carcere a sud di Siviglia, condannata per l’omicidio di un capitano della Guardia Civil avvenuto cinque anni addietro. Nonostante tutto, Arregui si dichiarava orgoglioso di aver allevato dei buoni figli baschi che gli avevano fatto onore.
Читать дальше