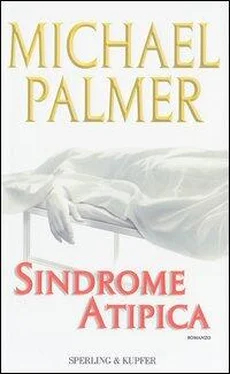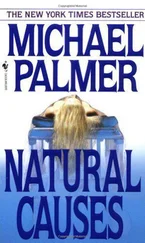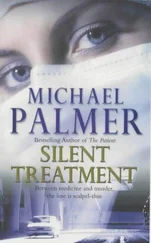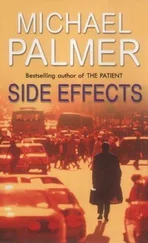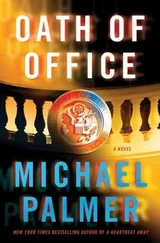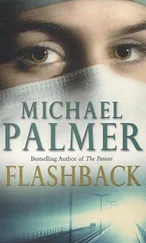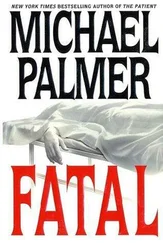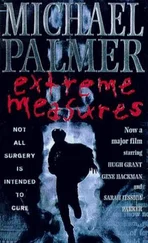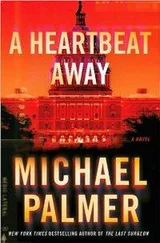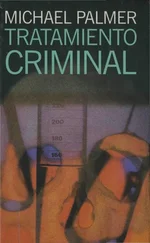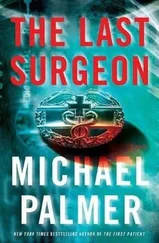«Lei non oserebbe mai fare del male a questa bambina!» esclamò Ellen con voce stridula.
L’uomo la fissò placidamente. Avrebbe voluto balzare in piedi e strappargli con le unghie quell’espressione soddisfatta dalla faccia.
«Farò qualsiasi cosa ci sia da fare», ribatté lui con fermezza. «Mi guardi e non dubiti di me neppure per un secondo. Se non crede alle mie parole, lei e solo lei sarà responsabile delle conseguenze. Le persone per cui lavoro hanno dato a questa faccenda precedenza assoluta. Dovesse deluderci in qualsiasi modo, le prometto che sua nipote sparirà… per sempre. Ciò che le capiterà dopo essere scomparsa, è qualcosa a cui lei neppure vorrà pensare. E, a seconda di quanto arrabbiati saranno i miei datori di lavoro, quello sarà forse solo l’inizio.»
L’arroganza del mostro seduto accanto a lei mise la sordina alla sua ira ed Ellen riuscì solo a esprimerla con lo sguardo.
«Mi sono spiegato?» chiese l’uomo. «Mi sono spiegato?» Per la prima volta alzò la voce.
«S… sì», riuscì a rispondere Ellen.
«Se vuole può rivolgersi alla polizia, ma le prometto due cose. Uno, lo scopriremo, e, due, la polizia non potrà fare nulla per evitare che succeda ciò che le ho promesso. Capito?»
«Sì.»
«Bene. Allora, siamo d’accordo?»
«Sì», ripeté lei, ora pericolosamente sul punto di piangere.
«Fantastico», commentò l’uomo, alzandosi in piedi.
Eretto in tutta la sua altezza, con quelle spalle larghe e la testa massiccia, era terrificante. Rilassato come se stesse raccogliendo il giornale, si chinò e prese la busta e le fotografie. La puzza di tabacco che emanava fece quasi vomitare Ellen. Il killer prese poi dalla tasca il cellulare, lo aprì e si collegò a un numero premendo un solo tasto.
«Abbiamo finito», disse semplicemente.
Pochi secondi dopo, un’automobile si fermò fuori della casa.
«La ringrazio per la sua ospitalità, signora Kroft», disse. «E la sua famiglia, ne sono certo, la ringrazia per il suo buonsenso. Non c’è bisogno che mi accompagni alla porta.»
Chiuse le tende della finestra panoramica e, con un ultimo sorriso, se ne andò. Ellen corse alla finestra e infilò la testa tra le tende, sperando di scorgere il numero della targa, ma l’automobile, una anonima berlina, si stava già allontanando giù per la strada.
Raramente, quando si svegliava, Matt ricordava il sogno fatto e, ancora più raramente, era consapevole di sognare mentre lo faceva. Questa volta però, lo sapeva. Era nello stesso tempo partecipante e osservatore, atterrito a ragione, eppure stranamente distaccato e analitico.
C’era un enorme mostro Gila, squame color arancione che scintillavano nella luce solare chiazzata. Il lucertolone velenoso, alto come un edificio, si spostava per la fitta foresta, la grossa coda che sbatteva sugli alberi, le tozze zampe che schiacciavano qualsiasi cosa si trovasse sul suo cammino. La lingua nera schioccava come una frusta, tranciando le punte dei pini. Continuava a sbattere contro il fianco roccioso di una collina, facendo precipitare le pietre dove si trovava Matt. All’improvviso vi furono anche uomini con armi, ombre vaghe che sparavano di continuo, cacciando proiettili su proiettili nel corpo della lucertola. Il Gila si drizzò sulle zampe posteriori, tenendosi in equilibrio sulla coda, alla ricerca della causa del dolore. Sempre più uomini… sempre più fucili… sempre più spari… sempre più fiammate… sempre più urla… e ora anche sangue che spruzzava da un centinaio di ferite lungo il fianco del mostro. L’enorme testa nera e arancione oscillava da una parte all’altra, le poderose fauci si aprivano e si chiudevano su null’altro che aria.
«Nooo!» Matt sentì se stesso gridare. «Basta!»
Ferita a morte, la bestia crollò, urlando contro i suoi assassini, sbattendo le zampe anteriori, lacerando più volte il braccio di Matt. Fu allora che ebbe l’impressione di essersi svegliato. Socchiuse gli occhi. Qualcosa continuava a graffiargli il braccio. Poi si rese conto che non era niente di più maligno di una mano che gli grattava il gomito. Era seduto su una sedia in un cubicolo circondato da vetrate all’unità di Terapia Intensiva, la stanza della dottoressa Solari. Accasciato su un fianco, aveva dormito, la testa appoggiata per metà sulla spalla e per metà sul letto. Era stata Nikki Solari a svegliarlo dal suo strano incubo con un colpetto. Attraverso il vetro, Julie Bellet, una delle infermiere di notte, lo salutò, sorridendo. L’orologio a muro alle sue spalle indicava le cinque e mezzo.
La mente di Matt si schiarì rapidamente. L’irrigidimento al collo gli fece capire che non si era mosso da un bel po’. La sua paziente, le braccia bloccate da cinghie in cuoio, lo stava implorando silenziosamente nella semioscurità. Gli occhi spalancati erano colmi di paura e confusione. Il tubo in poliestere che le aveva infilato tra le corde vocali era ancora al suo posto. L’apparecchio per la respirazione artificiale attaccato al tubo ronzava e sibilava mentre pompava aria nei polmoni della giovane a ogni respiro. Julie Bellet entrò nella stanzetta.
«Buongiorno a tutti», esclamò. «Ha dormito per almeno tre ore. Aveva un aspetto tanto sereno che nessuno di noi ha avuto il coraggio di svegliarla.»
«Io… ehm… ero un po’ stanco», riuscì a dire. «Penso sia ora di abbandonare il decaffeinato e tornare a quello forte e nero.»
Fece un timido sorriso e si girò verso Nikki. Sapeva dai racconti di chi si era svegliato attaccato a un respiratore quanto fosse spiacevole e spaventosa la sensazione data dal tubo infilato giù per la gola e nella trachea, avendo per di più le mani legate con le cinghie. Accese la lampada a fluorescenza sopra la testa.
«Dottoressa Solari, mi spiace di essermi addormentato così. Sono stati due giorni duri. Io sono Matt Rutledge, il suo medico. Mi capisce?» Nikki annuì, gli occhi fissi sul suo viso. «Bene», continuò. «Lei si trova nell’ospedale regionale dalla contea di Montgomery, a Belinda, nel West Virginia. Ho dovuto infilarle il tubo, perché ieri lei è quasi annegata in un lago. È rimasta priva di sensi per più di dodici ore.»
Nikki, ignorando il dolore alle tempie, allungò il più possibile la mano e indicò il suo viso.
Il tubo. Lo tiri fuori! Per favore, me lo tolga. Mi sta soffocando!
Nikki pregò che il medico la comprendesse.
Matt Rutledge aveva qualche anno più di lei, e un viso gentile e virile. I capelli scuri erano tirati all’indietro in una coda di cavallo che gli scendeva fin sopra il colletto della camicia.
«So che vorrebbe che le togliessi subito il tubo», disse. «So che è terribile, ma la prego, faccia del suo meglio per rilassarsi e respirare con calma. Pensa di avere bisogno di qualche farmaco per riuscirci?… Bene. Mi faccia un segno se dovesse cambiare idea. Il respiratore l’aiuta, tutto quello che lei deve fare è respirare. Le prometto che le toglierò il tubo appena potrò. Prima devo farle una radiografia e controllare il livello d’ossigeno nel sangue. Se le tolgo le cinghie, mi promette di tenere le mani lontane dal tubo?»
Nikki annuì. L’infermiera, che era rimasta sulla porta, si avvicinò, si presentò e slegò le cinghie.
«Nikki», disse, «il palloncino è ancora gonfio. La prego di non cercare di togliere il tubo. Potrebbe rovinarsi le corde vocali. D’accordo?»
Nikki si sforzò di annuire, anche se le sembrava di avere una canna per innaffiare in gola. A livello conscio, sapeva a che cosa serviva quel tubo, ma aveva la sensazione che la stesse soffocando. Chiuse gli occhi, mentre il medico le auscultava cuore e polmoni, le esaminava l’addome e controllava il battito alle braccia e alle gambe. Poi le chiese di aprire gli occhi e li esaminò con un oftalmoscopio. Aveva un modo di fare rassicurante e un tocco delicato. Per quanto poteva dire, sembrava sapesse quel che stava facendo. Si appoggiò al cuscino e si sforzò di respirare più lentamente. Pezzo dopo pezzo, gli eventi sulla strada e nel bosco si riordinarono.
Читать дальше