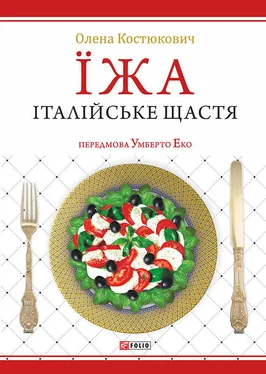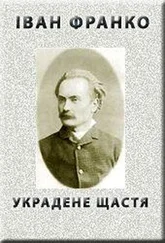Олена Олександрівна Костюкович
Їжа – італійське щастя
Il linguaggio universale dell'italia
Perché dovrei scrivere la prefazione a un libro di cucina? Me lo sono chiesto quando l’autrice me lo ha domandato, e ho avuto il sospetto di aver subito acconsentito perché Elena Kostioukovitch è la mia traduttrice in russo e io l’ammiro non solo per l’amore e la pazienza che ha dedicato ai miei libri ma anche per la sua intelligenza e la sua vasta cultura. Ma basta questa ragione, mi domandavo, visto che io non sono un gourmet?
Intendiamoci, il gourmet non è colui che, di fronte a un eccellente canard à l’orange o a una generosa porzione di caviale del Volga con bliny, si dichiara soddisfatto e felice. Costui è solo una persona normale, dai gusti non depravati e che non si chiama McDonald. No, il gourmet, il buongustaio, l’appassionato di cucina è colui che è capace di affrontare un viaggio di centinaia di chilometri per andare in quel tal ristorante dove fanno il canard à l’orange migliore del mondo. E io non sono una persona di questo genere perché di solito, tra il mangiare una pizza sotto casa e fare non dico duecento chilometri ma anche una corsa in taxi per andare a scoprire una nuova trattoria, scelgo la pizza.
Ma è proprio così? Mi sono reso conto che ho fatto chilometri e chilometri nelle Langhe (vicino alle quali sono nato, e di cui Elena parla nel capitolo dedicato al Piemonte) per condurre un amico francese (lui sì, gran gourmet) a scoprire i leggendari tartufi d’Alba, e altri chilometri ho fatto per partecipare a una seduta di bagna cauda a Nizza Monferrato dove il pranzo iniziava a mezzogiorno e terminava alle cinque del pomeriggio e tutto, salvo il caffè finale, era a base di aglio. E una volta sono andato nella più remota periferia di Bruxelles per assaggiare quella birra belga che si chiama gueuze e che può essere gustata solo sul posto, perché non sopporta il trasporto (tra parentesi, non andateci, meglio una buona ale inglese).
E allora? La cucina m’interessa o no? Riandiamo un momento agli esempi che ho citato. Una volta era per scoprire che tipo di birra amano i belgi, l’altra per far conoscere la civiltà piemontese a uno straniero e un’altra ancora per ritrovare il sapore di un rito come quello della bagna cauda che mi ricordava momenti magici della mia infanzia… In tutti questi casi andavo alla ricerca di cibo non per ragioni di palato ma per ragioni di cultura, voglio dire non (o non soltanto) per sentire un sapore nella bocca, ma per avere un’illuminazione, o il bagliore di un ricordo, o capire e far capire una tradizione, una civiltà.
E mi sono reso conto che, certo, se sono da solo, prendo la pizza sotto casa e non mi avventuro in un’esplorazione culinaria, ma non appena arrivo in un altro paese, prima ancora di visitare i musei o le chiese, faccio due cose: anzitutto cammino per le strade, cerco di perdermi in modo da girare a vuoto, a lungo, per vedere la gente, le vetrine, i colori delle case, sentire gli odori; e poi vado a cercare il cibo locale, perché senza l’esperienza del cibo non capirei il luogo in cui sono e il modo di pensare di chi vi abita.
E mi sono reso anche conto che in tutti i miei romanzi forse un po’ meno nel Pendolo di Foucault dove i protagonisti (e i lettori) vivono per così dire a casa propria, tra Milano e Parigi, ma certamente moltissimo in Baudolino, ne L’isola del giorno prima e nel mio ultimo, La misteriosa fiamma della regina Loana faccio mangiare moltissimo i protagonisti, così come faccio mangiare almeno una volta i monaci de Il nome della rosa, e li faccio girare a lungo in cucina. Perché, se ti avventuri nelle isole dei mari del Sud o nell’Oriente bizantino, o in un universo scomparso da centinaia o da decine di anni, devi far mangiare il lettore, per condurlo a capire come pensano i personaggi.
Ho dunque un’ottima ragione per introdurre il libro di Elena. Perché Elena, che pure si rivela prodigiosa conoscitrice della cucina italiana in tutte le sue sfumature e i suoi misteri, ci conduce per mano (e diciamo pure per palato e per naso) nel suo viaggio culinario non solo per farci conoscere dei cibi ma per farci conoscere l’Italia, che essa ha passato la vita a scoprire.
Questo che state per leggere è un libro sulla cucina ma anche un libro su un paese, su una cultura, anzi, su molte culture.
Infatti è sempre imbarazzante parlare di «cultura italiana» così come è imbarazzante parlare di «paesaggio italiano». Se prendete un’automobile e visitate gli Stati Uniti, vi può capitare di viaggiare giorni e giorni per orizzonti sterminati (e quando vi fermate avrete sempre lo stesso hamburger della sosta precedente); se viaggiate nel Nord Europa potete percorrere a lungo, per orizzonti altrettanto ampi, chilometri di autostrada vedendo soltanto magnifici campi di segale e naturalmente non cito l’esperienza di un viaggio per le steppe dell’Asia centrale, per i deserti del Sahara e di Gobi, per le distese australiane, al centro delle quali si leva il gran sasso di Ayers Rock. Questa esperienza di un contatto con l’immensità della natura ha prodotto l’idea del Sublime, che nasce sempre di fronte a mari in tempesta e a cieli, abissi, picchi montani sproporzionati, rupi impervie, ghiacciai senza fine, distese senza confini.
Bene, non si viene in Italia per trovare la vertigine verticale delle cattedrali gotiche, l’immensità delle piramidi, le cascate del Niagara. Una volta che avrete superato le Alpi (dove certamente potreste avere impressioni sublimi, ma le potreste trovare anche in Francia, in Svizzera, in Germania o in Austria), iniziate ad avere un’esperienza diversa. L’orizzonte non si amplia mai a dimensioni titaniche, perché è sempre limitato a destra da una collina, a sinistra da un moderato rilievo montano, e il cammino è spezzato continuamente da piccoli centri abitati, almeno uno ogni cinque chilometri. E a ogni tratto di strada (salvo in un certo tratto della pianura del Po) avrete una curva, un mutamento di rotta, e il paesaggio cambierà, così che non solo da regione a regione ma all’interno della stessa regione voi scoprirete sempre un paese diverso, con infinite gradazioni dalla montagna al mare, passando attraverso colline di varia conformazione. Vi sono poche analogie tra le colline del Piemonte e quelle delle Marche o della Toscana, talora basta varcare da est a ovest o viceversa l’Appennino, che percorre tutto lo Stivale come una spina dorsale, per avere l’impressione di entrare in un altro paese. Sono diversi persino i mari, che sulla costa del Tirreno vi offrono panorami, tipi di spiagge, coste, diversi da quelli della costa adriatica, per non dire dei mari delle isole.
Questa varietà non è solo propria del paesaggio, ma anche dei suoi abitanti. L’Italia ha dialetti diversi, che cambiano da regione a regione, così che se un siciliano ascolta un piemontese del Nord-ovest non capisce affatto che cosa stia dicendo. Ma pochi stranieri immaginano che i dialetti mutano da città a città, all’interno della stessa regione, e talora, sia pure di poco, da villaggio a villaggio.
È che nello Stivale convivono i discendenti delle tribù celtiche o liguri che abitavano il Nord prima della penetrazione romana, degli illiri dell’Est, degli etruschi e dei vari ceppi italici del Centro, dei greci del Sud, e poi delle varie etnie che si sono sovrapposte nel corso dei secoli alle popolazioni autoctone, i goti, i longobardi, gli arabi e i normanni (per non dire dei francesi, spagnoli, austriaci e ricordando che ai confini del Nord-ovest si parla qualcosa di molto simile al francese, e tedesco sulle montagne del Nord-est, e albanese in alcune località del Sud).
Questa stessa varietà di paesaggi, di lingue e di gruppi etnici caratterizza anche e soprattutto la cucina. Non la cucina italiana che si gusta all’estero e che, per buona che sia, è come la cucina cinese gustata fuori della Cina, una sorta di koinè, di cucina generica, che si ispira a diverse regioni, e fatalmente concede qualcosa al gusto locale e alle attese del cliente «medio» che cerca un’immagine «media» dell’Italia.
Читать дальше