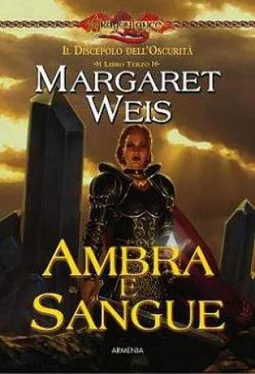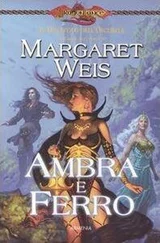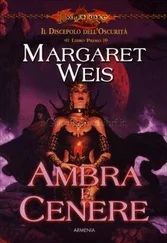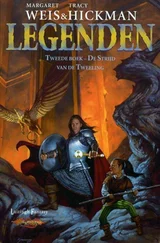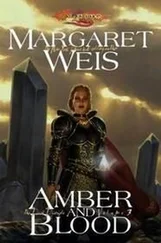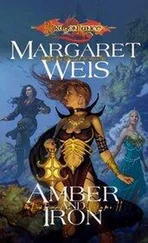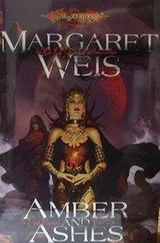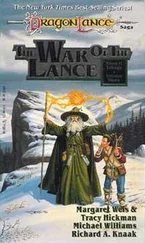Portava con sé i due oggetti sacri che aveva asportato dalla Sala del Sacrilegio. Li teneva stretti in mano e non intendeva mollarli, anche se quel fardello talvolta le rendeva difficile avanzare sul sentiero ripido. Quando finalmente si arrese e si sedette per riposarsi, estrasse gli oggetti sacri dalla bisaccia e li guardò, studiandoli, prendendoli su a turno e tenendoli fra le mani, passandoci sopra le dita come avrebbe fatto un cieco che cercasse di usare le mani per vedere ciò che gli occhi senza luce non potevano cogliere. Non disse nulla a Valthonis dei suoi pensieri, e lui non fece domande.
Mentre si avvicinavano a Godshome, i Signori del Destino parvero attenuare la loro ostilità sui viandanti, approvando il loro procedere. Il sentiero si fece più agevole e li condusse giù per un lieve pendio. Una brezza calda, come un alito di primavera, soffiò via i fumi di zolfo e il vapore. Lungo il sentiero comparvero fiori selvatici, che facevano capolino da sotto i macigni o crescevano nelle fenditure di una parete di pietra.
“Che cosa c’è che non va?” domandò Valthonis, facendo una sosta, quando notò che Mina aveva cominciato a zoppicare.
“Ho una vescica”, rispose lei.
Sedendosi per terra, Mina si tolse la scarpa, guardando con irritazione quella ferita aperta e sanguinante.
“Gli dei giocano a fare i mortali”, disse. “Chemosh sapeva fare l’amore con me traendo piacere dall’atto; o perlomeno così si era convinto. Ma in verità possono solo fingere di provare sensazioni. Nessun dio ha mai una vescica sul tallone.”
Sollevò la scarpa macchiata di sangue per mostrarla a Valthonis.
“Allora perché io ho una vescica?” domandò Mina. “Io so di essere una dea. So che questo corpo non è reale, io potrei balzare giù da questo dirupo e precipitare sulle rocce sottostanti e non mi succederebbe nulla. Io lo so, ma comunque”, disse mordendosi il labbro, “il piede mi fa male. Per quanto io possa desiderare di dire che in realtà non mi fa male, mi fa male davvero!”
“Takhisis doveva convincerti che eri umana, Mina”, disse Valthonis. “Ti ha mentito per renderti sua schiava. Se tu avessi saputo la verità, che eri una dea, temeva che diventassi una sua rivale. Dovevi essere indotta a credere di essere umana e pertanto dovevi provare dolore. Dovevi conoscere la malattia e il dispiacere. Dovevi sperimentare l’amore, la gioia e il dolore. Takhisis ha tratto un piacere crudele nel farti credere di essere mortale. Pensava che questo ti rendesse debole.”
“Ed è vero!” sbottò Mina, e gli occhi d’ambra luccicarono di collera. “E lo detesto. Quando assumerò il mio posto nel pantheon, non potrò mostrare debolezza. Devo imparare a dimenticare ciò che sono stata.”
“Non ne sono tanto sicuro”, disse Valthonis, inginocchiandosi davanti a lei e osservandola attentamente. “Tu dici che gli dei giocano a fare i mortali. Non “giocano”. Assumendo un certo aspetto della mortalità, un dio cerca di provare ciò che provano i mortali. Gli dei cercano di capire i mortali per aiutarli e guidarli oppure, in certi casi, obbligarli e terrorizzarli. Ma sono dei, Mina, e per quanto si sforzino non possono capire veramente. Tu sola conosci il dolore della mortalità, Mina.”
Mina ci meditò sopra. “Hai ragione”, disse alla fine, pensierosa. “Forse è per questo che io sono in grado di esercitare un tale potere sui mortali.”
“È questo che vuoi? Esercitare potere su di loro?”
“Ma certo! Non è ciò che vogliamo tutti?” Mina si accigliò. “Ho visto gli dei all’opera, quel giorno a Solace. Ho visto il sangue versato e i corpi accatastati davanti agli altari. Se i mortali vogliono combattere e morire per la loro fede, perché non dovrebbero andare verso la morte cantando il mio nome anziché quello di qualcun altro?”
Si infilò di nuovo la scarpa e si alzò e si mise a camminare. Sembrava intenta a cercare di convincersi di non provare nulla e camminare normalmente, ma non poté sopportarlo. Sobbalzando per il dolore, si arrestò.
“Tu eri un dio”, disse. “Ricordi qualcosa di quello che eri? Ricordi il momento prima della creazione? La tua mente abbraccia ancora la vastità dell’eterno? Riesci a vedere fino ai limiti del cielo?”
“No”, rispose Valthonis. “La mia mente è quella di un mortale. Vedo l’orizzonte e talvolta nemmeno quello, se le nubi lo oscurano. Sono contento di questo. Credo che altrimenti sarebbe troppo terribile da sopportare.”
“Infatti”, disse sottovoce Mina.
A strattoni si tolse entrambe le scarpe e le gettò oltre il ciglio del dirupo. Prese a camminare scalza, posando guardinga il piede sul sentiero, e quasi subito si procurò un taglio su un ciottolo aguzzo. Rimase senza fiato e si arrestò di colpo. Serrò i pugni per la frustrazione.
“Io sono una dea!” gridò. “Non ho piedi!”
Fissò le punte dei piedi nudi, come desiderando che sparissero.
Le punte dei piedi rimasero lì, contorcendosi e conficcandosi nella polvere.
Mina gemette e si accasciò, si accovacciò, si rannicchiò in se stessa.
“Come posso essere una dea se sarò sempre una mortale? Come posso camminare fra le stelle se ho vesciche ai piedi? Non so essere una dea, padre mio! Io so soltanto essere umana…”
Valthonis la cinse con le braccia e la sollevò. “Non serve che tu cammini più, figliola. Siamo arrivati”, disse.
Mina lo fissò, meravigliata. “Dove?”
“A casa”, rispose lui.
Al centro di una valle a forma di ciotola dai lati lisci, diciannove pilastri stavano di guardia silenziosi attorno a una pozza circolare di ossidiana danneggiata dal fuoco, di un nero lucente. Sedici pilastri erano vicini fra loro. Tre erano separati. Uno di questi era di giaietto nero, uno di granito rosso, l’altro di giada bianca. Cinque dei pilastri rimanenti erano di marmo bianco. Cinque erano di marmo nero. Sei erano fatti di marmo di un colore indefinito.
Un tempo sorvegliavano la pozza ventuno pilastri. Due di questi si erano rovesciati a terra. Uno, un pilastro nero, era andato in frantumi nella caduta. Non ne rimaneva altro che un mucchio di detriti spezzati. L’altro pilastro caduto era ancora intatto, con la superficie che brillava alla luce solare, ripulito dalla polvere da mani amorevoli.
Mina e Valthonis si trovavano all’esterno dei pilastri di pietra e guardavano dentro. Il cielo era terso, e di un azzurro intenso. Il sole oscillava precariamente sulle cime dei Signori del Destino, diffondendo ancora la sua luce radiosa, ma da un momento all’altro sarebbe scivolato giù per la montagna precipitando nella notte. La valle era avvolta nel crepuscolo; ombre proiettate dalle montagne, luce solare che luccicava sulla pozza di ossidiana.
Mina scrutava con incanto assorto la pozza nera. Si incamminò verso di essa, pronta a farsi strada a fatica nello stretto passaggio fra due pilastri, quando si rese conto che Valthonis non era più al suo fianco. Si girò e lo vide in piedi accanto alla piccola fenditura nella parete di roccia attraverso cui erano entrati.
“Il dolore non finirà mai, vero?” domandò.
La risposta di Valthonis fu il suo silenzio.
Mina estrasse dalla bisaccia gli oggetti sacri di Paladine e Takhisis e li tenne uno in ciascuna mano. Depose ai piedi di un pilastro di marmo bianco striato di arancione la bisaccia che era appartenuta al monaco, quindi si infilò tra i pilastri e mise piede sulla pozza di ossidiana di un nero lucente. Alzando gli occhi d’ambra, scrutò i cieli e vide le costellazioni degli dei brillare nel firmamento.
Ecco gli Dei della Luce, rappresentati dall’arpa di Branchala, dalla fenice di Habbakuk, dalla testa di bisonte di Kiri-Jolith, dalla rosa di Majere, dal simbolo dell’infinito di Mishakal. Sul lato opposto di questi vi erano gli Dei delle Tenebre, Chemosh col suo teschio di capra, la bilancia rotta di Hiddukel, il cappuccio nero di Morgion, il condor di Sargonnas, la tartaruga drago di Zeboim. A separare le tenebre dalla luce, pur tenendole assieme, vi erano il Libro di Gilean, il martello forgiatore del creato di Reorx, i pianeti dalla luminosità costante di Shinare, Chislev, Zivilyn, Simon. Più vicine ai mortali che alle stelle erano le tre lune: la luna nera di Nuitari, la luna rossa di Lunitari, la luna argentea di Solinari.
Читать дальше