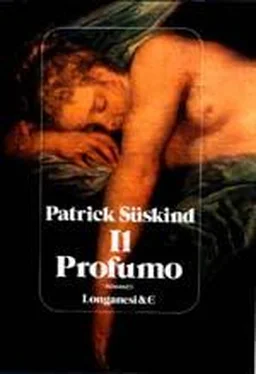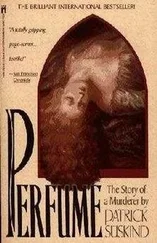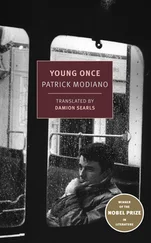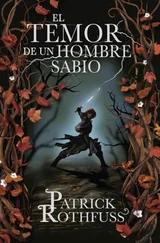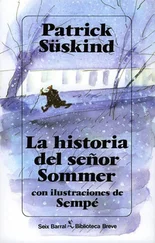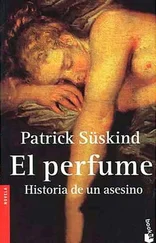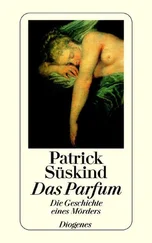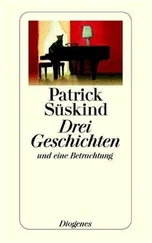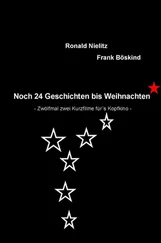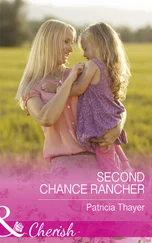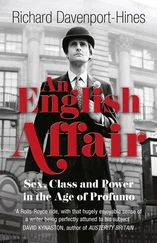In mancanza di zingari passarono a sospettare i lavoratori stagionali italiani. Ma non c’erano neppure italiani, per loro era troppo presto, sarebbero arrivati in paese soltanto a giugno, per la raccolta dei gelsomini, dunque non potevano essere stati loro. Infine furono sospettati i fabbricanti di parrucche, presso i quali cercarono i capelli della fanciulla assassinata. Inutilmente. Allora si pensò che fossero stati gli ebrei, poi i monaci, presunti lussuriosi, del convento dei benedettini — che naturalmente erano tutti già oltre i sessanta — poi i cistercensi, poi i massoni, poi i malati di mente della Charité, poi i carbonai, poi i mendicanti, e buon’ultima la nobiltà dissoluta, in particolare il marchese di Cabris: infatti, si era sposato già per la terza volta, allestiva, dicevano, messe orgiastiche nelle sue cantine e in tali occasioni beveva sangue di vergine per aumentare la propria potenza sessuale. Ovviamente non si riuscì a provare nulla in concreto. Nessuno aveva assistito al delitto, abiti e capelli della morta non furono trovati. Dopo qualche settimana il tenente di polizia sospese le indagini.
A metà giugno arrivarono gli italiani, molti con le loro famiglie, per andare a servizio come raccoglitori. I contadini li assunsero, ma, memori del delitto, proibirono alle mogli e alle figlie di frequentarli. La prudenza non era mai troppa. Infatti, sebbene in realtà i lavoratori stagionali non fossero responsabili del delitto accaduto, in linea di principio avrebbero ben potuto esserlo, e quindi era meglio guardarsi da loro.
Poco dopo l’inizio della raccolta dei gelsomini ci furono altri due delitti. Di nuovo le vittime erano fanciulle bellissime, di nuovo appartenevano a quel tipo malinconico dai capelli neri, di nuovo furono trovate in campi di fiori nude e coi capelli tagliati, con una ferita da botta alla nuca. Di nuovo non c’era traccia del colpevole. La notizia si diffuse con la rapidità di un incendio, e quando si seppe che entrambe le vittime erano italiane, figlie di un bracciante genovese, ci fu il rischio che scoppiassero ostilità contro gli immigrati.
Ora la paura gravava sul paese. La gente non sapeva più su chi dirigere la sua rabbia impotente. C’era sì ancora qualcuno che sospettava i pazzi o l’ambiguo marchese, ma nessuno ci credeva fino in fondo, perché i pazzi erano sorvegliati giorno e notte, e il marchese era partito da tempo per Parigi. Quindi gli uomini si appressarono l’uno all’altro. I contadini aprirono i loro granai agli immigrati, che fino allora si erano accampati all’aperto. I cittadini allestirono in ogni quartiere un servizio di pattuglie notturne. Il tenente di polizia rafforzò le guardie alle porte della città. Ma tutti i provvedimenti non servirono a nulla. Pochi giorni dopo il duplice omicidio, si trovò ancora il cadavere di una fanciulla, conciato come i precedenti. Questa volta si trattava di una lavandaia sarda del palazzo vescovile, che era stata uccisa vicino al grande bacino d’acqua alla Fontaine de la Foux, dunque proprio davanti alle porte della città. E sebbene le autorità, spinte dalla cittadinanza eccitata, avessero intrapreso nuove misure — controlli più rigidi alle porte della città, rinforzo della guardia notturna, divieto di uscire per tutte le persone di sesso femminile dopo il calar delle tenebre — quell’estate non passò più settimana senza che si trovasse il cadavere di una giovanetta. E sempre si trattava di adolescenti che avevano appena cominciato a farsi donne, e sempre delle più belle e per lo più di quel tipo scuro e vischioso. Per quanto l’assassino ben presto non disdegnasse più neppure il tipo femminile predominante nella popolazione locale, molle, di pelle bianca e lievemente corpulenta. Da ultimo erano diventate sue vittime persino le castane, adolescenti dai capelli biondo-scuro… sempreché non fossero troppo magre. Le braccava ovunque, non più soltanto nei dintorni di Grasse, ma nel cuore della città, addirittura nelle case. La figlia di un falegname fu trovata morta nella sua stanza al quinto piano, e nessuno in casa aveva sentito il minimo rumore, e non uno dei cani, che in genere fiutavano qualsiasi sconosciuto e lo segnalavano con latrati, aveva abbaiato. Sembrava che l’assassino fosse inafferrabile, immateriale, come uno spirito.
La gente s’indignò e se la prese con l’autorità. La minima diceria provocava assembramenti. Un mercante girovago, che vendeva polverine d’amore e ciarlatanerie varie, fu quasi massacrato, perché si disse che i suoi rimedi contenevano capelli triturati di giovanette. Al palazzo di Cabris e all’ospizio della Charité tentarono di appiccare incendi. Il mercante di tessuti Alexandre Misnard sparò al proprio domestico uccidendolo mentre costui tornava a casa di notte, poiché l’aveva scambiato per il famigerato assassino delle fanciulle.
Chi poteva permetterselo, mandò le figlie adolescenti da parenti lontani o in pensionati a Nizza, Aix o Marsiglia. Il tenente di polizia fu destituito dalla sua carica in seguito alle pressioni del consiglio municipale. Il suo successore fece esaminare i cadaveri di quelle bellezze private dei capelli da un collegio di medici, per accertare la loro condizione verginale. Risultò che erano tutte intatte.
Stranamente questo annuncio aumentò l’orrore, anziché diminuirlo, perché in cuor suo ognuno aveva pensato che le fanciulle fossero state violentate. In tal modo potevano almeno conoscere il movente dell’assassino. Ora non sapevano più nulla, erano totalmente confusi. E chi credeva in Dio si rifugiava nella preghiera, perché almeno la sua casa fosse risparmiata dalla visita del demonio.
Il consiglio municipale — un organo composto da trenta fra i cittadini e i nobili più ricchi e più stimati di Grasse, per lo più gente illuminata e anticlericale, che finora non aveva tenuto in gran conto il vescovo e per lo più aveva trasformato conventi e abbazie in magazzini e fabbriche — i fieri, potenti signori del consiglio municipale, nel momento del bisogno, acconsentirono a pregare monsignore il vescovo, con una petizione redatta in tono sottomesso, affinché maledicesse e colpisse con la scomunica il mostro che assassinava le fanciulle e su cui le forze terrene non riuscivano a prevalere, così come aveva fatto il suo illustre predecessore nel 1708 con le terribili cavallette che a quel tempo minacciavano il paese. E in effetti l’assassino delle fanciulle di Grasse, che fino allora aveva strappato a tutti i ceti della popolazione non meno di ventiquattro tra le vergini più belle, fu scomunicato e maledetto solennemente dal vescovo in persona, sia per iscritto con un affisso sia a voce da tutti i pulpiti della città, tra i quali anche il pulpito di Notre-Dame-du-Puy.
Il successo fu travolgente. I delitti cessarono da un giorno all’altro. Ottobre e novembre trascorsero senza cadaveri. All’inizio di dicembre da Grenoble giunsero rapporti su un assassino di fanciulle che di recente circolava nel luogo, strangolava le sue vittime e strappava loro gli abiti a brandelli dal corpo e i capelli a mazzi dalla testa. E sebbene questi rozzi crimini non avessero niente a che vedere con i delitti di Grasse, eseguiti in modo ineccepibile, tutti erano convinti che si trattasse di un solo e unico autore. Gli abitanti di Grasse si fecero tre volte il segno della croce dal sollievo che la bestia imperversasse non più tra di loro, bensì a Grenoble, distante sette giorni di viaggio. Organizzarono una fiaccolata in onore del vescovo e il 24 dicembre celebrarono una grande messa di ringraziamento. Il 1° gennaio 1766 le accresciute misure di sicurezza furono ridotte, e il divieto di uscite notturne per le donne fu abolito. La normalità tornò nella vita pubblica e privata con una sveltezza incredibile. La paura era sparita come per incanto, nessuno parlava più del terrore che soli pochi mesi prima aveva dominato la città e i dintorni. Non se ne parlava neppure nelle famiglie colpite. Era come se la maledizione del vescovo avesse bandito non soltanto l’assassino, ma anche qualsiasi ricordo di lui. E alla gente andava bene così.
Читать дальше