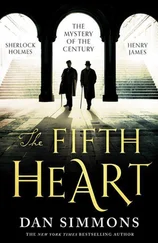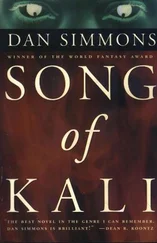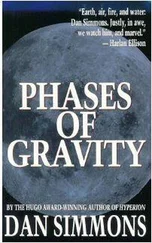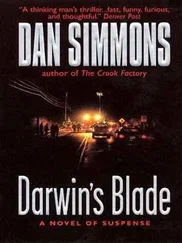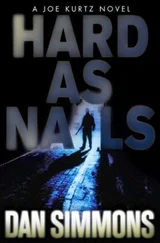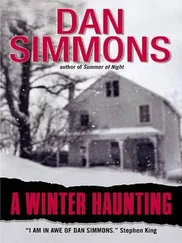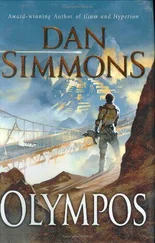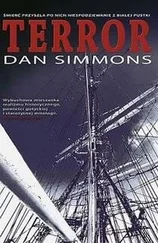Ares, alto due metri e mezzo, dio della guerra, mi afferra per i capelli e mi trascina via.
«Pensa, Lui» sibilò la voce di Calibano dalle ombre dello spedale «insegnerebbe ai due esseri razionali ciò che significa "deve"! Fa come gli piace o per quale altro motivo Signore? E Lui pure.»
«Da dove diavolo viene questa voce?» scattò Harman. Lo spedale era quasi tutto buio, la poca luce proveniva solo dalle vasche accese che si svuotavano a una a una.
Daeman frugò dalla parete semipermeabile al tavolo da cannibali, in cerca della fonte di quei bisbigli. «Non lo so» rispose alla fine. «Da un cunicolo di ventilazione. Da un ingresso che non abbiamo trovato. Ma se si fa vedere, lo uccido.»
«Gli puoi sparare» fece notare l’ologramma di Prospero, fermo accanto al bancone vicino ai comandi delle vasche «ma non è detto che tu lo uccida. Un diavolo, un demonio in carne e ossa, quel Calibano: non c’è insegnamento che riesca a cambiarne la natura. Le cure che per pura umanità gli ho dedicato non son servite a nulla, tutte invano!»
Per due giorni e due notti, quarantasette ore e mezzo, centoquarantaquattro rivoluzioni dell’asteroide dalla luce della Terra alla luce delle stelle, Harman e Daeman avevano provveduto a faxare il contenuto delle vasche di guarigione, finché era rimasta solo qualche decina di persone, le ultime arrivate. Ora sapevano come richiamare ologrammi dell’acceleratore lineare che correva in modo davvero lineare dritto su di loro. Adesso vedevano l’enorme affare, che si avvicinava col wormhole in punta, chiaro e terrificante nei pannelli trasparenti dello spedale, con i propulsori accesi e code di fiamma azzurra. Prospero e i dati virtuali garantivano che mancavano quasi novanta minuti all’impatto, ma l’istinto e la vista dicevano diversamente, perciò tutt’e due smisero di lanciare occhiate in alto.
Calibano era vicino, chissà dove. Daeman tenne la maschera osmotica per sfruttare le lenti che accrescevano la luminosità, ma usò anche la torcia di Savi e scrutò sotto il tavolo da cannibali, con un luccichio di luce bianca su ossa bianche.
Avevano pensato che il viaggio dalla sala di controllo a cupola fosse la parte peggiore (la lunga nuotata tra i fuchi nella fioca luce, aspettando da un momento all’altro l’attaccò di Calibano) ma, anche se in due occasioni qualcosa di grigio si era mosso nelle ombre e Daeman aveva usato la pistola di Savi per sparare a ciò che si muoveva, una volta la creatura ombra era schizzata via nuotando e l’altra era ruzzolata fuori, morta, con un luccichio di dardi sulla carne grigia. Era un cadavere di post-umano nei fuchi. Ora, però, dopo quarantasette ore e mezzo senza dormire, mangiando solo carne di lucertola rancida, avevano toccato il fondo. Quest’ultima ora era il fondo. Alla fine si erano fermati all’entrata della grotta artificiale, con gli stivali e il calcio della pistola avevano frantumato la crosta di ghiaccio e avevano riempito la loro unica bottiglia di globuli di acqua disgustosa, torbida di impurità, ardentemente desiderata. Alla fine l’avevano fatto. Ma ora l’acqua era finita e nessuno dei due aveva voglia di lasciare lo spedale per andare a prenderne altra. Inoltre, avevano tolto dalla parte superiore delle vasche dei fogli di plastica e li avevano inchiodati sopra la membrana semipermeabile d’ingresso, in modo che il rumore dello strappo li avrebbe avvertiti, se e quando Calibano fosse entrato nello spedale da quella parte; perciò non sarebbero potuti passare facilmente da lì, anche se avessero voluto. Ora tutt’e due avevano la lingua gonfia e un tremendo mal di testa per la sete e la fatica e l’aria viziata e la paura.
Non avevano avuto difficoltà con la decina di servitori dello spedale. Avevano lasciato che diversi continuassero il loro compito — faxare i corpi riparati — e avevano disattivato quelli che erano d’intralcio. Daeman aveva sparato a uno di essi, ma il gesto si era rivelato un errore. I dardi avevano strappato al servitore schegge e vernice, gli avevano fracassato un braccio manipolatore e staccato un occhio, ma non lo avevano distrutto. Harman aveva risolto il problema: aveva trovato un pesante pezzo di tubo nel vivaio di vasche, l’aveva staccato (facendo uscire ossigeno liquido che si era vaporizzato nell’aria già fredda) e con quello aveva colpito il servitore finché non era rimasto immobile. I restanti servitori erano andati in pensione allo stesso modo.
Prospero era giunto mentre loro davano corrente alla sfera olografica sopra il pannello di comando e si era accertato che le regolazioni per vuotare le vasche fossero giuste. Per prima cosa avevano spento i nodi fax d’arrivo. Poi avevano rispedito subito al nodo terrestre di partenza i corpi intatti inviati solo per il compimento di una Ventina. Prospero aveva detto che non c’era modo d’affrettare l’opera dei vermi blu e del liquido arancione, perciò avevano lasciato che in quelle vasche il ciclo continuasse. Gli esseri umani prossimi al completamento delle riparazioni erano stati rimandati indietro in anticipo. Adesso le seicentosessantanove vasche dello spedale erano tutte vuote tranne trentotto: trentasei di gente che necessitava di riparazioni estese e due di persone al termine della Ventina, sulle quali erano iniziate le normali riparazioni prima che Harman e Daeman riuscissero a spegnere i computer del fax.
«Inoltre a Setebo piace lavorare» sibilò la voce di Calibano, che si manteneva invisibile.
«Sta’ zitto!» gridò Daeman. Si mosse fra le vasche, cercando di non galleggiare: la gravità era bassa, ma percettibile. Ombre danzarono da tutte le parti, ma nessuna era tanto solida da meritare un colpo di pistola.
«Finisce per fare qualcosa: ammucchiata quella pila di zolle, l’ha ricoperta di lastre di tenero gesso bianco squadrate» bisbigliò Calibano dal buio. «E con un dente di pesce vi ha inciso una falce di luna e piantato per dritto certe spine d’albero e coronato il tutto con un teschio di scimmia trovata morta nei boschi, troppo difficile da uccidere. Un lavoro del tutto inutile, fatto solo per non stare in ozio: e Lui pure.»
Harman rise.
«Che c’è?» chiese Daeman e tornò ai comandi virtuali dove la sfera olografica consentiva a Prospero di stare in piedi. Dappertutto sul pavimento c’erano parti e pezzi di servitori, un’imitazione del tavolo da cannibali più avanti nell’ombra.
«Dobbiamo sbrigarci a uscire di qui» disse Harman, strofinandosi gli occhi arrossati. «Comincio a capire il mostro.»
«Prospero» disse Daeman, spostando lo sguardo da ombra a ombra nella scura foresta di vasche lucenti. «Chi o che cosa è quel Setebo di cui Calibano continua a parlare?»
«Il dio della madre di Calibano» rispose il mago.
«E hai detto che anche la madre di Calibano è la fuori chissà dove» commentò Daeman. Con una mano impugnò la pistola e con l’altra si strofinò gli occhi. Lo spedale pareva annebbiato e solo in parte per il vapore alla deriva provocato dall’ossigeno liquido uscito dal tubo.
«Sì, Sicorace è ancora viva» disse Prospero. «Ma non in quest’isola. Non più in quest’isola.»
«E Setebo?» lo incitò Daeman.
«Il nemico della Quiete» disse Prospero. «Come entrambe le parti del suo gruppo di due, un amaro cuore che il momento aspetta e morde.»
Segnalatori acustici suonarono sopra il pannello. Harman mise in funzione i comandi virtuali. Tre altre persone risanate (quasi risanate, per lo meno) furono faxate via. Ne restavano trentacinque.
«Da dove proviene questo Setebo?» chiese Harman.
«È stato importato dal buio, con i voynix e con altre creature» rispose Prospero. «Un piccolo errore di calcolo.»
«Odisseo è una delle altre creature importate dal buio?» chiese Daeman.
Читать дальше