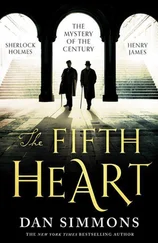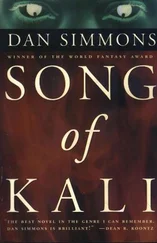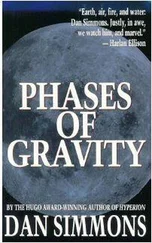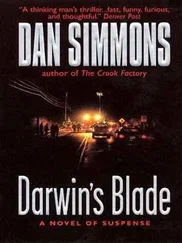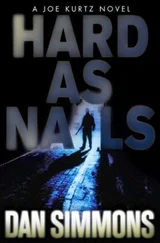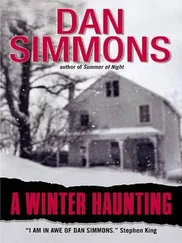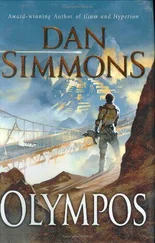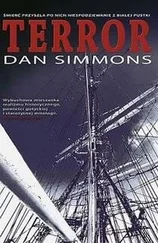«Mi chiamo Era» dice la dea «e sono venuta a porre fine una volta per tutte alle sofferenze di voi due sciocchi, sciocchi moravec. La vostra razza non mi è mai piaciuta.»
Esitavo, prima che la dea parlasse. Quella è Era, moglie e sorella di Zeus, regina degli dèi, la più potente di tutte le dee, con la possibile eccezione di Atena. Forse è stata quell’ultima frase, "la vostra razza non mi è mai piaciuta". Sono nato a metà del ventesimo secolo, ho vissuto nel ventunesimo, e ho già sentito frasi di quel tipo, fin troppe volte.
Così, quale che sia la ragione, uso lo storditore su quell’arrogante puttana.
Non ero sicuro che cinquantamila volt funzionassero su una dea, ma vedo che fanno effetto. Era si contrae per gli spasmi, comincia a cadere, aziona l’ovoide che tiene fra le mani e fa esplodere i pannelli del soffitto che danno luce alla stanza. Tutto diventa buio.
Ritraggo l’elettrodo dello storditore e preparo un’altra carica, ma la stanza, priva di finestre, è assolutamente buia e non vedo un accidente. Muovo un passo e quasi inciampo nel corpo di Era. La dea pare svenuta, ma si contrae ancora sul pavimento. All’improvviso due raggi di luce attraversano la stanza. Mi abbasso sulle spalle l’Elmo di Ade e mi vedo nei raggi gemelli.
«Toglimi dagli occhi quella luce» dico al piccolo robot. I raggi, che sembrano provenire dal petto del robot, si spostano.
«Sei umano?» chiede il robot. Impiego un secondo a capire che parla nella mia lingua.
«Sì» dico. Mi sento strano a usare la mia lingua. «Chi siete?»
«Siamo due moravec» risponde il piccolo robot; si avvicina e sposta su Era i due raggi luminosi. La dea batte già le palpebre. Mi chino, raccolgo l’arma grigia e me la metto nella tasca della giubba.
«Mi chiamo Mahnmut» riprende il robot. Con la testa non mi arriva neanche al petto. Non vedo occhi nel viso metallico che pare di plastica, ma due bande scure dove dovrebbero esserci gli occhi e ho la sensazione che il robot mi fissi. «Il mio amico è Orphu di Io» soggiunge con voce morbida, solo vagamente maschile, non metallica, tutta diversa da quella che ci si aspetterebbe da un robot. La… creatura… indica il guscio incrinato che occupa forse cinque metri di spazio in fondo alla stanza.
«Orphu… è vivo?» chiedo.
«Sì, ma al momento è privo di occhi e di manipolatori» risponde il piccolo robot. «Gli trasmetto via radio ciò che diciamo. È lieto di fare la tua conoscenza. Se avesse ancora gli occhi, dice, saresti il primo umano su cui li abbia mai posati.»
«Orphu di Io» ripeto. «Io non è il nome di una luna di Saturno?»
«Di Giove, a dire il vero» precisa la macchina Mahnmut.
«Be’, piacere di conoscervi, ma dobbiamo uscire subito di qui e chiacchierare più tardi. Quella vacca comincia a riprendersi. E poi qualcuno la cercherà, nel giro di un paio di minuti. In questo momento gli dèi sono molto sconvolti.»
«Vacca» ripete il robot. Guarda Era. «Che buffo.» Sposta i raggi di luce e illumina la porta. «Pare che la porta della stalla sia stata chiusa dietro la vacca. Hai un sistema per aprirla o farla saltare?»
«No» rispondo. «Ma non dobbiamo varcare la porta, per uscire di qui. Dammi la mano… zampa… quel che è.»
Il robot esita. «Vuoi telequantarci fuori di qui, per caso?»
«Sai del TQ?»
La piccola figura sposta i raggi sul guscio inerte che mi supera in altezza. «Puoi portare con te tutt’e due?»
Tocca a me esitare. «Non lo so. Sospetto che sia impossibile. Una massa così grande…» Era si agita e geme ai nostri piedi… be’, ai miei piedi e agli appoggi vagamente simili a piedi di Mahnmut. «Dammi la mano» ripeto. «Ti telequanto al sicuro, giù dall’Olimpo, e torno a prendere il tuo amico.»
Il piccolo robot si allontana di un altro passo. «Prima di andarmene devo sapere che Orphu potrà essere salvato.»
Sento voci nel corridoio. Mi cercano già? Probabile. Afrodite ha condiviso con gli altri la tecnologia per vedere ciò che è nascosto dall’Elmo di Ade o gli dèi si limitano a disporsi a ventaglio e a tastare lo spazio vuoto come per dare la caccia a un uomo invisibile? Era geme e si gira sul fianco. Batte ancora le palpebre, ma comincia a riprendersi.
«’Fanculo» dico. Strappo la cappa e tolgo la bardatura di levitazione inserita nella corazza. «Fammi luce, per favore.» Si dice "per favore", a un robot? Be’, Mahnmut non ha detto di essere un robot, ma un moravec. Qualsiasi cosa sia.
La prima cinghia della bardatura è troppo corta per passare intorno al grosso granchio, allora ne collego le tre sezioni e aggancio le fibbie a fenditure del guscio. Il povero Orphu pare sia stato usato in esercitazioni di terroristi e preso a bersaglio per anni. Nel guscio d’aspetto vagamente metallico ci sono crateri dentro crateri.
«Bene» dico «vediamo se funziona.» Attivo la bardatura.
Quelle che dovrebbero essere tonnellate di guscio inerte traballano, sobbalzano e poi levitano a venti centimetri dal pavimento di marmo.
«Vediamo se il medaglione può trasportare tutto questo peso» dico, senza preoccuparmi se Mahnmut capisca. Passo al piccolo robot lo storditore. «Se la vacca si muove prima del mio ritorno o se qualcuno varca la porta, prendi la mira e premi qui. Almeno uno lo fermerà.»
«A dire il vero devo portare con me due oggetti che ci hanno rubato e mi farebbe più comodo quel congegno d’invisibilità che usavi prima. Posso prenderlo in prestito?» Mi restituisce lo storditore.
«Merda» dico. Ormai le voci sono proprio fuori della porta. Mi sgancio la corazza, mi tolgo l’elmo e lo tiro al robot. Il marchingegno di Ade funzionerà per una macchina? Devo dire a Mahnmut che Afrodite può vedere chi sfrutta il congegno d’invisibilità? Non c’è tempo, ora. «Come ti trovo, al ritorno?»
«Vieni sui lato più vicino del lago della caldera in qualsiasi momento della prossima ora» dice il robot. «Ti troverò io.»
La porta si apre. Il piccolo robot scompare.
Con Nightenhelser e Patroclo mi sono limitato ad afferrarli per includerli nel campo TQ, anche se nel secondo caso cingevo col braccio l’inerte Patroclo. Ora mi appoggio al guscio di Orphu, allungo il braccio fin dove posso, visualizzo la destinazione e mi telequanto.
Vivido sole e sabbia sotto i piedi. Ho telequantato con me il pesante Orphu che ora si libra a venti centimetri dalla sabbia; ed è un bene, perché sotto di lui ci sono piccoli massi tondeggianti. Non penso che sia possibile emergere in un oggetto solido, dopo essersi telequantati, ma sono lieto che oggi non sia stato il giorno giusto per scoprirlo.
Sono nel campo di Agamennone sulla spiaggia, ma a quest’ora del tardo mattino l’area coperta di tende è quasi deserta. Malgrado le nubi tempestose, il sole illumina a chiazze la spiaggia, le tende variopinte e le lunghe navi nere; vedo sentinelle achee che saltano indietro, stupefatte, alla nostra improvvisa comparsa. Sento il fragore della battaglia a qualche centinaio di metri dal campo e capisco che greci e troiani combattono ancora al di là delle trincee difensive. Forse Achille guida un contrattacco.
«Il guscio è sacro agli dèi!» grido alle sentinelle, acquattate dietro la propria lancia. «Non toccatelo, pena la morte. Dov’è Achille? È stato qui?»
«Chi lo vuole sapere?» replica la sentinella più alta e più irsuta. Solleva la lancia. Riconosco il guerriero, Guneo, comandante degli enieni e dei perebi di Dodona. Cosa faccia oggi, lì di guardia al campo di Agamennone, non lo so e non ho tempo di scoprirlo.
Stordisco Guneo e guardo il suo vice, un basso sergente dalle gambe arcuate. «Allora, mi porti da Achille?»
L’uomo pianta nella sabbia il calcio della lancia, piega il ginocchio e china brevemente la testa. Gli altri esitano, ma poi lo imitano.
Читать дальше