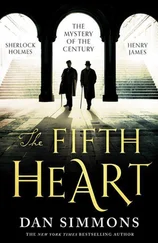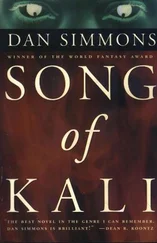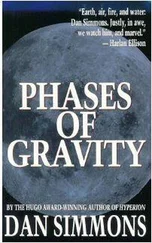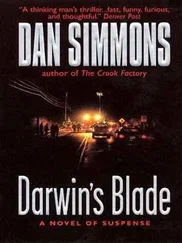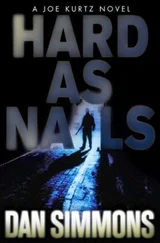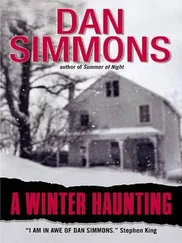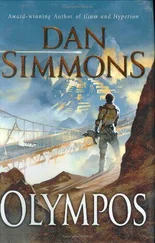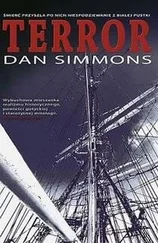Tutti gli edifici parevano collegati e quella che nell’avvicinarsi era parsa vivida illuminazione interna risultò illusione. Le finestre brillavano di calda luce, ma erano le finestre stesse a emetterla. Gli ampi interni (il primo ambiente dove si trovarono, attraversato il bianco muro, era largo un centinaio di metri e alto almeno trecento, con terrazze aperte che si alzavano su tre lati. dello spazio delimitato da colonne) erano tutti fiocamente illuminati dal bagliore arancione delle distanti finestre lungo le pareti e davano a Daeman la sensazione di muoversi sott’acqua a grande profondità. Per rinforzare l’illusione di trovarsi sott’acqua, varie piante incolte erano cresciute fino a una quindicina di metri e ondeggiavano al minimo soffio d’aria come distese di fuchi.
Daeman sentiva quanto era rarefatta l’atmosfera, mentre cercava di nuotare in ciò che restava dell’aria. E anche se la termotuta gli copriva tutta la pelle esposta e conservava il calore corporeo, Daeman sentiva comunque il gelo all’esterno dello strato molecolare. Ne vedeva anche gli effetti, perché i pannelli di vetro erano coperti di una sottile patina di ghiaccio e occasionali gruppi di cristalli di ghiaccio che galleggiavano liberamente e mandavano riflessi, come pulviscolo in raggi di luce.
Dopo soli cinque minuti passati a scalciare e nuotare negli edifici collegati dell’asteroide, incapparono nei primi cadaveri.
Un tempo il terreno in basso era coperto d’erba, di piante terrestri e di alberi, di piante e di fiori che Daeman non aveva mai visto sulla Terra, ma ormai era tutto morto, a parte le ondeggianti torri di fuchi. Mentre il terreno era simile a un parco, balconate aperte su colonne metalliche, aree per pranzare e riunirsi, erano poste a mo’ di festoni sui muri; e le finestre mostravano quanto scarsa doveva essere la gravità generata dal campo di forza. I post-umani dovevano essere stati in grado di spingersi su dal "terreno" e volare un centinaio di metri in verticale, prima d’avere bisogno di un’altra piattaforma aperta o di un gradino aereo per darsi di nuovo la spinta. Molte piattaforme avevano ancora tavolini coperti di ghiaccio, sedie rovesciate, divani tondeggianti e arazzi non fissati alle pareti.
E cadaveri.
Savi si diede la spinta e salì fino a una terrazza larga quasi una trentina di metri. Un tempo si trovava chiaramente a lato di una sottile cascata che si riversava giù da una balconata centocinquanta metri più in alto, nel muro di permacemento; ma ora l’acqua si era solidificata in un fragile traliccio di ghiaccio e fra i tavolini c’erano solo cadaveri galleggianti.
Cadaveri di donne. Tutte donne, anche se quei grigi oggetti parevano più mummie di cuoio che creature dell’uno o dell’altro sesso.
In realtà i cadaveri erano decomposti pochissimo, ma gli effetti del gelo estremo e della pressione atmosferica sempre minore li avevano rinsecchiti e ghiacciati nel corso di anni o decenni o secoli. Quando Daeman si avvicinò al primo gruppo di cadaveri (tutti in grado di galleggiare liberamente nell’assenza di gravità, ma impigliati nelle maglie di quella che un tempo era stata una sorta di rete decorativa fra l’area pranzo e la cascata) decise che erano passati secoli, non semplici decenni, da quando quelle donne avevano respirato e camminato e svolazzato in quello che secondo Savi era stato probabilmente un decimo della gravità terrestre e riso e fatto qualsiasi altra cosa i post-umani avessero fatto prima di… prima di che cosa? Gli occhi delle donne erano ancora intatti, anche se congelati e velati di bianco nel viso grigio della consistenza del cuoio, e Daeman fissò gli sguardi lattei dei cadaveri come se potesse leggervi una risposta. Poiché non ne giungeva nessuna, si schiarì la voce e chiese, nel microfono della maschera osmotica: «Secondo voi, chi le ha uccise?».
«Me lo chiedevo anch’io» disse Harman, librato presso un altro gruppo di cadaveri. L’azzurro della sua termotuta aveva un effetto quasi sconvolgente nella fioca, funerea luce, contro il grigio della pelle dei cadaveri. «Depressurizzazione improvvisa?»
«No» rispose Savi. Il suo viso era a qualche centimetro da quello di una donna morta. «Non c’è emorragia negli occhi né segni d’asfissia o di esplosione dei timpani, come accadrebbe se un cataclisma avesse causato un’improvvisa perdita di pressione atmosferica. E guardate questa.»
Gli altri due si avvicinarono. Savi infilò tre dita guantate in un foro frastagliato nel collo del cadavere. Le dita scomparvero fino alle nocche. Disgustato, Daeman si diede una spinta e arretrò, ma non prima di notare che pure gli altri cadaveri avevano simili ferite slabbrate, nel collo, nelle cosce o nella cassa toracica.
«Animali che si nutrono di cadaveri?» domandò Harman.
«No, non credo» rispose Savi. Passò da un cadavere all’altro e ispezionò ogni ferita. «Non sono nemmeno effetti della decomposizione. Non credo che qui ci fossero molti batteri vitali, prima che l’aria cominciasse a sfuggire e il gelo a penetrare. Forse i post-umani non avevano neppure batteri nell’intestino.»
«Com’è possibile?» chiese Daeman.
Savi si limitò a scuotere la testa. Si accostò a due cadaveri impigliati alle sedie sulla piattaforma vicina. Questi mostravano ferite più grandi nel ventre. Brandelli di vestiti strappati galleggiavano nell’aria rarefatta e gelida. «Si direbbe che li abbiano dilaniati a morsi» mormorò Savi.
«Cosa?» esclamò Daeman e si accorse di quanto fosse attutito il suono della sua voce nel trasmettitore della tuta.
«Credo che queste persone, questi post, siano morti per le ferite» disse Savi. «Qualcosa ha dilaniato a morsi la gola e il ventre di questi disgraziati e ha strappato loro il cuore.»
«Cosa?» ripeté Daeman.
Anziché rispondere, Savi estrasse dallo zaino la pistola e la sistemò nel riquadro adesivo sulla coscia della termotuta. Indicò in basso il viale a cielo aperto della città interna, nel punto dove questo faceva una curva, circa un chilometro più avanti. «Là c’è qualcosa che si muove» disse.
Senza aspettare di vedere se i due uomini la seguivano, si diede una spinta e galleggiò in quella direzione.
Dopo la cattura, Mahnmut pensò che avrebbe fatto meglio ad azionare il Congegno, qualsiasi cosa fosse, non appena il dio biondo nel cocchio volante aveva distrutto il pallone e cominciato a trainarli su Olympus Mons.
Ma non poteva arrivare al Congegno. Né al trasmettitore. Né a Orphu. Riusciva solo a tenersi aggrappato alla murata della navicella, mentre volavano verso il vulcano quasi a velocità mach 1. Se il Congegno, il trasmettitore e Orphu non fossero stati legati alla piattaforma della navicella, con tutte le funi e i cavi che Mahnmut era riuscito a ricuperare, sarebbero caduti da dodicimila metri sull’altopiano fra il più a nord dei vulcani del Tharsis, Ascraeus, e il mare Tethys.
Il dio nella macchina volante, che portava con una sola mano tutte quelle tonnellate di peso morto e in più i cavi raggruppati, salì di quota e si diresse verso Olympus Mons da nord. Anche con le corte gambe penzolanti e i manipolatori conficcati profondamente nella murata della navicella, Mahnmut riconobbe che era un gran bel panorama.
Una massa di nubi quasi solida copriva gran parte della regione fra i vulcani del Tharsis e Olympus Mons: solo le scure ombre dei vulcani sbucavano da quella coltre. Il sole nascente, piccolo ma molto luminoso verso sudest, indorava vividamente l’oceano e le nubi. Il riflesso sul mare Tethys era così sfavillante che Mahnmut fu costretto ad aumentare i filtri polarizzanti. Olympus Mons, che si ergeva proprio al bordo dell’oceano Tethys, era sbalorditivo nella sua immensità, un infinito cono di campi di ghiaccio che si alzavano fino alla vetta di un verde incredibile, con una serie di laghi azzurri nella caldera.
Читать дальше