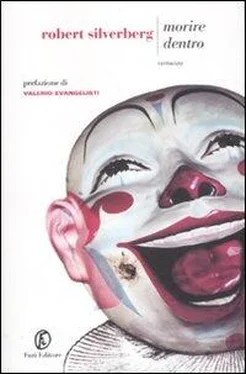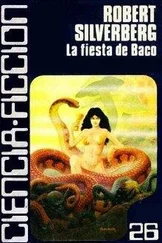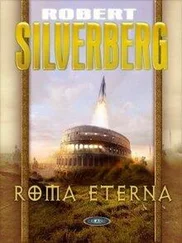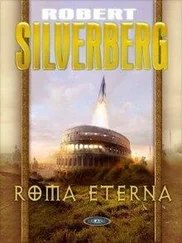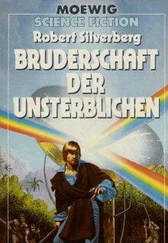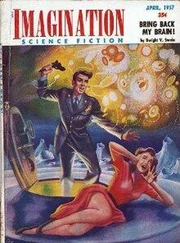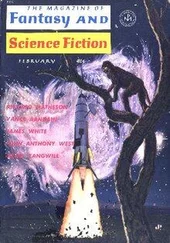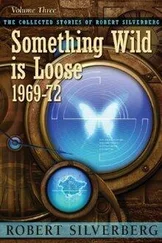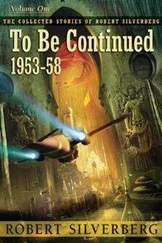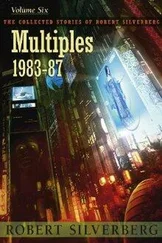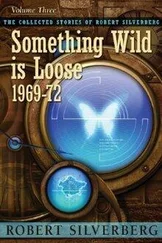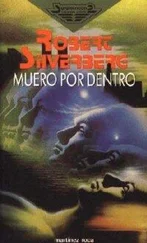Le due opere rappresentano una variazione sullo stesso tema, quello dell’uomo scardinato esistenzialmente, che all’improvviso è coinvolto in una situazione da cui non c’è scampo, e che, dopo aver tentato di ottenere la grazia che lo libererebbe dalla sua condizione, soccombe. Così come sono arrivati a noi, Il Processo è senza dubbio il maggiore successo artistico, impostato con rigore e continuamente sotto il controllo tecnico dell’autore; Il Castello , o meglio il frammento che ne possediamo, potenzialmente è tuttavia il romanzo migliore. Tutto quello che c’era nel Processo ci sarebbe stato nel Castello , e anche molto di più. Ma si ritiene che Kafka abbia smesso di lavorare al Castello essendosi accorto che gli venivano a mancare le risorse per portarlo a termine. Non riusciva a trattare il mondo del Castello , con il suo enorme sfondo di vita paesana alla Bruegel, con la stessa sicurezza con cui aveva trattato il mondo cittadino del Processo. E poi nel Castello mancava una necessità pressante; noi non siamo mai interessati veramente al destino di K, perché è inevitabile; Joseph K., invece, sta combattendo contro forze più tangibili e fino alla fine abbiamo l’illusione che la vittoria sia, per lui, possibile. Inoltre Il Castello è troppo ponderoso. Simile a una sinfonia di Mahler, crolla sotto il suo stesso peso. Ci si chiede se Kafka avesse in mente una qualche struttura che lo mettesse in grado di terminare Il Castello. Può anche darsi che egli non abbia mai inteso concludere il romanzo, ma che abbia voluto esprimere l’eterno vagabondare di K in cerchi concentrici e sempre più ampi, senza mai arrivare alla tragica coscienza che non avrebbe raggiunto affatto il Castello.
Forse è questa la ragione della struttura informe, comparativa, dell’ultima opera: la scoperta di Kafka che la vera tragedia di K, la sua figura di eroe-vittima archetipica, non risiede nella percezione finale dell’impossibilità di ottenere la grazia, quanto piuttosto nel fatto che egli non raggiungerà mai neppure questa percezione finale. Abbiamo qui il ritmo tragico, una struttura comune a tutta la letteratura, troncato per rappresentare più esplicitamente la condizione umana contemporanea, una condizione repellente, secondo Kafka. Joseph K., che effettivamente raggiunge uno stato di grazia, tramite ciò raggiunge una vera e propria statura tragica; K, che semplicemente scende sempre più in basso, potrebbe simboleggiare per Kafka l’individuo contemporaneo, così schiacciato dalla generale tragedia dei tempi da essere incapace di ogni tragedia a livello individuale. K è una figura patetica, Joseph K. una figura tragica. Joseph K. è un personaggio più interessante, ma forse è K che Kafka comprendeva più profondamente. E per la storia di K non è possibile nessun finale, probabilmente, se non quello senza senso della morte.
Non è poi così male. Sei cartelle a spazio due: a tre dollari e mezzo l’una, mi fruttano 21 dollari per meno di due ore di lavoro, e frutterà sicuramente alla muscolosa mezz’ala, Paul F. Bruno, un “buono” dal prof. Schmitz. Ne sono sicuro, perché lo stesso dattiloscritto, diverso soltanto in pochi ritocchi stilistici, fruttò a me un “buono” dall’esigentissimo prof. Dupee nel maggio 1955. Oggi, dopo un ventennio di inflazione universitaria, gli standard sono più bassi. Bruno può anche arrivare a prendere “ottimo”, per la ricerca su Kafka. È un lavoro che ha qualità di vivida intelligenza, quel misto, tipico dello studente, di introspezione sofisticata e ingenuo dogmatismo, e Dupee, nel ’55, aveva trovato lo scritto “chiaro e forte”, come risultava da una sua annotazione in margine. Benissimo. Ho il tempo per farmi un po’ di spezzatino, magari con un pasticcio di verdure come contorno. Poi affronterò Odisseo come simbolo sociale oppure Eschilo e la tragedia aristotelica. Non posso cavarmela, qui, coi miei vecchi compiti, ma non dovrebbe essere troppo difficile. Cara macchina per scrivere, vecchia imbrogliona, cerca di essermi di aiuto adesso e per sempre.
Aldous Huxley riteneva che l’evoluzione avesse trasformato il nostro cervello in un filtro per eliminare tutto il ciarpame che non aveva utilità pratica nella lotta quotidiana per il pane. Visioni, esperienze mistiche, fenomeni psi come i messaggi telepatici provenienti da altri cervelli, tutte le cose di questo tipo continuerebbero a fluire dentro di noi, se non fosse per l’azione di quella che Huxley chiamava, in un piccolo libro intitolato Cielo e Inferno , “valvola di riduzione cerebrale”. Sia ringraziato Dio per la valvola di riduzione cerebrale! Se non l’avessimo sviluppata per evoluzione, saremmo continuamente distratti da scene di incredibile bellezza, da intuizioni spirituali di schiacciante grandezza, e da un prosciugante, assolutamente sincero contatto mente-a-mente con i nostri compagni umani. Fortunatamente, il meccanismo della valvola ci protegge — protegge la maggioranza di noi — da simili situazioni, e noi siamo liberi di vivere la nostra vita quotidiana, comprando a buon mercato e vendendo a caro prezzo.
Naturalmente, pare che alcuni di noi siano nati con le valvole difettose. Intendo parlare di artisti come Bosch o El Greco, i cui occhi non vedevano il mondo come appare a voi e a me; intendo parlare dei filosofi visionari, quelli che raggiungono l’estasi e quelli che arrivano al nirvana; intendo parlare dei miserabili vermi che sono capaci di leggere nella mente degli altri. Siamo tutti mutanti, noi. Anomalie genetiche.
Con tutto questo, Huxley credeva che l’efficienza della valvola di riduzione cerebrale potesse essere indebolita con vari artifici, per esempio permettendo che i comuni mortali accedessero ai dati extrasensoriali, abitualmente raggiungibili soltanto da pochi eletti. Le droghe psichedeliche, pensava lui, producono questo effetto. La mescalina, suggeriva lui, interferisce con il sistema di enzimi che regola le funzioni cerebrali, e, così facendo, «abbassa l’efficienza del cervello in quanto strumento per mettere a fuoco la mente sui problemi della vita sulla superficie del nostro pianeta. Questo… pare permettere la presa di coscienza su determinate classi di eventi mentali, che normalmente vengono esclusi perché non posseggono valore di sopravvivenza. Simili intrusioni di materiale biologicamente inutile, ma significativo a livello estetico e talvolta a livello spirituale, possono verificarsi come risultato di debolezza o di affaticamento; possono anche essere indotte dal digiuno prolungato, oppure da un periodo di confine nell’oscurità totale e nel silenzio più assoluto.» Riferendosi alla sua esperienza, David Selig può dire molto poco sulle droghe psichedeliche. Con esse ebbe un’unica esperienza, e non felice. Fu nell’estate del 1968, quando viveva con Toni.
Anche se Huxley teneva in grande considerazione la droghe psichedeliche, non le vedeva come l’unico tramite per le esperienze mistiche. Digiuno e mortificazione fisica potrebbero portarvici anche loro. Egli scrisse di mistici, i quali «usavano regolarmente su di sé la frusta di cuoio, o anche il cillcio di ferro. Questi strumenti di mortificazione erano l’equivalente di drastiche operazioni chirurgiche senza anestetici, e i loro effetti sulla chimica del corpo del paziente erano considerevoli. Enormi quantità di istamina e di adrenalina venivano liberate mentre la frusta cadeva, e quando le conseguenti ferite cominciavano a suppurare (come praticamente facevano sempre, prima dell’era del sapone), diverse sostanze tossiche, prodotte dalla decomposizione delle proteine, entravano in circolazione. L’istamina, però, provoca shock, e lo shock colpisce la mente non meno in profondità di quanto colpisca il corpo. Oltre a ciò, abbondanti quantità di adrenalina possono provocare allucinazioni, e alcuni dei prodotti della sua decomposizione inducono sintomi paragonabili a quelli della schizofrenia. Come per le tossine provenienti dalle ferite, questi turbano il sistema di enzimi che regola il cervello, e abbassano la sua efficienza come strumento-guida in un mondo dove sopravvive chi è biologicamente più adatto. Ciò può spiegare perché il Curato d’Ars nei giorni in cui era libero di flagellarsi senza pietà, èra solito dire che Dio non gli avrebbe rifiutato niente. In altre parole: quando rimorso, auto-disprezzo e paura dell’inferno liberano adrenalina, quando lacerazioni autoinflitte liberano istamina e adrenalina, e quando le ferite infette liberano nel sangue i prodotti della decomposizione delle proteine, l’efficienza della valvola di riduzione cerebrale viene abbassata e affluiscono alla coscienza dell’asceta gli aspetti sconosciuti della Mente Liberata (ivi inclusi fenomeni psi, visioni, e, se egli è filosoficamente ed eticamente preparato per questo, esperienze mistiche).»
Читать дальше