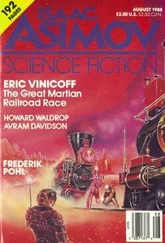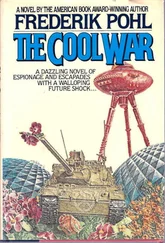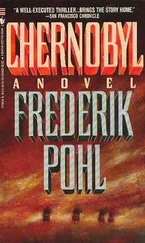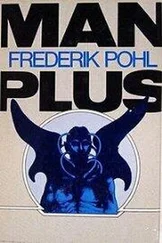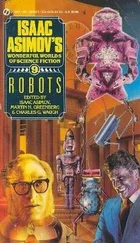— Penoso — grugnii.
Lei disse con aria assente: — Be’, almeno sono onesti.
Alzai le sopracciglia. Cosa c’entrava l’onestà con la promozione di un prodotto? E un posto del genere era una manna per un pubblicitario! Primo: avevano una clientela obbligata. Secondo: avevano un argomento attorno a cui sviluppare gli slogan. Terzo, e più importante di tutti, avevano clienti di umore vacanziero, pronti a comprare tutto ciò che fosse in vendita! Bastava che chiamassero gli hot-dog «Wurstel Odessa», e gli hamburger «Polpetta Komsomol», per dare ai consumatori una scusa per comprare. E invece facevano di tutto per dissuaderli! I consumatori non si aspettano di ottenere quello che la pubblicità promette. Vogliono solo un attimo fuggevole di speranza, prima che il materasso «Supermorbido Sognidoro» gli infili una molla nel sedere, e l’«Elisir di Frutti Tropicali, Fresco come la Natura» lasci in bocca il suo sapore di catrame. — Bene — dissi — visto che ci siamo, andiamo a dare un’occhiata alla loro maledetta sonda spaziale.
Venere faceva schifo fin dall’inizio. L’aria era velenosa, e ce n’era troppa, per cui la pressione era spaventosa. La temperatura faceva bollire tutto ciò che poteva bollire. Non cresceva nulla di cui valesse la pena di parlare quando la prima nave terrestre atterrò, e cinquant’anni di colonizzazione non avevano migliorato le cose: le avevano rese soltanto infinitesimalmente meno spaventose. I tentativi venusiani di trasformare l’atmosfera in qualcosa di respirabile non erano cessati, anzi, erano arrivati al punto che in certi posti si poteva uscire senza una tuta pressurizzata… anche se bisognava portarsi una bombola sulla schiena, perché l’ossigeno è scarsissimo.
Quella parte, che loro chiamavano «parco planetario di Venera-Colline Russe» (così diceva il cartello alla fermata del tram), non era molto peggio del resto, per quanto i conservazionisti si dessero grandi pacche sulle spalle l’uno con l’altro per avere conservato la sua «incontaminata natura selvaggia». Guardai il «parco» dalla finestra, senza provare il minimo desiderio di andarci più vicino.
— Andiamo, Tenn — disse Mitzi.
— Sei sicura di volerlo fare? — Era già abbastanza brutto nella stazione, con il fracasso delle vetture e i Venusiani con i loro ragazzini vocianti. Uscire dalla porta significava passare a un livello superiore di disgusto. Avremmo dovuto caricarci sulle spalle le bombole di ossigeno, e respirare l’aria attraverso i tubi, e sopportare un calore superiore a quello dei forni che i Venusiani chiamano «città». — Forse prima faremmo meglio a mangiare qualcosa — dissi, adocchiando il ristorante. Sotto l’intestazione: «Oggi il cuoco consiglia», qualcuno aveva scritto col gesso: Evitate le uova strapazzate.
— Andiamo, Tenn! Dici sempre che non sopporti la cucina venusiana. Vado a prendere un paio di respiratori.
Se non hai scelta, devi dire di sì: questo è il motto dei Tarb. Ha sempre funzionato, visto che siamo nel campo pubblicitario dai tempi di Madison Avenue e delle canzoncine della Pepsi-Cola. Così mi misi sulle spalle le maledette bombole, mi infilai m bocca il maledetto tubo, e bofonchiai: — Avanti verso la valle della morte!
Mitzi non rise. Quel giorno era di umore triste… forse perché me ne dovevo andare. Così le misi un braccio attorno alle spalle, e ci avviammo lungo il sentiero che conduceva a Venera.
La sonda spaziale Venera è un guscio di metallo corroso, grande circa come un taxi a pedali, con delle specie di bastoni e di piatti che spuntano qua e là. Non è in buono stato. Ci fu un tempo in cui venne issata sulla cima di un razzo, nella nevosa Tyuratam, e si lanciò fra le fiamme, attraverso centinaia di milioni di chilometri di spazio, per scendere come una meteora nell’aria rovente di Venere. Doveva essere un bello spettacolo, ma naturalmente non c’era nessuno a guardarla. Dopo tutta quella fatica, e le spese, funzionò per un paio d’ore. Abbastanza per inviare sulla Terra qualche dato sulla temperatura e la pressione, e trasmettere qualche foto distorta e sfocata delle rocce su cui si era posata. Questa fu la sua intera carriera. Poi i gas velenosi filtrarono nello scafo, e tutti i circuiti e i meccanismi e i marchingegni si fermarono. Immagino che fosse una bella impresa per quegli antichi tempi pre-tecnologici. Quelle foto grigie e nebbiose fornirono la prima immagine della superficie di Venere che occhio umano avesse mai visto, e quando i Venusiani la ritrovarono, nei primi mesi della colonizzazione, vi aspettereste che celebrassero l’avvenimento come un trionfo, no? E invece no. La ragione per cui i Venusiani fanno tante storie per un pezzo di metallo è un’altra delle loro stranezze. Vedete, in quei tempi antichi i Russi erano Sovietici. Non so bene cosa fossero i Sovietici (me li confondo sempre con gli Scientologi e i Ghibellini), ma so una cosa: non credevano (sentite questa!) nel profitto! Proprio così. Nel profitto. Non credevano nella gente che faceva soldi fabbricando e vendendo cose. E per quel che riguarda l’ancella del profitto, la pubblicità, be’, non ce l’avevano! Lo so che sembra strano, e quando ho studiato la storia, all’università, non riuscivo a crederci, così ho controllato bene. È proprio vero. A parte alcune cosine, come insegne luminose che decantavano la produzione di acciaio, o comunicati televisivi che invitavano gli operai a non ubriacarsi durante le ore di lavoro, la pubblicità proprio non esisteva. Ma con i Venusiani era più o meno lo stesso, ed è per questa ragione che di un paio di tonnellate di rottami ne hanno fatto un santuario. La grossa differenza fra i Venusiani e i Russi è che dopo un po’ quelli si sono fatti furbi, e si sono uniti alla libera confraternita degli amanti del profitto, mentre i Venusiani fanno del loro meglio per andare nella direzione opposta.
Dopo mezz’ora che giravo attorno a Venera ne avevo abbastanza. Il posto era pieno di turisti, e mi ero proprio stufato di ingurgitare aria attraverso una cannuccia da bibite. Così mentre Mitzi era china sulla sonda, con le labbra che si muovevano, mentre cercava di decifrare le scritte in cirillico, allungai una mano verso la valvola di scarico delle bombole e le diedi una giratina. Emise un sibilo acuto mentre il gas usciva, ma io mi misi a tossire, e comunque l’urlo dei tubi di Hilsch, sulle colline attorno, sopraffà tutti i rumori più piccoli. Poi le tirai una manica.
— Che mi venga un accidente, guarda qui! — gridai, e le feci vedere il manometro dell’ossigeno. La lancetta era sul giallo, e sfiorava il settore rosso. Ne avevo fatto uscire un po’ più di quanto volessi. — Quei dannati Venusiani mi hanno venduto un serbatoio mezzo vuoto! Be’ — dissi con aria molto rassegnata, — mi dispiace, ma dovrò tornare alla stazione. E poi è quasi ora di rientrare all’ambasciata.
Mitzi mi diede un’occhiata strana. Non disse niente; si voltò e si avviò lungo la salita che portava alla stazione. Di sicuro aveva controllato il manometro nel comprare le bombole, ma probabilmente non poteva essere sicura di averlo fatto. Per distrarla, sulla via del ritorno, mi levai il tubo dalla bocca e dissi: — Cosa ne dici di bere qualcosa prima di prendere il tram? — È vero che non posso sopportare il cibo venusiano: è colpa dell’anidride carbonica nell’aria, che fa crescere le cose troppo in fretta, e poi i Venusiani mangiano tutto fresco, e uno non ha mai il piacere di sentire. quell’aroma della refrigerazione istantanea. Ma un liquore è un liquore, in qualsiasi parte del sistema solare. E dopo diciotto mesi che uscivo con Mitzi, avevo capito che lei diventava sempre più allegra dopo un paio di bicchierini. Si illuminò subito, e dopo aver riconsegnato le bombole (la convinsi a non protestare per la faccenda dell’ossigeno) ci dirigemmo subito verso le scale.
Читать дальше