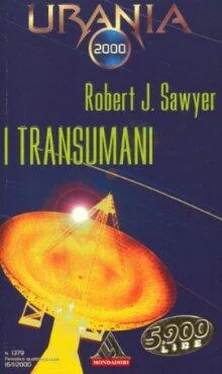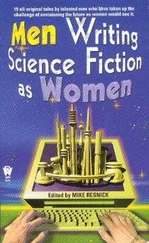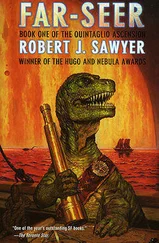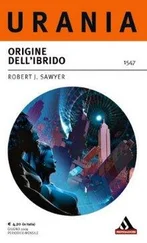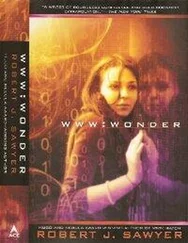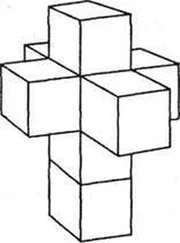Kyle s’infilò le mani in tasca, dirigendosi alla tomba di sua figlia.
Superò quattro lapidi, prima di accorgersi dell’errore. Aveva imboccato la fila sbagliata; il posto di Mary stava in quella successiva. Ci rimase male. Cristo santo, nemmeno sapeva più dov’era sepolta sua figlia!
In vita sua gli era capitato abbastanza spesso di scavalcare le tombe, ma stavolta non se la sentì di compiere un gesto del genere, proprio lì, vicino a Mary.
Tornò quindi sui suoi passi, riprese la strada, e scelse la fila giusta.
Scaglie di mica sfolgoravano nel sole dal rosso granito levigato della lapide di Mary.
Kyle indugiò con lo sguardo sull’epigrafe, domandandosi se un giorno sarebbe anch’essa divenuta illeggibile come quelle incise sulle consunte lastre di marmo degli antichi cimiteri:
MARY LORRAINE GRAVES
DILETTA FIGLIA, DILETTA SORELLA
2 NOVEMBRE 1996 – 23 MARZO 2016
ORA RIPOSA IN PACE
Era parso loro un epitaffio adeguato, incapaci com’erano di comprendere i motivi di quel gesto estremo. Il biglietto che Mary aveva lasciato, scarne parole vergate in rosso su carta a righe, diceva semplicemente: “Non ho altro modo per restare in silenzio”. E nessuno, allora, aveva capito che cosa volesse dire.
Kyle rilesse l’ultima riga: “Ora Riposa In Pace”.
Magari così fosse stato, ma com’era possibile?
Se Becky aveva detto la verità, Mary si era uccisa nella convinzione che suo padre l’avesse violata. Come poteva riposare in pace?
“Non ho altro modo per restare in silenzio”.
Si era sacrificata, dunque, ma non certo per proteggere Kyle. No, l’aveva fatto senza dubbio per sua madre, per difendere Heather dall’onore e dalla colpa.
Kyle abbassò lo sguardo sulla tomba. La ferita nel terreno si era rimarginata, naturalmente. La traccia rettangolare era scomparsa, non rimaneva alcuna cicatrice a interrompere la continuità fra il prato circostante e le zolle erbose poste a sigillo della fossa ricolma.
Tornò a scrutare la lapide.
— Mary — disse ad alta voce, vincendo l’imbarazzo. La falciatrice era lontana, ormai, il suo lamento ridotto quasi a nulla.
Tante cose avrebbe voluto ancora esprimere, ma non sapeva da dove incominciare. Si rese conto di star muovendo piano la testa avanti e indietro, e con uno sforzo si ricompose.
Rimase in silenzio per diversi minuti, poi pronunziò di nuovo il nome di sua figlia… sottovoce stavolta, quasi un sospiro che si perse fra il cinguettio degli uccelli, il fruscio d’un libratore di passaggio e il gemito della falciatrice che lentamente ritornava, disegnando un altro nitido sentiero nell’esuberanza del tappeto erboso.
Kyle volle rileggere la lapide e scoprì di non esserne capace. Un tremolar di palpebre non bastò a cacciar via tutte le lacrime.
“Potessi dirti quanto mi dispiace” pensò; ma quelle parole non ebbero mai voce.
Per continuare la ricerca, Heather doveva innanzitutto disconnettersi da Ideko.
Ma come procedere?
Perplessa, indecisa, cercò di analizzare la situazione.
Poteva ovviamente rivisualizzare la struttura centauriana, quindi aprire la porta cubica; in tal modo avrebbe senza dubbio interrotto la connessione.
Ma quanto brutale sarebbe stato quel distacco? Esisteva forse il rischio di un’amputazione psichica? Era possibile che una parte di lei rimanesse intrappolata qui all’interno di Ideko mentre il resto, forse il nucleo dell’io cosciente, veniva espulso e rispedito a Toronto?
Sentiva il cuore martellarle in petto, sentiva la fronte madida di sudore… e pensò che almeno quei legami fisici col proprio corpo rimanevano intatti.
Come fare, dunque, a separarsi? Doveva pur esserci un sistema, e forse anche a portata di mano. Una situazione del genere assomigliava un po’ al ritrovarsi d’un tratto capaci di vedere per la prima volta. Il cervello, nel fare esperienza della luce e del colore, non riusciva a dar senso a ciò che vedeva, non era in grado d’interpretare le immagini nella loro individualità.
O forse equivaleva ad aver subito un’amputazione (ecco di nuovo quella metafora, evidente riflesso dei suoi timori circa il distacco imminente), ricevendo in cambio, supponiamo, un braccio artificiale: null’altro, all’inizio, che un blocco inerte di metallo e plastica penzolante dal moncherino. La mente doveva imparare a controllarlo, ad attivarlo. Bisognava stabilire tutto un nuovo accordo: “questo” pensiero provoca “quel” movimento.
Se un cervello di carne e di sangue poteva apprendere a interpretare la luce, a muovere l’acciaio, a contrarre tendini di nailon su pulegge di teflon, doveva essere senza dubbio anche in grado di sbrigarsela con le regole di questa nuova dimensione. La mente umana non serve a nulla se incapace di adattarsi. La sua carta vincente è l’elasticità.
Heather cercò dunque di calmarsi, di ragionare in modo lucido e sistematico.
Provò a visualizzare, per quanto possibile, ciò che intendeva fare. Il suo cervello era connesso a quello di Ideko: immaginò allora di recidere il collegamento.
Nulla. Rimaneva sempre lì, dentro di lui, partecipe della visione frantumata che in un vortichio di luci e ombre penetrava dai finestrini del vagone a trafiggere la retina di Ideko, alternandosi all’instancabile arrembaggio di lascive fantasticherie immancabilmente rintuzzate.
Volle tentare un’immagine diversa: una soluzione in un bicchiere da laboratorio, la mente di Ideko con lei disciolta dentro, una lieve differenza di rifrazione luminosa a demarcare nitide pennellate di lei sulla remissiva trasparenza di lui. Immaginò di separarsi dalla miscela sotto forma di precipitato: una pioggia d’immacolati cristalli esagonali, a riecheggiare la muraglia delle menti, che scendevano a depositarsi sul fondo del bicchiere…
Funzionava!
La metropolitana di Tokyo scomparve.
Il borbottio dei pensieri di Ideko si spense.
Il chiacchierio di voci giapponesi svanì.
Però…
No!
Nulla venne a sostituirli; solo tenebra assoluta. Aveva lasciato Ideko, ma non era rientrata in se stessa.
Forse doveva uscire dal manufatto. A meno che non s’illudesse, di controllo sul proprio corpo un po’ ne aveva, ancora. Ordinò alla sua mano di sollevarsi verso dove riteneva situato il pulsante di arresto.
Ma la sua mano si muoveva davvero? Cominciò a sentirsi nuovamente invadere dal panico. Forse quella mano se l’immaginava soltanto, alla maniera in cui chi ha subito amputazioni immagina arti fantasma o chi soffre di dolori cronici impara a immaginare di avere in testa un interruttore che, azionato con uno sforzo di volontà, almeno per qualche istante interrompe il patimento.
Continuare l’operazione, uscire dallo psicospazio, le avrebbe confermato se conservava o no il controllo sul proprio corpo materiale.
Ma innanzitutto, maledizione, doveva combattere il panico e sconfiggerlo. Intanto da Ideko si era distaccata, metà cammino l’aveva già percorso.
Soluto che precipitando si separa dal solvente.
Cristalli depositati sul fondo del bicchiere…
…in un mucchietto informe, senza alcun ordine, senza simmetria. • Aveva bisogno di risistemare il suo io recuperato.
I cristalli danzarono, andando a formare una matrice di diamanti bianchi.
Purtroppo non serviva, non funzionava, non…
Ma all’improvviso, meravigliosamente, eccola riunita a se stessa, di nuovo padrona delle proprie percezioni.
La Heather materiale tirò un sospirone di sollievo.
Era tornata nello psicospazio, dinanzi all’immensa parete costellata di esagoni.
Il suo indice si era ritratto di circa un centimetro dal tasto di Ideko.
Naturalmente tutto ciò andava inteso come frutto di una formulazione concettuale, di una semplificazione interpretativa. Il tasto di Ideko non esisteva in quanto oggetto fisico, e senza dubbio lo psicospazio, qualunque cosa fosse, era diverso da come si mostrava a lei. Adesso, comunque, conosceva la ginnastica mentale necessaria a liberarla da una mente altrui. Sapeva come uscire e come reintegrarsi.
Читать дальше