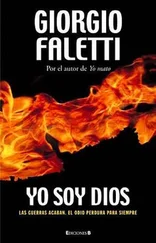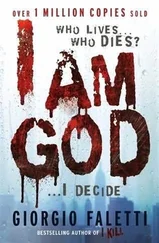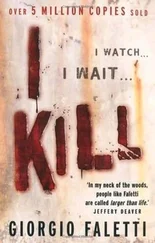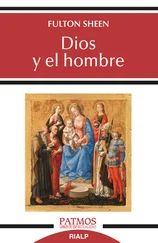Terrance aveva chiarito la sua posizione.
«Sto andando a nord, al Mid-Ohio Speedway, verso Cleveland.
Chillicothe non è proprio di strada, ma posso fare una piccola deviazione.
Se ti va bene viaggiare senza fretta e senza aria condizionata, posso darti un passaggio.»
Aveva risposto all’offerta con una domanda.
«Lei è un pilota, signor Terrance?»
L’uomo si era messo a ridere. Ai lati degli occhi, sul viso abbronzato, gli si era formata una ragnatela di rughe.
«Oh no. Sono solo una specie di tuttofare. Meccanico, autista, uomo di griglia. Di partenza e di barbecue, se serve.»
Aveva fatto un gesto con le mani, un gesto che riassumeva i fatti della vita.
«Jason Bridges, il mio pilota, sta viaggiando comodo su un aereo, in questo momento. A noi maestranze spetta la fatica, ai piloti la gloria. Ma se devo essere onesto, di gloria non ne arriva molta. Come pilota è una mezzasega. Tuttavia continua a correre. Cose che succedono, quando hai un padre con il portafoglio gonfio. Le auto si comprano, le palle no.»
L’inserviente aveva finito il rifornimento e si era girato a cercare con lo sguardo l’autista del pick-up. Quando lo aveva individuato gli aveva fatto un gesto eloquente, indicando la fila di auto in attesa. Terrance aveva battuto le mani cancellando così tutte le parole precedenti.
«Bene, si va? Nel caso la tua risposta sia affermativa, da questo momento puoi anche chiamarmi Lukas.»
Aveva raccolto la sacca da terra e lo aveva seguito.
La cabina di guida era un caos di carte stradali, riviste di parole crociate e numeri di «Mad» e «Playboy». Terrance gli aveva fatto posto sul sedile del passeggero spostando una confezione di biscotti Oreo e una lattina vuota di Wink.
«Devi scusarmi. Non abbiamo mai molti passeggeri su questa carretta.»
Avevano lasciato alle spalle con calma la stazione di servizio e poi Florence e infine il Kentucky. Presto, quei momenti e quei posti sarebbero stati solo ricordi. E nemmeno dei peggiori. Quelli belli, quelli veri, quelli che avrebbe accarezzato tutta la vita come gatti sulle ginocchia, stava andando a crearseli.
Era stato un viaggio piacevole.
Aveva ascoltato gli aneddoti del suo autista sul mondo delle corse e in particolare sul pilota che seguiva. Terrance era un brav’uomo, scapolo, in pratica senza fissa dimora, che viveva da sempre nell’ambiente delle gare senza mai avere trovato uno spazio in quelle veramente importanti, come la NASCAR o la Indy. Citava nomi di piloti famosi, gente del calibro di Richard Petty o Parnelli Jones o A J. Foyt come se li avesse conosciuti di persona. E forse li aveva conosciuti davvero. In ogni caso sembrava gli facesse piacere pensarlo e a tutti e due andava bene così.
Nemmeno una volta avevano accennato alla guerra.
Passato il confine, il pick-up con il suo guscio da corsa al seguito aveva imboccato senza fretta e senza aria condizionata la Route 50, che portava dritto a Chillicothe. Seduto al suo posto, con il finestrino aperto, mentre seguiva i racconti di Terrance, a poco a poco aveva visto il tramonto prepararsi a diventare notte, con quella tenace luminosità persistente tipica delle sere d’estate. I posti d’un tratto erano diventati familiari e infine era apparso un cartello con la scritta «Benvenuti nella Ross County».
Era a casa.
O meglio, era dove voleva arrivare.
Un paio di miglia dopo Slate Mills aveva chiesto al suo stupito compagno di fermarsi. Lo aveva lasciato alla sua perplessità e al resto del suo viaggio e adesso camminava come un fantasma in aperta campagna.
Solo le luci di un gruppo di case che sulla cartina stavano sotto il nome di North Folk Village apparivano in lontananza a indicargli la strada. E ogni passo sembrava molto più faticoso di tutti quelli che aveva stampato nel fango del Nam.
Finalmente arrivò a quella che era stata la sua meta fin da quando era partito dalla Louisiana. A poco meno di un miglio dal Village, imboccò un viottolo sterrato sulla sinistra e dopo qualche centinaio di iarde raggiunse un capannone in muratura, cintato da una rete metallica. Sul retro c’era uno spiazzo illuminato da tre lampioni, dove, fra cataste di tubi per ponteggi, erano parcheggiati un’autogru a otto ruote, un furgone Volkswagen, un Mountaineer Dump Truck con la pala dello spartineve.
Quella era stata la sua casa per tutto il tempo in cui aveva vissuto a Chillicothe. E sarebbe stato il suo appoggio per l’ultima notte che ci avrebbe trascorso.
Dall’interno della costruzione non usciva luce a rivelare presenze.
Prima di proseguire, si accertò che non ci fosse nessuno nelle vicinanze.
Infine si avviò, costeggiando la recinzione sulla destra fino al lato più in ombra. Arrivò a una macchia di cespugli che lo proteggeva dalla vista.
Appoggiò la sacca a terra e tirò fuori un paio di pinze che aveva comprato in un emporio durante il viaggio. Tagliò la rete quel tanto che gli bastava per permettergli di entrare. Immaginò la figura robusta di Ben Shepard in piedi davanti all’apertura e sentì con le orecchie del ricordo la sua voce sibilante che se la prendeva con «quei maledetti figli di puttana che non hanno rispetto per la proprietà altrui».
Appena dentro, si avviò verso una piccola porta in ferro, accanto al portone scorrevole dipinto di blu che era l’ingresso carraio del capannone.
Sopra era appesa una grande insegna bianca con una scritta azzurra.
Diceva a chiunque fosse interessato che quel posto era la sede della «Ben Shepard – Demolizioni Ristrutturazioni Costruzioni». Non aveva più la chiave ma sapeva dove il suo vecchio datore di lavoro ne lasciava una di riserva, sempre che avesse conservato quell’abitudine.
Aprì lo sportello dell’estintore. Subito dietro al fusto rosso c’era la chiave che cercava. La prese con un sorriso sulle labbra martoriate e andò ad aprire la porta. Il battente scivolò verso l’interno senza cigolii.
Un passo e fu dentro.
La poca luce che riusciva a entrare dall’esterno, attraverso i vetri posti in alto sui quattro lati, rivelava un capannone pieno di attrezzi e macchinari.
Caschi da lavoro, tute appese, due betoniere di diversa capienza. Alla sua sinistra un lungo bancone pieno di strumenti per la lavorazione del legno e del ferro.
Il caldo umido, la penombra, l’odore, erano oggetti familiari. Ferro, cemento, legno, calce, cartongesso, lubrificante. Il vago afrore di corpi sudati dalle tute appese ai ganci. Invece il gusto che sentiva in bocca era del tutto nuovo. Era il gusto acido della lacerazione, il rigurgito di tutto quello che gli era stato strappato. La vita di tutti i giorni, l’affetto, l’amore.
Quel poco che aveva conosciuto quando Karen gli aveva insegnato che cosa meritasse quel nome.
Avanzò nella semioscurità, badando a dove metteva i piedi, verso una porta sul lato destro. Sforzandosi di non pensare che quel posto ruvido e spigoloso per lui aveva significato tutto quello che altri ragazzi trovavano in una bella casa dalle pareti tinteggiate di fresco e in una macchina parcheggiata nel garage.
Oltre quella soglia, attaccata al muro del capannone come un mollusco a uno scoglio, c’era un’unica grande stanza con una sola finestra protetta da un’inferriata. Un angolo cottura e un bagno ai lati opposti completavano la pianta della sua dimora abituale. Quando di quel posto era diventato custode, operaio e unico inquilino.
Arrivò alla porta e la spinse.
E rimase a bocca aperta per lo stupore.
Qui le forme erano più nette. La luce dei lampioni del parcheggio che entrava dalla finestra mandava quasi tutte le ombre a rintanarsi negli angoli.
La stanza era in perfetto ordine, come se fosse uscito ore e non anni prima. Non c’era per aria l’idea pruriginosa della polvere e saltavano agli occhi i segni di una pulizia frequente e accurata. Solo il letto era coperto da un telo di plastica trasparente.
Читать дальше