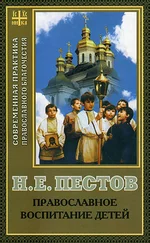Ho pensato che quella cartaccia era una sciocchezza, una formalità, qualcosa di poco importante. Sono tornato a casa, ho preso i documenti e, senza neanche cambiarmi, sono partito in ciabatte verso il luogo indicato, un posto che si trovava dall’altra parte della città, dove c’era una vecchia base militare russa.
All’ingresso ho mostrato il biglietto alle guardie e loro mi hanno aperto la porta, senza dire niente.
— Dove devo andare? — ho chiesto a uno di loro.
— Vai dritto, tanto fa lo stesso… — mi ha risposto un soldato, senza entusiasmo e con evidente fastidio.
«E un imbecille», ho pensato, e mi sono diretto verso un grande ufficio dove c’era scritto: «Sezione leva e nuovi arrivati».
L’ufficio era buio, non si vedeva quasi niente. In fondo c’era una piccola finestrina nel muro, uno sportello da dove usciva una debole luce, molto gialla e triste. Si sentiva il ticchettio di una macchina da scrivere.
Mi sono avvicinato e ho visto una giovane donna, vestita con l’uniforme militare, che seduta davanti a un tavolino con una mano batteva a macchina e con l’altra teneva stretto un bicchiere di tè. Faceva piccoli sorsi e soffiava spesso dentro il bicchiere per raffreddarlo.
Mi sono appoggiato sul bancone e ho sporto la testa: ho visto che sulle ginocchia, sotto il tavolo, la donna teneva un giornale aperto. C’era un articolo sulle star musicali russe, con la foto di un cantante che aveva in testa una corona decorata con piume di pavone. Mi sono sentito ancora più triste.
— Salve, chiedo perdono, signora, ho ricevuto questo, — ho detto allungando il biglietto.
La donna si è girata verso di me e per un secondo mi ha guardato come se non riuscisse a capire dove si trovava e cosa stava succedendo. Era evidente che avevo interrotto un’onda di pensieri e di sogni personali. Con un movimento veloce ha preso il giornale che teneva sulle gambe e lo ha messo capovolto dietro la macchina da scrivere, in modo che io non potessi vederlo. Poi ha posato il bicchiere di tè, e senza alzarsi né dire qualcosa, con la faccia indifferente ha preso dalle mie mani il foglio bianco con la riga rossa. L’ha guardato un attimo e poi ha chiesto con una voce che mi sembrava appartenere a un fantasma:
— Documenti?
— Quali documenti, i miei? — ho chiesto io goffamente, prendendo dalla tasca dei pantaloni il passaporto e il resto.
Lei mi ha guardato con un po’ di disprezzo, dicendo a denti stretti:
— Beh, certo non i miei.
Ha ritirato i miei documenti e li ha messi in una cassaforte. Poi ha preso da uno scaffale un modulo e ha cominciato a compilarlo. Mi ha chiesto nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza. Poi è passata a informazioni più personali. Dopo aver chiesto le generalità dei miei genitori, mi ha detto:
— Sei mai stato arrestato, hai avuto problemi con la legge?
— Beh, problemi con la legge non li ho mai avuti, è la legge che sembra ogni tanto avercela con me… Sono stato arrestato molte volte, non mi ricordo quante. E ho scontato due condanne in carcere minorile.
Dopo le mie parole lei era cambiata. Ha strappato il foglio che stava compilando e ne ha preso un altro, più grande, con una riga rossa che andava da un angolo all’altro, come quella del biglietto postale.
Siamo ripartiti da capo, di nuovo tutte le informazioni personali, questa volta anche sulle condanne: i numeri degli articoli, le date. Poi la salute: malattie, vaccinazioni, mi ha persino chiesto se consumavo alcol о droghe, se fumavo sigarette. Cosi per un’ora… Io non ricordavo con precisione le date delle condanne, quindi le inventavo sul momento, cercando almeno di azzeccare il periodo, il mese.
Quando abbiamo finito ho cercato di spiegarle che doveva esserci stato uno sbaglio, che io non potevo fare il servizio militare, avevo chiesto e ottenuto un rinvio di sei mesi, promettendo che nel frattempo avrei finito un ciclo di studi e poi sarei andato all’università. Se tutto fosse andato come previsto, ho aggiunto, avrei aperto una scuola di educazione fisica per ragazzi lì a Bender.
Lei mi ascoltava. Senza guardarmi in faccia, il che mi preoccupava. Poi mi ha dato un foglio: c’era scritto che da quel momento io ero proprietà del governo russo e la mia vita era protetta dalla legge.
Non riuscivo a capire cosa significava concretamente tutto questo.
— Significa che se cerchi di scappare, farti del male о sui-ridarti, sarai processato per danni alla proprietà del governo, — mi ha detto lei con tono freddo.
Improvvisamente mi sono sentito intrappolato, tutto intorno a me ha cominciato a sembrarmi molto più pesante e macabro di prima.
— Senti, — sono sbottato, — non me ne frega niente della vostra legge, sono un criminale e basta. Se devo andare in galera ci vado, ma non prenderò mai in mano le armi dal tuo cazzo di governo…
Ero furibondo, e quando ho cominciato a parlare cosi mi sono subito sentito forte, persino più forte di quell’assurda situazione. Ero sicuro, assolutamente sicuro, di riuscire a cambiare il meccanismo che doveva regolare la mia vita.
— Dove cazzo avete qui un generale, о come si chiamano le vostre autorità? Voglio vederne uno, parlare con lui, dato che con te non ci capiamo! — ho alzato la voce, e lei mi ha guardato con la stessa faccia indifferente di prima.
— Se vuoi parlare con il Colonnello, lui c’è, però non credo che risolverai qualcosa… Anzi, cerca di non peggiorare la tua situazione, ti consiglio di stare tranquillo…
Era un buon consiglio, se ci penso adesso. Stava dicendomi una cosa importante, ne sono sicuro, mi stava indicando una via migliore, ma in quel momento ero accecato.
Mi sentivo male. Ma come, mi dicevo, solo stamattina ero libero, avevo i miei piani per la giornata, per il mio futuro, per il resto della vita, e adesso, per colpa di un foglio di carta, stavo perdendo la mia libertà. Volevo urlare e litigare con qualcuno, far sentire quant’ero arrabbiato. Ne avevo bisogno. L’ho interrotta, urlandole in faccia:
— Ma Gesù, Signore Benedetto sulla croce! Se voglio parlare con qualcuno, gli parlo e basta! Dove cazzo si trova quel vostro comandante, generale, che cazzo è?
Lei si è alzata dalla sedia e mi ha chiesto di calmarmi e aspettare una decina di minuti seduto sulla panchina. Ho guardato intorno e non ho visto nessuna panchina. «Porca puttana, dove sono finito, qui sono tutti matti», pensavo aspettando nel buio.
Improvvisamente si è aperta una porta e un militare, un uomo di mezz’età, mi ha chiamato per nome.
— Nicolai, vieni, il Colonnello ti aspetta!
Sono saltato come una molla e mi sono messo a correre verso di lui, per andarmene il più in fretta possibile da quel buco schifoso.
Siamo usciti su una piccola piazzetta circondata da edifici dipinti di bianco, con disegni di propaganda e cartelloni dov’erano disegnati gli esercizi che i soldati dovevano fare per imparare a camminare in gruppo. Abbiamo attraversato la piazzetta e siamo entrati in un locale pieno di luce, con le finestre grandi e tanti fiori nei vasi. In mezzo ai fiori c’era una panchina, e vicino alla panchina un grande portacenere.
— Aspetta qui, il Colonnello ti chiamerà da questa porta. Puoi fumare, se vuoi…
Il militare era gentile, mi parlava con un tono molto amichevole. Mi ero calmato e mi sentivo pili sicuro, mi sembrava che adesso finalmente la mia situazione sarebbe stata chiarita e la mia voce ascoltata.
— Grazie, caro signore, ma io non fumo. Grazie mille per la vostra gentilezza, — cercavo di essere anch’io il pili gentile possibile, per fare buona impressione.
Il militare mi ha salutato e mi ha lasciato da solo. Sono restato li sulla panchina, ad ascoltare i rumori dei soldati che erano usciti sulla piazzetta per le esercitazioni. Ho guardato da una finestra.
Читать дальше