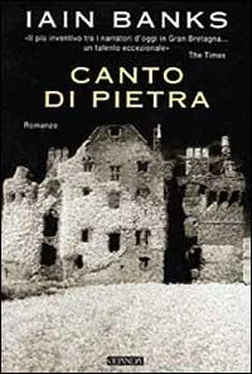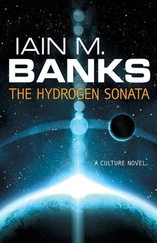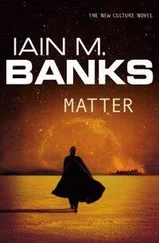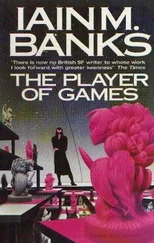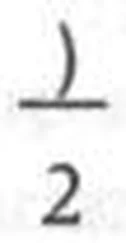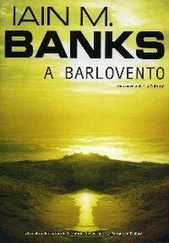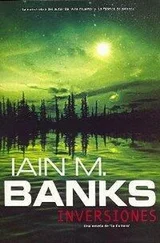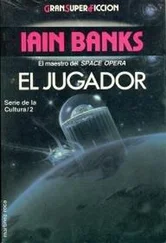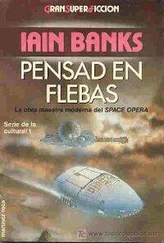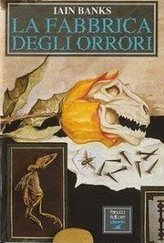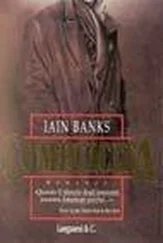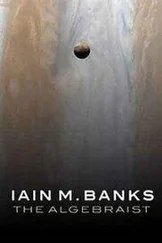Ma avverto un cigolio, uno schiocco sopra di me, e poi un disorientante senso di movimento, e un rumore sordo che mi circonda. Mi guardo intorno con gli occhi sbarrati, chiedendomi cosa stia succedendo, e non posso credere ai miei occhi, e solo allora mi rendo conto che è il mulino che si è messo a ruotare. La forza del vento deve essere appena diventata sufficiente per spingere l’alto cerchio delle pale a rivolgersi alla corrente. Stridendo, risuonando, con molti gemiti luttuosi e dolenti cigolii, il mulino si muove e — come se le pale e gli ingranaggi e le pietre fossero magneti — alla fine si stabilizza di fronte all’aspro nord. Osservo il cambiamento del paesaggio attraverso la porta: scivola lentamente dalla strada e dalla foresta verso il suo lato lontano, toglie alla vista i morti e rallenta borbottando fino a fermarsi, per mostrare il paesaggio verso ovest, lungo la strada che, a quanto pare, il destino mi impedisce di percorrere fino alla fine, per costringermi a tornare indietro, verso il castello.
Il mio sguardo torna a posarsi sulla luogotenente. Il vento irrompe dalla porta aperta e le scompiglia i riccioli castani. Depongo la pistola. Non posso farlo. Raggiungo l’entrata, di nuovo assalito dalla debolezza e dalle vertigini, guardo il giorno che nasce e respiro profondamente. Le pale del mulino, la cui tela è lacera e slabbrata, sono sollevate in una vana supplica al vento, impotenti.
Eppure, una parte di me continua a dire: «Sforzati, afferma il tuo io…» Ma lo fa troppo bene, questa frase è pronunciata con troppa chiarezza. Non so, non posso impersonare una rabbia così vitale. È una cosa che conosco empiricamente, ma niente di più e questa conoscenza mi inchioda.
La osservo di nuovo. Cosa farebbe lei? Eppure: perché dovrebbe importarmi quello che farebbe lei? È seduta lì, più vicina alla morte di quanto possa sapere, è in mio potere. Sono io che comando, io che ho vinto, anche se per pura fortuna. Cosa farò? Cosa dovrei fare? Essere quello che sono, agire normalmente? Ma cosa vorrà mai dire normale, e che valore, che utilità può avere la normalità in tempi così anomali? Vale meno di niente, direi. Perciò: rompi le regole, agisci in maniera diversa, sii irregolare.
La luogotenente si merita la mia ira per quello che ha sottratto a noi, compresa la possibilità di fuggire, pochi giorni fa, quando ci ha fermato su questa stessa strada. Quella prima intromissione ha condotto a tutto il resto: alla occupazione della nostra casa, alla distruzione del lascito della nostra famiglia, alla luogotenente che ha preso il mio posto accanto a te e — come doveva essere nelle sue intenzioni — al progetto del mio assassinio. Quel suo primo sparo, che mi ha abbattuto: quello è stato nell’agitazione del momento. Ma quando mi hanno messo nella jeep, mi hanno portato via dal castello, nell’ora tradizionale delle esecuzioni, l’hanno fatto a sangue freddo, mia cara.
La tolleranza che ho ostentato e provato nei confronti della nostra luogotenente era un residuo di epoche più civili, quando grazie agli agi della pace potevamo concederci l’un l’altro una simile cavalleria. Pensavo di dimostrare, con un’esibizione di civiltà, tutto il mio disprezzo per questi giorni disperati e per la volgare arroganza della luogotenente, ma oltre un certo grado una simile gentilezza diventa controproducente. Devo lasciarmi infettare dalla natura violenta di questi tempi, devo aspirare il loro respiro contaminante, accettare il loro fatale contagio. Guardo la pistola che ho in mano. Eppure, questa è la maniera della luogotenente. Ucciderla con l’arma che lei avrebbe potuto usare per uccidere me sarà anche poetico — giustizia o ingiustizia poetica — ma è una rima troppo facile per i miei gusti.
Il vento mi accarezza le guance e mi tira per i capelli. Il mulino si tende, sembra sul punto di muoversi ancora, poi si blocca. Poso la pistola sul pavimento, la riprendo in mano, controllo che abbia la sicura e me la infilo nella cintura dei pantaloni, dietro la schiena. Mi guardo intorno, alla ricerca di una leva, di qualcosa che governi il meccanismo.
Corro in cima alle scale scheggiate, e ho un breve attacco di vertigini per lo sforzo, poi entro nell’oscurità degli ingranaggi di legno, dei longheroni, dei recipienti, delle tramogge; alla fine trovo una leva di legno simile a quelle delle vecchie cabine ferroviarie, unita per mezzo di barre di ferro arrugginito a un diaframma di legno nel muro, attraversato da un assale orizzontale che scompare all’esterno. Tiro la maniglia. Un rumore come un sospiro, e un gemito. Una sensazione di potenza liberata pervade il mulino, e l’asta orizzontale comincia a ruotare lentamente, facendo muovere i cigolanti ingranaggi di legno che convertono il movimento orizzontale in verticale e lo trasmettono alle macine del piano di sotto. Mi precipito di nuovo da basso, quasi cadendo per la fretta in fondo ai gradini.
Le due grandi macine girano lentamente lungo il loro percorso, scuotendo l’intero mulino con il loro rimbombo basso e determinato. Rallentano mentre le osservo, in corrispondenza del calo del vento, e poi riprendono velocità. Ecco una fine diversa, ecco una poesia più appropriata. Sono scosso da una strana eccitazione e la fronte mi si imperla di sudore. Devo assolutamente farlo, finché la risolutezza mi infiamma.
Le mie mani scivolano sotto le ascelle della luogotenente e la tiro su. Lei emette un debole lamento. La poso accanto al grande cerchio di pietra del binario delle macine, facendola inginocchiare come una fedele nel tempio. Sorreggo il peso del suo tronco, impedendole di cadere in avanti. Ha un fianco intriso di sangue. Una ruota passa lentamente davanti a lei. Mi tremano le mani mentre la tengo e faccio passare la ruota; poi lascio che la luogotenente si protenda in avanti, con le spalle posate sul bordo del binario e la testa sulla strada della ruota, pronta al sacrificio. Mi sporgo all’indietro, e il cuore martella impazzito; la ruota di pietra che segue romba poderosa e letargica verso il cranio della luogotenente, gettando un’ombra sulla sua testa. Chiudo gli occhi.
Un suono terribile e stridente mi scuote, quindi si placa. Apro gli occhi. La testa della luogotenente è incastrata fra la macina e il binario, ma è intatta. Credo di sentirla emettere una specie di piagnucolio. Corro alla porta. Una debole brezza ansima davanti alle pale bucate, immobili, bloccate. Torno alla macina e cerco di fare arretrare le ruote per liberare la testa della luogotenente, ma si rifiutano di muoversi. Tremo di rabbia, urlo e cerco di spingerle nella direzione opposta, per frantumarle il cranio con le mie sole forze, ma anche così so che non spingerò con tutta la mia potenza, e il risultato è lo stesso, e lei resta incastrata ma incolume, con la testa che blocca le pietre.
Cosa sto cercando di fare? Potrei comunque toglierla di qui, farla rinvenire e chiederle scusa? O vivrò col ricordo delle pietre che si muovono e del suo cervello che schizza sulle mole? Scoppio a ridere, lo ammetto: non c’è nient’altro da fare. Non posso ucciderla e non posso liberarla. Dalla radio accanto al cadavere vicino alla porta esce un improvviso suono gracchiante. Mi allontano dalla luogotenente, lasciandola inginocchiata lì, premuta e bloccata, una supplice per metà prostrata davanti a un tondo altare di pietra. Sulla porta di quel fortino improvvisato mi volto verso il vento, poi salto fuori, correndo via, volgendo il viso verso il vento e verso di te, mio castello.
Mi sferza una pioggia gelida, mia cara, ma io rivolgo la faccia anche a te, in quella vecchia torre rovinata, e finalmente le gocce nascoste nella brezza mi donano le lacrime per tutti noi. Mi fermo alla jeep, come se il mio ultimo mezzo di trasporto potesse in qualche modo benedire il mio viaggio, ma non ha nulla da offrirmi. Mi avvio da solo per la strada nell’aria fredda e cammino nella brezza intrisa di pioggia lungo i campi desolati.
Читать дальше