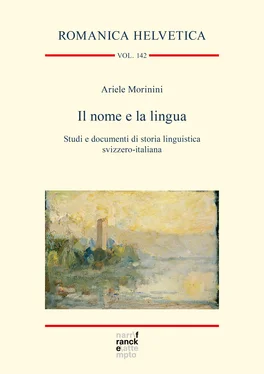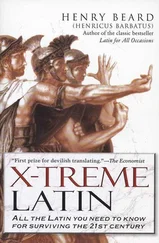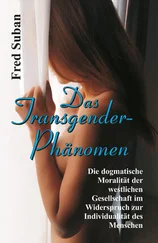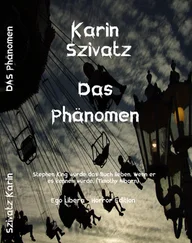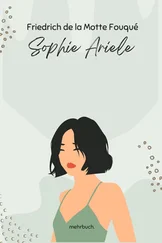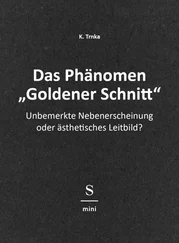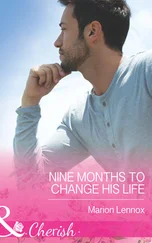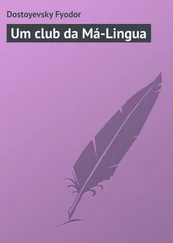Sequendo et volendo sequire nelle preditte cose la forma della rassone et de statuti de Mendrisio et Plebe di Balerna et ogni altro megliore modo et via quale meglio possemo et debbiamo atteso la auctorità podestà et bailia ad noi in questa parte atribuita et concessa per li magnifici illustrissimi et potentissimi signori Helvetii delli XII cantoni.9
Usi analoghi per esprimere lo statuto di sovranità svizzera sono documentati prevalentemente nei testi redatti da chierici o persone istruite, e possono variare secondo la cultura e la classe sociale dello scrivente. Per aggiungere un esempio, nell’intestazione degli atti relativi alla visita pastorale del 1591 del vescovo Feliciano Ninguarda nelle pievi comasche si legge una formula affine:
Visitationis personalis sitionum
illustrisimis dominis Helvetijs subiectarum
Diocesis nostrae comensis
factae anno domini 1591
per r.mum D. Felicianum episcopum comensem
pars secunda10
Anche per quanto concerne la consuetudine etnonimica il riferimento alla sovranità svizzera è talvolta aggiunto alle espressioni abituali. Come esempio a tale proposito, si veda la breve notifica di un medico di nome Benedetto della PortaBenedetto della Porta, stilata, in un italiano molto incerto, il 29 settembre 1659:
Notifico io Benedeto della Porta profesore delarte cirugicha alloficio del Ill. treS. rg lanfocho di aver medicato Angero Realle di ColaAngelo Reale di Cola [Colla, nell’omonima valle] paiese deli Ill. triS. rg Souiceri di una ferita fata di ponta nel peto nella parte sinistra la quale al mio giudicio non è mortalle ocorendo qualce cosa mentre che io lo seguitaro a medicarlo.11
Nel caso di artigiani o scriventi di media cultura, invece, il riferimento agli svizzeri quando presente è semplice e segue quello patriziale o diocesano. In coda alle usuali formule etnonimiche si sommano sintagmi come «degli suyceri», «stato suizero» o «dominii Elvetii». Ma le occorrenze, in questa situazione come nelle altre, oscillano sensibilmente caso per caso, testimoniando una tendenza facilmente intuibile e spiegabile: ovvero, questo tipo di menzioni sono più frequenti nelle carte redatte nel territorio e aumentano ulteriormente nei documenti ufficiali, allestiti per le autorità svizzere.
Nella Lombardia svizzera il riferimento alla sovranità non era sistematicamente esplicitato nelle denominazioni etniche e geonimiche, in special modo nei documenti vergati lontano dal territorio dei baliaggi comuni. Nel secolo XVI, con il progressivo fissarsi dell’uso cognominale anche per i ceti più modesti, una consuetudine che si è successivamente consolidata con la Controriforma, gli etnonimi oscillano anche più vistosamente, ma i riferimenti alla sovranità politica svizzera si attestano in rare occorrenze e con precise funzioni.12 A questo proposito, riagganciandoci a quanto osservato nelle pagine precedenti, possiamo vagliare la situazione di tre fra i più celebri artisti affermatisi nella vasta schiera di pittori, stuccatori, lapicidi e architetti partiti dai baliaggi italiani e attivi nei maggiori cantieri d’Italia e d’Europa.
Nel tardo Cinquecento è esemplare il caso di Domenico FontanaFontanaDomenico (1543-1607), primo di una serie di mastri provenienti dalle Prealpi lombarde che ebbero un ruolo centrale nell’edificazione della Roma barocca. L’uso etnico a lui riferito è oggetto di minime variazioni nel tempo. Nell’illustrazione che apre il suo trattato Della trasportatione dell’obelisco vaticano e delle fabriche di Nostro Signore Papa Sisto V Peretto (Sisto V)Felice di fatte dal Cavallier Domenico Fontana FontanaDomenico architetto di sua Santità , pubblicato a Roma nel 1590 e relativo all’erezione dell’obelisco di Piazza San Pietro, qui trasportato dal circo che sorgeva presso il colle Vaticano nel 1586 su ordine di Sisto VPeretto (Sisto V)Felice di, l’architetto è indicato con il nome di battesimo seguito dal riferimento al borgo natio e alla giurisdizione diocesana. Nella fascia che incornicia l’effige del mastro, posta al centro dell’incisione a tutta pagina collocata dopo il frontespizio, si legge infatti: «DOMENICO FONTANAFontanaDomenico DA MILI DIOCESE DI COMO ARCHITETTO DI S. SAN. D’ETA D’AN. XLVI».13 L’obelisco, trasportato a Roma da Eliopoli per ordine di Caligola, necessitò di un notevole impegno ingegneristico e di grandi mezzi per essere collocato al centro della piazza. A opera eseguita, sul lato nord del monumento, sotto le insegne papali di Sisto VPeretto (Sisto V)Felice di, l’architetto firmò la sua impresa ribadendo gli elementi etnici e onomastici presenti nel trattato: «DOMINICUS FONTANAFontanaDomenico EX PAGO MILI AGRI NOVOCOMENSIS TRANSTULIT ET EREXIT». Probabilmente in ragione del prestigio ottenuto con il lavoro svolto nei cantieri capitolini e napoletani, nell’edicola sepolcrale costruita nel 1627 e oggi posta nell’atrio della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli cadono invece le qualifiche municipali e regionali. Nell’iscrizione che trascrivo, FontanaFontanaDomenico è infatti indicato dai figli SebastianoFontanaSebastiano e Giulio CesareFontanaGiulio Cesare come patrizio romano, senza ulteriori riferimenti etnici:
DOMINICUS FONTANAFontanaDomenico PATRITIUS ROMANUS
MAGNA MOLITUS MAIORA POTUIT
IACENTES OLIM INSANAE MOLIS OBELISCOS
SIXTO V PONTIF.
IN VATICANO ESQUILIIS CELIO ET AD RADICES PINCIANI
PRISCA VIRTUTE LAUDE RECENTI EREXIT AC STATUIT
COMES EX TEMPLO PALATINUS EQUES AURATUS
SUMMUS ROMAE ARCHITECTUS
SUMMUS NEAPOLI PHILIPPO II PHILIPPO III REGUM
SESEQ.; AEUUMQ.; INSIGNIVIT SUUM
TEQ; INSIGNIVIT
QUEM SEBASTIANUS IULIUS CAESAR ET FRATRES
MUNERIS QUOQ.; UT VIRTUTIS AEQUIS PASSIBUS HAEREDES
PATRI BENEMERENTISSIMO P. ANNO MDCXXVII
OBIIT VERO MDCVII AETATIS LXIV
Un altro esempio rilevante si trova sempre a Roma pochi decenni più tardi e riguarda il pittore Giovanni SerodineSerodineGiovanni (1600-1630), originario di Ascona sul lago Maggiore, impostosi alla critica moderna come uno dei maggiori del suo secolo. Secondo le più recenti acquisizioni, l’artista nacque a Roma nel 1600, e non come precedentemente ipotizzato ad Ascona nel 1594, ma mantenne vivo negli anni il suo legame con la patria d’origine, nella quale i SerodineSerodineGiovanni conservarono la casa paterna e dove si trovano alcune tele di Giovanni, tra cui la grande Incoronazione della Vergine realizzata poco prima della morte per la chiesa dei SS. Pietro e Paolo.14 In una monografia del 1954, Roberto LonghiLonghiRoberto pubblica alcuni documenti d’archivio della famiglia asconese, tra cui due redazioni del testamento di Cristoforo SerodineSerodineCristoforo, il padre del pittore, nelle quali si verifica un uso etnonimico conforme alla consuetudine osservata nelle pagine precedenti. Una prima stesura in latino del 13 agosto 1625 legge infatti l’ incipit «Dominus Christophorus Serodinus condam Joannis Andreae Serodinis filius, de Ascona Comensis dioecesis mihi Notario cognitus, sanus Dei gratia mente, sensu, corpore, loquela et intellectu, asserens alias et sub die 30 Mensis Septembris 1621 […]».15 Una compilazione successiva in italiano del 19 giugno 1626 ripete gli stessi elementi con due minime variazioni, cade il patronimico e compare il riferimento geografico al lago Maggiore: «Considerando io Christoforo SerodineSerodineGiovanni d’Ascona del Lago Maggiore diocesi di Como, che in questo mondo non vi è cosa più certa della morte et più incerta dell’hora et ponto suo […]».16 Una formulazione analoga è impiegata anche da Giovanni, che in un documento datato del 24 settembre 1624 scrive: «Die 24 7bris 1624, Jo: Baptista filius Christophori Serodani de lacu maiori comen.[sis] dioec.[sis] aetatis suae annor […]».17 Se questi documenti attestano un uso conforme alle aspettative, risulta invece eccentrico l’uso di un particolare « sobriquet toponimico» (così LonghiLonghiRoberto) impiegato in alternativa al nome di battesimo per identificare il pittore. Infatti, alla morte del marchese Asdrubale MatteiMatteiAsdrubale, avvenuta nel 1631, nell’inventario dei suoi beni sono elencati «un quadro dei Farisei, quando mostrano la moneta», ovvero l’opera riconosciuta come Tributo della moneta , conservata alla National Gallery of Scotland di Edimburgo; e un’altra tela raffigurante «quando Santo Pietro e Santo Paolo andarono al martirio», cioè l’ Incontro dei Santi Pietro e Paolo sulla via del martirio , oggi a Palazzo Barberini. Entrambi i dipinti sono attribuiti a «Giovanni della Voltolina», ovvero Giovanni della ValtellinaGiovanni della Valtellina ( voltolina nelle varietà lombarde), nome dietro il quale va riconosciuto Giovanni SerodineSerodineGiovanni.18 Verosimilmente, la denominazione etnica regionale, in senso ampio, era impiegata per indentificare in ambiente romano il pittore proveniente da un modesto borgo lombardo, genericamente ricondotto alla vallata del fiume Adda. L’equivoco è forse dovuto al fatto che la Valtellina al tempo era soggetta al dominio grigionese delle Tre Leghe, alleate dei Cantoni confederati. Era cioè una terra dipendente dal potere degli svizzeri, seppur mediato dai Grigioni, e proprio come Ascona, situata nel Baliaggio italiano di Locarno, rispondeva alla sovranità dei Dodici cantoni. Inoltre, come buona parte della Lombardia svizzera, la Valtellina era luogo di emigrazione, orientata verso le maggiori città italiane, e gli emigranti dell’una e dell’altra, considerati semplicemente come lombardo-alpini, si confondevano fra loro ed erano facilmente scambiabili.19
Читать дальше