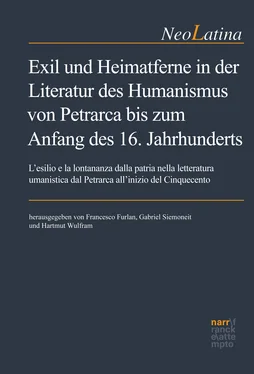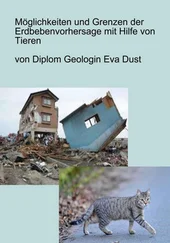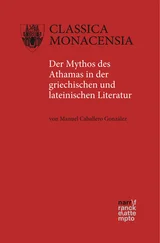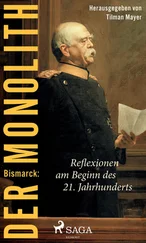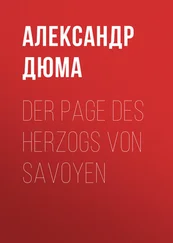1 ...7 8 9 11 12 13 ...41 Nuova partenza, che non significa però riorientamento definitivo, decisione di non guardarsi mai piú indietro – la serie che segue (dopo 81, piú penitenziale ancora) basta a testimoniarlo.99 E, per tornare un attimo a Rvf 70, non è perché vi siano tutti gli estremi del bilancio-congedo che non si canterà piú, né che ci sarà piú soavità o dolcezza, combinata con l’asperità mai dimessa. Il superamento dei punti di passaggio cui si sono voltate le spalle, e quindi le nuove partenze – quelle da se stesso comprese100 – non sono oblío totale: senza parlare delle tracce protratte di cavalcantiana sofferenza (o di dolenti reminiscenze),101 già le cantilene oculorum (71–73) prolungano in qualche modo il «bel guardo soave» ciniano ( Rvf 70, 40); e pensiamo pure ai ritorni continui, fino alla fine della raccolta, al «dolce tempo de la prima etade» (limite estremo di tali ritorni: la fronte del sonetto 352,102 e le ultime tentazioni mnesiche della canz. 359).
Manca lo spazio per considerazioni dettagliate sulla sestina doppia ( Rvf 332). Ma un’analisi puntuale metterebbe senz’altro in evidenza la straordinaria attitudine petrarchesca a frattalizzare l’esilio- peregrinatio in svariati modi lungo tutto il Canzoniere , specie nei punti nodali, strategici.103
Ecco, a una valutazione fattasi via via piú microscopica, alcuni (alcuni soltanto) aspetti, credo significativi, del vivere petrarchesco esule in lingua. Questa prima ricognizione sembra avvalorare l’ipotesi di un Petrarca che vive nella lingua, che vive la lingua inventandola giorno dopo giorno, da peregrinus ; una lingua fattasi nel Canzoniere destino tendenzialmente infelice, specie – ma non solo – dopo la morte di Laura.104 Un pellegrino piú ubique di quanto egli lasci intendere spesso e volentieri, ché bisogna sempre tener conto anche di ciò che dissimula / dissimila: le contrade che vorrebbe farci credere di non aver mai perlustrato, i paesi che dimentica accuratamente di confessare essere stati da lui visitati, ma che lasciano impronte talvolta indelebili.105 Che dire allora per concludere? Che questa prima, molto imperfetta ricognizione invita a nuovi sondaggi, su scala allargata, scavando sistematicamente altri strati. Chiama nuove partenze, condotte con metodo piú sicuro, ma anche con spirito aperto a sorprese, a scoperte di paesaggi insospettati. Per capire meglio come questo scrittore apolide (che avverte l’esilio come una condizione, anzi se ne fregia), non sia senza una terra d’elezione: l’Italia sognata della renovatio e, soprattutto, la lingua che va inventando, man mano che percorre e ripercorre tutte le terre dove ha deciso (o meno) di passare e ripassare per soddisfare la sua inarrestabile e selettiva (ma non esattamente come si credeva) curiosità, sperimentando soluzioni che sono anche – e anzitutto – esperienze di vita. Che lasciano tracce, vestigia improntate anche a nostalgia. La «sapientia» (in fatto di scrittura) essendo figlia della pratica («usus») e della memoria, come insegna Agostino, che «ha definito l’arte come la memoria delle cose sperimentate e che sono piaciute».106
Afribo, Andrea: Petrarca e petrarchismo: Capitoli di lingua, stile e metrica, Roma 2009.
Agamben, Giorgio: Nymphæ, in: Image et mémoire: Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, Traduit par M. Dell’Omodarme, S. Doppelt, D. Loayza et G. A. Tiberghien, Paris 2004, 37–69.
Antognini, Roberta: Il progetto autobiografico delle Familiares di Petrarca, Milano 2008.
Ariani, Marco: Petrarca, Roma 1999.
Blanc, Pierre: Le discours de l’intellectuel comme parole d’exilé: Psycho-poétique de l’exil chez Dante et chez Pétrarque, in: Jacques Heers / Christian Bec (edd.): Exil et civilisation en Italie (XII e–XVI esiècles), Nancy 1990, 49–59.
Cachey, Theodor: Il lettore in viaggio con Francesco Petrarca, in: Luca Marcozzi (ed.): Petrarca lettore: Pratiche e rappresentazioni della lettura nelle opere dell’umanista, Firenze 2016, 143–155.
Carrai, Stefano: Il mito di Ulisse nelle Familiari , in: Claudia Berra (ed.): Motivi e forme delle Familiari di Francesco Petrarca, Milano 2003, 167–173.
Coletti, Vittorio: Storia dell’italiano letterario: Dalle origini al Novecento, Torino 22000.
Contini, Gianfranco: Preliminari sulla lingua del Petrarca [Paragone aprile 1951], in: Id.: Varianti e altra linguistica, Torino 1970, 169–192.
De Robertis, Domenico: Petrarca petroso, Revue des é tudes italiennes ns. 29, 1983, 13–37.
Fenzi, Enrico: Saggi petrarcheschi, Fiesole 2003.
Fenzi, Enrico: Petrarca e l’esilio: Uno stile di vita, in: Anna Fontes Baratto / Marina Gagliano (edd.): Écritures de l’exil dans l’Italie médiévale, Arzanà 16–17, 2013, 365–402.
Filippini, Célia: v. Telesinski, Anne-Marie.
Gentili, Sonia: Solitudine, in Luca Marcozzi / Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 308–320.
Grimaldi, Marco: Petrarca, il «vario stile» e l’idea di lirica, Carte romanze 2, 2014, 151–210.
Guérin, Philippe: Autour des Rerum vulgarium fragmenta : Poésie et pensée de la ruine, in: Paolo Grossi / Frank La Brasca (edd.): Sul Canzoniere di Francesco Petrarca, Atti della giornata di studî (25 novembre 2005), Paris 2006, 101–137.
Guérin, Philippe: De l’image au texte et du texte à l’image: Sur les puissances de la peinture chez Boccace, in: Johannes Bartuschat (ed.): Boccace à la Renaissance: Lectures, traductions, influences en Italie et en France, Actes du Colloque international Héritage et fortune de Boccace, Université Stendhal Grenoble 3 (12–14 octobre 2006, Cahiers d’Etudes Italiennes. Filigrana 8, 2008, 13–39.
Guérin, Philippe: Pétrarque, ou de l’écriture comme odyssée, in: Voyages de papier: Hommage à Brigitte Urbani, Revue d’ é tudes italiennes du CAER, Aix Marseille Université 17/18, 2014, 31–57.
Guérin, Philippe: Poesia, in: Luca Marcozzi / Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 244–259.
Guittone d’Arezzo: Le Rime di Guittone d’Arezzo, A cura di Francesco Egidi, Bari 1940.
Manni, Paola: Storia della lingua italiana: Il Trecento toscano, Bologna 2003.
Marcozzi, Luca: Retorica dell’esilio nel canzoniere di Petrarca, Bollettino di italianistica ns. 8.2, 2011, 71–93.
Marcozzi, Luca: Petrarca e l’esilio nel tempo, in: Elisa Brilli / Laura Fenelli / Gerhard Wolf (edd.): Images and words in Exile: Avignon and Italy at the beginning of the 14 thcentury, Firenze 2015a, 223–237.
Marcozzi, Luca: Petrarca testimone dell’esilio di Dante, in Johannes Bartuschat (ed.): Dante e l’esilio, Ravenna 2015b (Letture classensi, vol. 44), 97–126.
Marcozzi, Luca: Tempo, in Luca Marcozzi / Romana Brovia (edd.): Lessico critico petrarchesco, Roma 2016, 321–332.
Patota, Giuseppe: La grande bellezza dell’italiano: Dante, Petrarca, Boccaccio, Roma / Bari 2015.
Perrus, Claude: La sextine LXXX du Canzoniere, Chroniques italiennes 61, 2000, 5–15.
Petrarca, Francesco: Opere: Canzoniere, Trionfi, Familiarum rerum libri [testo latino secondo l’edizione critica curata da Vittorio Rossi e Umberto Bosco per l’Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca, Firenze, Sansoni, 1933–1942, X–XIII], Firenze 1992a.
Petrarca, Francesco: Secretum / Il mio segreto, A cura di Enrico Fenzi, Milano 1992b.
Petrarca, Francesco: Les remèdes aux deux fortunes / De remediis utriusque fortune, Texte établi et traduit par Christophe Carraud, Commentaire, notes et index par Christophe Carraud, 2 vol., Grenoble 2002.
Petrarca, Francesco: Canzoniere, A cura di Ugo Dotti, 2 vol., Roma 22004a.
Читать дальше