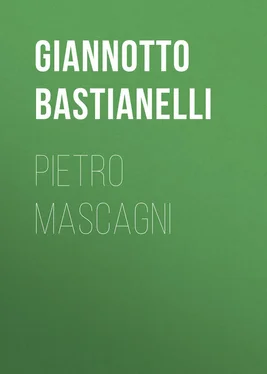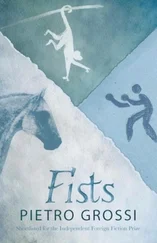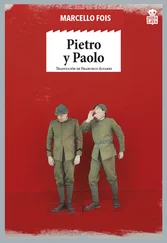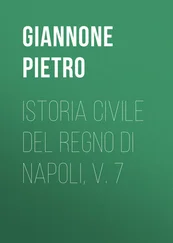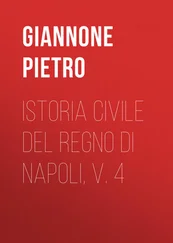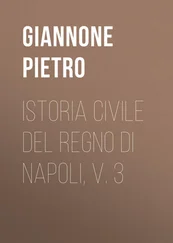Giannotto Bastianelli - Pietro Mascagni
Здесь есть возможность читать онлайн «Giannotto Bastianelli - Pietro Mascagni» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: foreign_antique, foreign_prose, на итальянском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Pietro Mascagni
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pietro Mascagni: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Pietro Mascagni»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Pietro Mascagni — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Pietro Mascagni», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Analizziamo dunque questa bella e fresca prefazione.
La Cavalleria , a differenza delle opere successive del Mascagni nelle quali viene usato, almeno nell'intenzione, un sistema analogo a quello wagneriano della melodia continua ; – dico analogo, giacchè, se il discorso musicale del Mascagni è, come dicono oggi, continuo, la sua concezione è per sua intima natura, opposta alla volubile fluenza del polifonismo wagneriano – è divisa in tanti pezzi staccati secondo l'antico sistema prewagneriano. E questo sistema dei pezzi formanti un tutto da loro stessi, è un vero peccato sia poi stato abbandonato dal Mascagni. Il genio latino, generalmente, non ha potente in sè, come il tedesco, il senso dello svolgimento ininterrotto della Storia, del divenire inarrestabile e irrivertibile delle cose. Egli ha ereditato dal mondo ellenico la classica oggettività, il bisogno del ciclo simmetrico della strofe, invece della prosa flessibile e asimmetrica. Così al posto degli interminabili svolgimenti aritmici e simili al pesante e indeterminato flusso della materia, così cari a Riccardo Wagner e ai seguaci Riccardo Strauss e Claudio Debussy 5 5 Sebbene il recitativo debussysta non sia più maestoso come quello wagneriano, nè di Wagner il presente dittatore della musica francese accetti il sistema polifonico, Debussy è forse più wagneriano dello stesso Strauss. Il perchè della mia affermazione non potrei dire in due parole. Su ciò vedi, nel giornale La Voce di Firenze, i miei tre articoli: Claude Debussy , Impressionismo musicale , Ciò che ci può insegnar Beethoven .
, egli ama le brevi forme nitide, i contenuti ben serrati dai solidi argini del ritmo. Così le cadenze che chiudono ogni pezzo mascagnano, sieno pure abilmente mascherate e dissimulate, generano in noi il senso della perfezione, poichè quei motivi e quelle melodie, che si avvolgono e si svolgono in periodi regolari come strofi della lirica greca o degli inni sillabici del canto gregoriano, non son fatte per essere contorte e concatenate secondo i dogmi, a loro estranei, del sistema wagneriano o dei sistemi da quello nati. La guerra alle cadenze che oggi infierisce nella musica, è errata per Mascagni e starei per dire per la musica italiana; sarebbe come fare in nome del verso aritmico dei verslibristes una guerra alla rima nella nostra poesia rimasta tuttavia a strofa ritmicamente obbligata. E il Mascagni laddove tenta di obbedire ai canoni del discorso libero o simile alla prosa del romanzo e della commedia in prosa, non ha fatto che generare un malinteso puramente grafico, malinteso che si dissipa all'audizione, se pure l'intento non sia stato davvero raggiunto a scapito della musica stessa.
L'opera è preceduta da un preludio di carattere più lirico che descrittivo sebbene d'una certa descrittività. A un breve episodio religioso che ci avverte di essere in un giorno festivo (la Pasqua), tracciando così un poco la cornice del quadro passionale che a poco a poco ci vedremo svolgere dinanzi, segue un motivo che potrebbe chiamarsi: il pianto di Santuzza; chè, infatti, esso e gli incisi che lo seguono, son tratti dal duetto tra Santuzza e Turiddu. A questo episodio, che subito c'immerge in quell'atmosfera di calda sensualità disperata, caratteristica vibrante dell'anima del Mascagni, succede una cadenza delle arpe preludiante alla Siciliana – una canzone cantata a sipario calato da Turiddu sotto le finestre di Lola. Ecco così che i personaggi sono già evocati tutti e quasi lineati dal preludio. La Siciliana è una melodia bellissima, serena sebbene languida di passione. È come una stasi intima e profonda nel terribile dramma che ha già cominciato a scatenarsi. Non è detto se sia una mattinata o una serenata ; ma noi sentiamo in essa quella indefinibile aspirazione quasi a superare i limiti dei corpi e gli argini delle azioni, che trema nelle popolari canzoni d'amore, cantate nei due crepuscoli, in alcune nostre provincie, a cui la civiltà s'è appena avvicinata. Non so se la musica della Siciliana sia originale oppur ripresa da un vero e proprio motivo popolare. Il fatto è che Mascagni ha qui avuto una stupenda intuizione del sentimento che doveva avere una canzone popolare.
Ma improvvisamente l'incanto vien spezzato dal dramma feroce che prorompe di nuovo e con maggior foga. Il fascino lascivo della canzone vien come affogato nell'onda furiosa dell'orchestra, dove nuovi impeti di passione balzano alternati da murmuri sordi come di collera e da echi lontani di melodie umili come di preghiera. Finchè comincia a svolgersi maestoso e doloroso il motivo esprimente l'urto tragico tra l'amor vano di Santa per Turiddu e la noncuranza satura di rimorsi di quest'ultimo, motivo a cui, dopo un fortissimo spasimante, s'attacca il pianto di Santuzza, così pieno di disperazione rassegnata. E il preludio si chiude con una lunga cadenza sacra che riprende e compie la cornice sacra con cui esso si era aperto.
A proposito della descrittività di questo preludio mi si potrebbe obbiettare che il significato che io dò ad esso può anche dipendere da una retroproiezione del significato del dramma su di esso. In altre parole: se questo preludio fosse eseguito separatamente, esso non potrebbe parlarci di Santuzza e del suo dolore. Ma la questione è che questo preludio non dev'essere eseguito separatamente, per la semplice ragione che esso è stato concepito insiem col dramma. Nè, parimente, è vero che tutte le parti d'un'opera debbano, se staccate da essa, dirci da loro sole a qual causa, per dir così, sono votate. Se la Cappella Sistina fosse per ipotesi scancellata dal tempo di sul muro dov'è dipinta e dalla memoria umana, colui che ne venisse a scoprire un frammento, ad es: una delle Sibille, si troverebbe, credo, ben'imbrogliato a ricostruire il tutto, risalendo ad esso da quella parte frammentaria. Lo stesso si dica di uno dei frammenti scampati al naufragio del teatro greco. Una frase, un motivo, una figura prendono il loro significato dal testo al quale sono concreate. È il tutto che dà il valore delle parti, o, meglio, è l'intuizione, per dir così, centrale, che s'è espanta armoniosamente nelle più estreme ramificazioni del tutto. Le parole, le frasi, i periodi; le note, gli accordi, i motivi, gli svolgimenti, etc. etc., non sono che forme del linguaggio, il quale è composto di simboli vuoti e, per dir così, non solo empibili di sempre mutevole contenuto, ma trasportabili in quella di tutte le posizioni rispetto al tutto, che possa contribuire maggiormente a raggiungere l'intuizione madre, a esprimerne la vita, almeno approssimativamente. L'essere scettici riguardo alla descrittività della musica, o meglio al suo valore determinativo, è essere scettici del potere rappresentativo del linguaggio umano; e se tale scetticismo spesso non ha luogo di esercitarsi sul linguaggio parlato, ciò dipende dalla lunga abitudine, che ha soffocato lo stupore del miracolo.
Il sipario si alza davanti alla piazzetta d'un paese in festa. È mattina. Le campane suonano e dal loro ritmo vien generato, con un'intuizione geniale, il motivo gaio e esuberante di trilli di colore e di squilli di luce, che descrive la pasqua. Son frasi gaie, lanciate con un brio rossiniano di danza, alle quali si unisce a poco a poco il doppio coro, quello femminile cantante una fresca e delicata melodia primaverile, quello maschile, rude, un po' sgarbato nella sua allegria contadinesca. La scena è indovinatissima. Potrà forse sembrare triviale a certi critici di palato ipersensibile, ma chi conosce bene le pasque gioconde delle nostre città italiane col loro bel sole d'aprile, con quel brulichio d'abiti femminili dai colori accesi che formano colle luci e con le ombre accordi policromi sempre cangianti; chi ha provato quel senso tutto caratteristico di allegria spensierata e di facile felicità che effondono lo scampanio incessante e il clamore della folla, diverso, non so perchè, da quello delle altre domeniche, riconoscerà che Pietro Mascagni ha mirabilmente rappresentato in questa scena introduttiva il mattino della pasqua popolare italiana.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Pietro Mascagni»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Pietro Mascagni» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Pietro Mascagni» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.