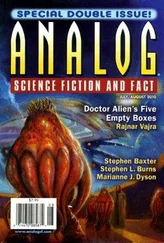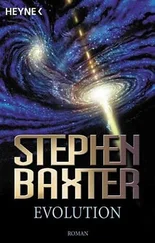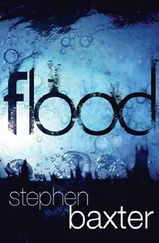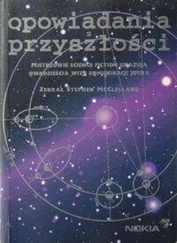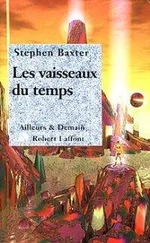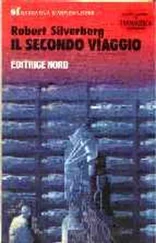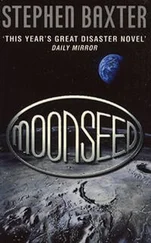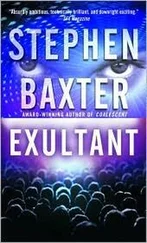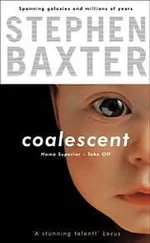Mi alzai a sedere nell’oscurità impenetrabile. Nel posare le mani sul pavimento, sentii uno strato di granelli ruvidi, come di sabbia stesa sopra una superficie più dura. Benché indossassi soltanto la camicia, i calzoni e gli stivali, non avevo freddo. Gli echi dell’urlo che mi ero lasciato scioccamente sfuggire erano rimbalzati come in uno spazio chiuso.
Girai la testa all’intorno, in cerca di una finestra o di una porta, ma invano. Poi mi accorsi di avere qualcosa intorno alla testa: un oggetto che mi premeva sul naso. Sollevando le mani a investigare, scoprii d’indossare un paio di occhiali pesanti.
Li palpai, e l’ambiente fu invaso da una luce splendente.
Accecato, serrai d’istinto gli occhi, quindi mi strappai gli occhiali, e la luce scomparve, lasciandomi di nuovo immerso nell’oscurità. Li rimisi, e la luce tornò.
Non fui costretto a sforzarmi molto per capire che il buio era reale, mentre la luce era fornita dalle lenti, che avevo attivato inavvertitamente. Dunque gli occhiali erano simili a quelli che il povero Nebogipfel aveva perduto nel paleocene, durante la tempesta.
Quando la vista si fu abituata alla luce, mi alzai e mi osservai. Ero integro e apparentemente sano. Sulle mani e sulle braccia non trovai tracce dell’attività pervasiva della piramide. Trovai invece una serie di chiazze bianche sul tessuto della camicia e dei calzoni militari. Palpandole, scoprii che erano in rilievo: sembrava che si trattasse di rozzi rammendi.
La stanza in cui mi trovavo, larga circa tre metri e mezzo e alta altrettanto, era la più strana che avessi visto sino a quel momento durante tutti i miei viaggi attraverso il tempo. Sembrava una stanza d’albergo del tardo diciannovesimo secolo, però non era a pianta rettangolare, come nella mia epoca, bensì di forma conica, simile all’interno di una tenda, priva di porta e di mobilio, con il pavimento coperto da uno strato uniforme di sabbia, in cui si era impressa, dove avevo dormito, l’impronta del mio corpo. Le pareti, e persino i pannelli delle finestre dalle pesanti tende scostate, erano rivestiti di carta da parati ruvida, di un vistoso color porpora.
Benché non vi fosse alcuna fonte d’illuminazione, nella stanza era diffusa una luce uniforme e fioca, simile a quella di una giornata nuvolosa, dovuta sicuramente agli occhiali che indossavo. Il soffitto era decorato con straordinari dipinti barocchi, in cui riuscii a distinguere forme umane frammentarie e distorte: non grottesche, bensì rozze e confuse, come se fossero state dipinte da un artista dotato dell’abilità tecnica di Michelangelo e dell’immaginazione di un bimbo ritardato.
In sostanza, quell’ambiente sembrava una camera d’albergo a poco prezzo della mia epoca, però trasfigurata magicamente, come in un sogno.
Con gli stivali che scricchiolavano sulla sabbia, esaminai la stanza.
Le pareti non avevano commessure, né vi era alcuna traccia di una porta. Trovai un cubo di porcellana bianca di circa novanta centimetri di lato. Quando vi montai, inaspettatamente, da alcune aperture nelle pareti uscirono sibilando getti di vapore. Sconcertato, smontai dal cubo e i getti cessarono. Il vapore che indugiava mi sfiorò il viso.
Sulla sabbia trovai alcune ciotoline larghe come una mano aperta, con il bordo rilevato, come piattini. Alcune contenevano acqua, altre cibi semplici, come frutta, noci, e bacche, che però non riuscii a riconoscere. Assetato, vuotai due delle tazze che contenevano l’acqua. Erano tutt’altro che comode, perché erano così poco profonde che, nel bere, si rischiava sempre di rovesciarne il contenuto: più che a tazze, assomigliavano a recipienti adatti ai cani o ai gatti. Assaggiai la frutta, che era poco saporita, ma gradevole.
Con le dita e con le labbra appiccicose, cercai un lavandino o un bagno per lavarmi, ma ovviamente non trovai nulla. Ricorsi perciò all’acqua contenuta in un’altra ciotolina, infine mi asciugai con un lembo della camicia.
Dopo avere palpato le finestre finte, tentai, con una serie di salti, di esaminare anche il soffitto dipinto: le pareti e il pavimento erano lisci come gusci d’uovo, ma infrangibili. Scavando, trovai sotto lo strato di sabbia, spesso circa trenta centimetri, un mosaico di tessere sgargianti, che ricordava quelli degli antichi Romani, però era caratterizzato da un guazzabuglio di composizioni frammentarie in cui non riuscii a distinguere alcuna forma.
Dall’esterno non proveniva alcun rumore. Ero del tutto solo, in un piccolo universo silenzioso, in cui si udivano soltanto il frusciare del mio respiro e il palpitare del mio cuore: gli stessi suoni che soltanto poco tempo prima avevo accolto con gioia veemente.
Con il trascorrere del tempo, mi s’imposero le necessità fisiologiche. Resistetti il più a lungo possibile, ma alla fine fui costretto a scavare fosse nella sabbia per orinare e per evacuare.
Nel coprire la prima fossa, provai la più spiccata vergogna. Mi chiesi come avrebbero giudicato il mio comportamento gli Uomini Stellari di quel remoto 1891.
Allorché la stanchezza mi sopraffece, sedetti sulla sabbia, addossato alla parete, e dopo un poco mi tolsi gli occhiali, perché la loro luminosità m’impediva di riposare. Tenendoli in mano, mi addormentai.
Così iniziò il mio soggiorno in quella prigione bizzarra. La mia paura iniziale si placò, sostituita poco a poco dalla noia e dall’inquietudine. La prigionia mi rammentò il periodo che avevo trascorso nella Gabbia di Luce dei Morlock, da cui ero uscito senza alcun desiderio di ripetere l’esperienza. Mi convinsi che tutto, persino il pericolo, sarebbe stato preferibile a rimanere in quella cella sigillata e tediosa. L’esilio nel paleocene a cinquanta milioni di anni dal giornale più accessibile, mi aveva guarito dall’antica compulsione alla lettura, comunque temetti, a volte, di essere sul punto d’impazzire per l’impossibilità di conversare.
Durante ogni mio periodo di sonno, le ciotole vennero riempite di cibo e di acqua, senza che riuscissi a capire in qual modo: non trovai alcuna traccia di macchine capaci di spuntare dalle pareti o dal pavimento, come quelle dei Morlock, e neppure vidi qualcuno entrare in qualche modo.
Una volta, per puro esperimento, mi addormentai sopra una ciotola collocata nella sabbia. Al risveglio, mi accorsi di avere un fianco bagnato e scoprii, nell’alzarmi, che la ciotola era stata portentosamente riempita d’acqua.
Giunsi così a congetturare che ogni ciotola contenesse una micromacchina capace, in qualche modo, di ricavare l’acqua e il cibo dalla sostanza dei contenitori stessi, oppure dall’aria. Pur senza avere alcun desiderio di verificare, supposi che micromacchine dello stesso genere, invisibili e silenziose, provvedessero ad eliminare i miei rifiuti organici sepolti nella sabbia. La possibilità che ne derivava era bizzarra e poco allettante.
2
Esperimenti e meditazioni
Dopo tre o quattro giorni, sentii la necessità di lavarmi a dovere. Infatti, come ho detto, la stanza non aveva nulla che assomigliasse a un impianto sanitario, e le abluzioni che potevo permettermi con l’acqua potabile delle ciotole non erano affatto soddisfacenti: desideravo un bagno, o meglio ancora una nuotata nel mare paleocenico.
Forse merito di essere considerato ottuso a questo proposito, comunque passò un certo tempo prima che dedicassi nuovamente la mia attenzione al cubo di porcellana che ho già descritto, e che avevo sempre ignorato dopo la prima ispezione della stanza. Mi avvicinai dunque al cubo. Allorché posai cautamente un piede sulla superficie di porcellana, le pareti emisero getti di vapore.
D’improvviso, capii. In un accesso d’entusiasmo, mi spogliai completamente, tranne gli occhiali, quindi montai sul cubo. Il vapore mi avvolse, facendomi sudare, e l’umidità mi appannò le lenti. Mi ero aspettato che il vapore si diffondesse, trasformando la stanza in una sauna; invece rimase confinato alla zona del cubo, senza dubbio grazie a un sistema basato sulle differenze di pressione atmosferica.
Читать дальше