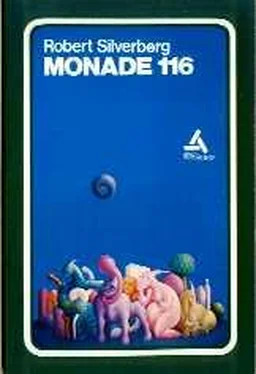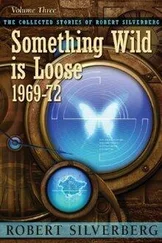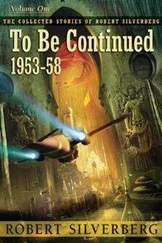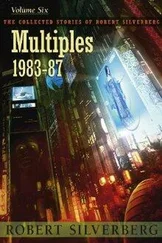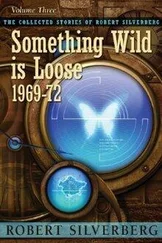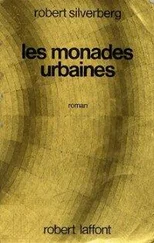Il pozzo di salita lo scarica 160 piani più in alto verso il cielo. Uscendo, si trova a Roma. Sale affollate, volti tesi. Il pubblico è composto per la maggior parte di burocrati di grado minore, un campionario medio di funzionari falliti, di uomini che non si recherebbero mai a Louisville se non per consegnare un rapporto. Non sono neppure abbastanza eleganti da sperare di raggiungere Chicago o Shanghai o Edimburgo. Rimarranno in questa buona città grigia, raggelata in una stasi consacrata, facendo lavori che qualsiasi computer eseguirebbe quaranta volte meglio di loro. Dillon prova una pietà cosmica per chiunque non sia un artista, ma compatisce più di tutti gli abitanti di Roma, talvolta. Perché non sono nulla. Perché non possono usare né il loro cervello né i loro muscoli. Anime paralizzate, serie, che camminano; meglio venire precipitati nello scarico. Un Romano viene a sbattere contro di lui mentre indugia fuori del pozzo di discesa, meditando su queste cose. Maschio, forse quarant’anni, tutto lo spirito è defluito dai suoi occhi. Il morto che cammina. Il morto che corre. «Mi spiace,» mormora l’uomo, e continua ad andare di fretta. «Verità!» gli grida dietro Dillon. «Ama! Rilassati! Chiava un sacco!» Ride. Ma che importa; il Romano non riderà con lui. Altri dello stesso tipo vengono correndo per il corridoio e i loro corpi pesanti assorbono le ultime vibrazioni delle esclamazioni di Dillon. «Verità! Amore!» Suoni indistinti che si dileguano, si attenuano, svaniscono. Svaniti. Suonerò per voi questa sera, dice loro silenziosamente. Vi condurrò fuori delle vostre miserabili menti e voi mi amerete per questo. Potessi soltanto bruciare i vostri cervelli! Potessi soltanto strinare le vostre anime!
Pensa ad Orfeo. Mi farebbero a pezzi, capisce, se riuscissi mai a raggiungerli davvero.
Si dirige svogliatamente verso il centro sonico.
Fermandosi presso la curva a gomito del corridoio, e poi ancora a metà della strada che conduce all’auditorium passando tutt’intorno all’edificio, Dillon sente un’improvvisa estatica consapevolezza dello splendore della monade urbana. Un’epifania frenetica: la vede come una punta sospesa tra cielo e terra. Ed egli qui si trova quasi nel punto di mezzo: ha poco meno di cinquecento piani sopra il capo, poco più di cinquecento sotto i piedi. Gente che va in giro, che si accoppia, mangia, partorisce, fa un milione di cose degne di benedizione, e ciascuno è uno delle 800-quante-famiglia che percorre una sua orbita. Dillon ama l’edificio. Proprio ora sente che potrebbe quasi librarsi nell’aria sulla sua molteplicità nello stesso modo in cui altri potrebbero sollevarsi per mezzo di una droga. Essere all’equatore, bere il divino equilibrio - oh, sì, sì! Ma naturalmente c’è un modo di sperimentare l’intera complessità della monurb in un solo selvaggio flusso di informazione. Non l’ha mai tentato; in realtà non è assuefatto, si è fermato lontano dalle droghe più elaborate, le sole capaci di aprire la mente in modo che ogni cosa possa vagare dentro di essa. Tuttavia qui, a metà della monurb, sa che questa è la sera adatta a provare il multiplex. Dopo il concerto. Prendere la pillola che gli permetterà di far cadere le barriere mentali, di permettere alla piena immensità di Monade 116 di penetrare nella sua consapevolezza. Sì. Per farlo andrà al 500° piano. Se lo spettacolo avrà successo. Passeggio notturno a Bombay. In realtà dovrebbe aggirarsi nella città nella quale il concerto verrà tenuto, ma Roma non scende sotto il 521° piano, ed egli deve andare al 500°. Per la simmetria mistica delle cose. Anche se è ancora inesatto. Dove si trova il vero punto di mezzo di un edificio di mille piani? In qualche parte tra il 499° e il 500° piano, non è vero? Ma andrà bene il 500° piano. Impariamo a vivere con approssimazione.
Entra nel centro sonico.
Un bell’auditorium nuovo, altro tre piani, con un palcoscenico a fungo e una rete di posti per gli spettatori disposti concentricamente attorno ad esso. Lo splendore della luce vaga nell’aria. Le bocche degli altoparlanti posti nel soffitto a cupola della ricca struttura, si chiudono e si spalancano. Una sala calda, una buona sala, costruita qui dalla divina carità di Louisville per portare un poco di gioia nelle vite di questi Romani senza sugo. Nell’intera monurb non c’è una sala migliore per un gruppo cosmos. Gli altri membri del gruppo sono già arrivati e stanno accordando gli strumenti. L’arpa-cometa, l’incantatore, il tuffatore-orbitale, l’imbibitore-di-gravità, l’invertitore doppler, il cavalcatore-dello-spettro. La sala trema già per i suoni scintillanti e per le allegre esplosioni di colore, e un raggio di pura trama senza riferimento, astratta e immanente, si sta levando dal cono centrale dell’invertitore doppler. Tutti gli fanno cenni. «È tardi, amico,» dicono, e: «Dove sei stato?», «Pensavamo che non ti preoccupassi della prova,» ed egli dice: «Sono stato in giro per le sale, a vendere amore ai Romani,» parole che li fanno sbottare in interminabili acute risate. Si arrampica sul palcoscenico. Il suo strumento si trova incustodito sul limitare del palcoscenico, i tralicci penzolanti, il bell’involucro di pelle lucente. Una macchina per sollevare è lì vicino e attende di aiutarlo a metterlo nel posto più adatto. La macchina ha portato il vibrastar nell’auditorium e lo accorderebbe anche, se glielo chiedesse, ma naturalmente egli non lo vorrà. I musicisti hanno una mistica per l’accordatura del loro strumento. Anche se gli occorreranno almeno due ore per accordare, e la macchina potrebbe farlo in dieci minuti. I lavoratori della manutenzione e altri umili della classe dei grubbo hanno la stessa mistica. Non è strano: si deve continuamente combattere contro la propria obsolescenza se si vuole continuare a pensare a se stessi come a una persona che ha uno scopo nella vita.
«Qui sopra,» dice Dillon alla macchina.
Questa porta il vibrastar con delicatezza fino alla presa dell’allacciamento e lo collega. Dillon non avrebbe potuto muovere da solo lo smisurato strumento. Non gli importa di permettere alle macchine di compiere le azioni che non potrebbero mai compiere gli uomini, come sollevare pesi di tre tonnellate. Dillon appoggia le mani sulla manipolatrice e sente la potenza strimpellando sulla tastiera. Bene. «Vai,» dice alla macchina ed essa scivola via silenziosamente. Impasta e spreme i proiettroni della manipolatrice. Come se stesse mungendo. Il piacere sensuale nel prendere contatto con la macchina. Un piccolo orgasmo ad ogni crescendo. Sì. Sì. Sì.
«Sintonizzo!» avverte gli altri musicisti.
Inseriscono il feedback nei loro strumenti; altrimenti l’improvviso irrompere di Dillon potrebbe recar danno sia agli strumenti che ai suonatori. Ad uno ad uno gli fanno segno di essere pronti, ultimo si associa il ragazzo dell’imbibitore, ed infine Dillon può innestare. Sì! La sala si riempie di luci. Stelle fluiscono dalle pareti. Riveste il soffitto di nebulose gocciolanti. Egli è lo strumento base del gruppo, l’importantissimo continuo, che fornisce la base sulla squale gli altri faranno la loro esecuzione. Con occhio esercitato controlla il fuoco. Ogni cosa è chiara. Nat il cavalcatore-dello-spettro dice: «Il colore di Marte è un poco fuoritono, Dill.» Dillon cerca Marte. Sì. Sì. Gli fornisce un tocco extra d’arancio. E Giove? Un globo splendente di fuoco bianco. Venere. Saturno. E tutte le stelle. È soddisfatto della parte visiva.
«Alzate il suono, ora,» dice.
Il palmo delle mani colpisce il pannello di controllo. Dagli altoparlanti spalancati giunge un tenero filo di rumore bianco. La musica delle sfere. Ora lo colorisce, dando forza alla parte galattica, lasciando che il movimento stellare conferisca un colore risonante al tono. Poi, con un veloce colpo verso il basso sui proiettroni, pesta col piede sui suoni planetari. Saturno turbina come una cintura di coltelli. Giove tuona. «Lo afferrate?» esclama. «Com’è la chiarezza?» Sophro il tuffatore-orbitale dice: «Ingrossa gli asteroidi, Dill,» ed egli obbedisce. Sophro annuisce, felice, il mento tremante per il piacere.
Читать дальше