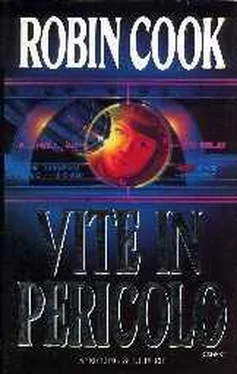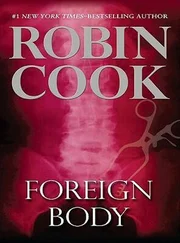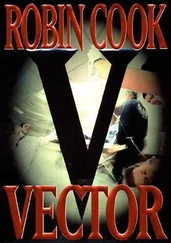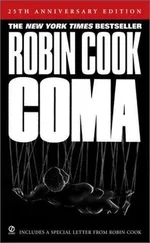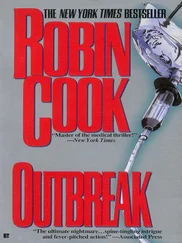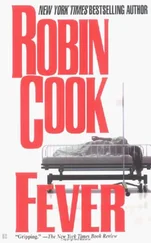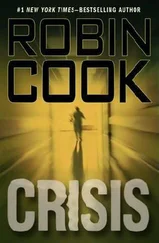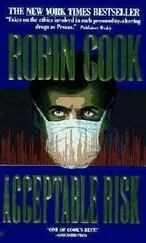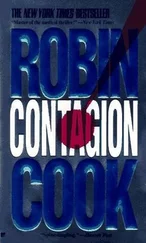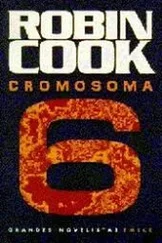«Qualche problema?» le domandò Wadley.
«No», rispose lei seccamente.
«Mi faccia dare un’occhiata», le disse lui, avvicinandosi al microscopio. «Di quale caso si tratta?»
Angela gli cedette la sedia e gli diede succinte spiegazioni. Lui guardò il vetrino, poi si alzò.
Rimasero per un momento a parlare del vetrino e concordarono su una diagnosi benigna.
«Più tardi la voglio vedere nel mio studio», disse Wadley, facendole l’occhiolino.
Angela annuì, ignorando quel gesto, poi si voltò e, mentre stava per sedersi, sentì la mano di Wadley toccarle il sedere e lui aggiungere, prima di uscire dal laboratorio: «E non lavori troppo, tesoro!»
Tutto era accaduto talmente in fretta che Angela non fu in grado di reagire. Ma questa volta non c’erano dubbi, non si era trattato di un gesto involontario, ed ebbe così la conferma che non lo era stato nemmeno quello del giorno prima.
Per qualche minuto rimase seduta a tremare per l’indignazione e la confusione. Si chiedeva che cosa avesse incoraggiato quell’improvvisa sfacciataggine; di certo lei non aveva cambiato il proprio comportamento in quegli ultimi giorni. Che cosa doveva fare? Non poteva rimanere lì seduta e permettere che la cosa continuasse, sarebbe stato un invito esplicito.
Decise di avere due possibilità. Poteva affrontare direttamente il dottor Wadley oppure rivolgersi al direttore medico, Michael Caldwell. Ma poi pensò al capo del personale, il dottor Cantor. Magari avrebbe potuto andare da lui.
Sospirò. Né Caldwell né Cantor le sembravano in un caso simile le autorità adatte a cui rivolgersi. Erano entrambi maschilisti e lei si ricordava la loro reazione la prima volta che si erano visti. Caldwell era sembrato scioccato che le donne potessero fare i patologi e Cantor si era lasciato andare a quell’osservazione idiota sulle sue compagne «racchie» alla facoltà di Medicina.
Pensò di nuovo di affrontare direttamente Wadley, ma anche questa alternativa non l’attirava.
Il ronzio rauco del citofono la fece sussultare, riportandola alla realtà. «Dottoressa Wilson», disse la voce della caposala, «stanno aspettando i risultati della biopsia alla sala operatoria numero tre.»
Quella mattina, David trovò ancora più difficile concentrarsi sui problemi dei suoi pazienti, rispetto al pomeriggio precedente. Non solo era ancora sottosopra per l’incontro con Kelley, ma si preoccupava per le condizioni di Marjorie Kleber.
A metà mattinata ricevette John Tarlow, il paziente affetto da leucemia, che aveva fatto passare anche se non aveva un appuntamento perché si trattava di un caso di emergenza. Soltanto il giorno prima lo avrebbe mandato al pronto soccorso, ma dopo la lavata di capo di Kelley non se la sentiva.
John aveva mangiato dei frutti di mare crudi, la sera precedente, e ora stava malissimo, con vomito e diarrea. Era disidratato e soffriva di coliche addominali.
David decise di ricoverarlo immediatamente e ordinò una serie di analisi per scoprire la causa dei suoi sintomi. Inoltre, gli prescrisse una fleboclisi per reidratarlo. Per il momento, decise di non ricorrere agli antibiotici, preferendo attendere di sapere di che cosa si trattasse. Poteva essere un’infezione batterica o una reazione dell’organismo alle tossine; un’intossicazione alimentare, in parole povere.
Poco prima delle undici, Traynor ricevette la cattiva notizia dalla sua segretaria, Collette: Jeb Wiggins aveva nuovamente riunito il consiglio comunale e la richiesta di autorizzazione per costruire il garage, che Traynor era riuscito a far mettere un’altra volta all’ordine del giorno, non era stata accolta. Ormai, fino alla primavera seguente, non sarebbe stato possibile tentare ancora.
«Maledizione», tuonò Traynor, battendo rabbiosamente entrambi i pugni sul tavolo. «Vorrei poterlo prendere per il collo e stringere fino a quando npn diventa blu!»
Collette, ormai abituata alile escandescenze del suo capo, non fece una piega e si limitò a uscire con discrezione dalla stanza. Traynor si mise a passeggiare avanti e indietro davanti alla scrivania. Non riusciva a capire come mai il consiglio comunale non vedesse più in là del proprio naso. Era evidente che l’ospedale era l’azienda più grande della città ed era altrettanto evidente che aveva un assoluto bisogno di quel garage.
Incapace di continuare a lavorare, afferrò impermeabile, cappello e ombrello e si precipitò fuori. Se non avrebbero potuto avere un garage, avrebbe almeno ispezionato di persona l’illuminazione dei parcheggi; non voleva rischiare altre aggressioni.
Trovò Werner Van Slyke nello stanzino privo di finestre che fungeva da sede dell’ufficio tecnico. Come al solito, si sentiva piuttosto a disagio in sua presenza: quell’uomo era troppo tranquillo, troppo solitario e anche un po’ sciatto. Per di più, lo trovava fisicamente minaccioso, essendo più alto di lui di parecchi centimetri e molto più robusto, con i muscoli ben sviluppati, come se nel tempo Ubero praticasse il sollevamento pesi.
«Voglio vedere l’illuminazione dei parcheggi», gli disse.
«Adesso?» chiese Van Slyke, senza dare nessuna intonazione alla voce, come se non fosse una domanda.
«Ho un po’ di tempo libero», spiegò Traynor, «voglio assicurarmi che sia adeguata.»
Van Slyke si mise addosso un impermeabile giallo e uscì dall’ufficio. Passò da un lampione all’altro, indicandoli senza parlare, e Traynor lo seguì, annuendo davanti a ognuno. Mentre procedevano lungo il parcheggio inferiore, Traynor si chiese che cosa facesse Van Slyke quando non lavorava. Non lo si vedeva mai in giro per la città ed era noto che non partecipava alle attività sociali dell’ospedale.
«Tutto bene a casa?» gli domandò, non sopportando quel silenzio.
«Sì.»
«Non ci sono problemi?»
«No.»
Traynor cercò di fargli dire qualcosa di più di quei laconici monosillabi. «Ti piace di più la vita civile, anziché quella militare?»
L’altro alzò le spalle e cominciò a indicare i lampioni del parcheggio superiore. Sembrava che ce ne fossero abbastanza, ma Traynor pensò di passare di lì una sera in macchina, per verificare com’era quando faceva buio.
Mentre stavano ritornando verso l’ospedale, Traynor domandò ancora: «Li impieghi bene i soldi che guadagni?»
«Sì.»
«Penso che tu stia facendo un buon lavoro qui all’ospedale. Sono orgoglioso di te.»
Van Slyke non reagì e Traynor, osservando il suo profilo sotto la pioggia, si chiese come facesse a essere così privo di emozioni, rendendosi conto di non averlo mai capito, nemmeno quando era piccolo. A volte gli riusciva difficile credere che fossero parenti, eppure Werner era il suo unico nipote, il figlio della sua sorella ormai defunta.
Quando raggiunsero il gruppo di alberi che separava i due parcheggi, Traynor si fermò. «Come mai il sentiero non è illuminato?» domandò.
«Nessuno ha detto di illuminare il sentiero», rispose l’altro. Era la prima frase vera e oropria che diceva e Traynor ne fu quasi compiaciuto.
«Penso che un lampione o possano bastare», gli disse e Van Slyke annuì.
Quando se ne andò, Traynor provò un certo sollievo. Si era sempre sentito in colpa per il senso di estraneità che provava nei confronti di quel suo parente, ma Werner era un enigma. D’altronde, considerati i genitori che aveva, non ci si poteva aspettare nient’altro di diverso. La sorella di Traynor, nonostante si chiamasse Sunny, non aveva nulla di solare: era tranquilla e riservata e aveva sofferto di depressione per quasi tutta la vita. Aveva sposato il dottor Werner Van Slyke pur sapendo che era un ubriacone e, come se non bastasse, si era suicidata.
Traynor aveva proposto al nipote di entrare a lavorare all’ospedale e il suo addestramento in marina come motorista si era rivelato utile.
Читать дальше